
Alla ricerca dell’identità europea. Strumenti concettuali, storia e un dossier didattico
Abstract
Individuazione dei molteplici elementi storico-culturali che, dall’antica Grecia al XX secolo, hanno contribuito a caratterizzare l’Europa; decostruzione di alcuni luoghi comuni in merito alla credenza di una supposta “essenza”, fissa e immutabile, dell’Europa; riflessione multidisciplinare sulla complessa tematica.
Destinazione didattica
Il dossier sulla identità europea evidenzia la complessità e problematicità di un tema al centro di un vivace dibattito che ha visto impegnati storici, sociologi, filosofi, studiosi di scienze sociali, personalità del mondo politico e istituzionale.
Fatte alcune preliminari precisazioni sui concetti di “identità”, “radici”, “tradizioni”, che a dispetto del loro uso comune appaiono alquanto problematici e forieri di possibili effetti distorsivi e implicite ideologie, il dossier ripercorre, per grandi linee, la storia del concetto di Europa, mettendo in luce gli elementi che nel corso dei secoli hanno contribuito a caratterizzarne la fisionomia e le peculiarità, non certo riducibili a qualche sommaria e astorica formula.
Il dossier è destinato agli studenti della scuola superiore, con particolare riferimento ai discenti del quarto e quinto anno del ciclo di studi, e presuppone la conoscenza di base degli eventi della storia europea, dall’impero romano all’età contemporanea. Si presta come strumento didattico per il docente di storia e filosofia, materie letterarie, pedagogia, scienze sociali, diritto e nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza.
Il problema
In cosa consiste l’identità europea? Quale la sua essenza? In cosa individuare il suo nucleo costitutivo? Simili quesiti non sono di agevole soluzione, come dimostra l’articolato dibattito sviluppatosi sul tema ad opera di storici, sociologi, filosofi e studiosi di scienze sociali. Ad evidenziare la complessità e problematicità dell’argomento può essere citato questo passaggio del Rapporto 1992 della Commissione europea:
il termine “Europa” non è ufficialmente definito. Esso combina elementi geografici, storici e culturali che tutti insieme hanno contribuito all’identità europea. L’esperienza condivisa della prossimità, idee, valori e interazione storica, non può essere condensata in una semplice formula, ed è soggetta a revisione da parte di ogni generazione che segue. La Commissione crede che non sia possibile, né sia opportuno stabilire le nuove frontiere dell’Unione europea, i cui contorni saranno disegnati lungo gli anni a venire.
Mito e geografia
Cominciamo con l’affrontare la questione geografica. Dove inizia e dove finisce l’Europa? Come stabilirne estensione e confini? Donna dal volto molto ampio e bello, secondo una delle tante etimologie proposte, e al centro di diverse narrazioni mitologiche, Europa sarebbe stata rapita da Zeus, che assunte le sembianze di un toro bianco l’avrebbe issata in groppa e condotta sull’isola di Creta, ove la giovane fanciulla, ingravidata dal signore degli dei, avrebbe dato alla luce Minosse – quello del labirinto – Radamante e Sarpedone, trio destinato a ricoprire il ruolo di giudici nel mondo dell’al di là.
Passando dal mito alla geografia, l’estensione dell’Europa fu una questione tutt’altro che risolta per i dotti dell’antica Grecia. Erodoto (V sec. a.C.), ragionando sulla tripartizione del globo – Europa, Asia e Libia (ovvero Africa) – propugnata dai suoi contemporanei, ammetteva di non riuscire a comprendere “per quale ragione alla terra, che è una, si diano tre distinte denominazioni, prese da nomi di donna” e perché si siano stabiliti certi confini piuttosto che altri. Problema che sembrò avviarsi a soluzione quando l’esegetica cristiana venne a legittimare la concezione geografica pagana: il capitolo IX della Genesi, con il racconto dei figli di Noé – Sem, Cam e Iafet – da cui sarebbero discese tutte le genti del mondo dopo il diluvio universale, ben si prestava a sanzionare la tripartizione continentale.
Alquanto problematico, già nel mondo antico e poi ancor più nell’era volgare, risultava stabilire l’esatto confine orientale dell’Europa (il fiume Don?; la catena degli Urali?; il limite espansivo della cristianità non ortodossa?; la cortina di ferro della Guerra fredda?) che, nel corso della storia, sarebbe andato soggetto ad arretramenti ed avanzamenti, a dimostrazione di come fossero i fattori politici e ideologici, e non mere valutazioni geografiche e climatiche, a incidere sulla definizione dell’estensione europea. Ritenuta estranea alla civiltà europea e alla cristianità occidentale per la sua adesione alla confessione ortodossa e per il carattere “dispotico” del suo sistema politico, la Russia solo in periodi limitati della sua storia, connotati dall’opera riformatrice di sovrani illuminati come Pietro il Grande e Caterina, sarà ritenuta degna di venir annoverata tra le nazioni europee, e assisterà, nel corso dell’Ottocento, ai dibattiti tra “zapadnik”, fautori dell’occidentalizzazione dei costumi, e slavofili, come Nikolaj Danilevskij, sostenitori della peculiarità e superiorità dei valori russi rispetto a quelli europei.
E non possiamo tralasciare, in questa breve rassegna, le posizioni del geografo francese Eduard Suess, coniatore nel 1885 del termine “Eurasia”, il quale invitava a considerare l’Europa come occidentale penisola di un unico, immenso, indistinto continente.
Gli strumenti concettuali dell’identità
Se dalle mappe geografiche passiamo a quelle concettuali, la situazione sembra non meno intricata. In cosa individuare l’autentica identità dell’Europa? Ove rinvenirne le radici? Come non smarrirne memoria e tradizione? Prima di procedere oltre è opportuno riflettere, seppur brevemente, su concetti quali “identità”, “radici”, “tradizione” che a profusione vengono impiegati nei talk-show televisivi, negli articoli dei quotidiani, sui social e utilizzati, quasi sempre, in contesti argomentativi connotati da un incombente senso di minaccia e pericolo.
L’antropologo Francesco Remotti ha messo in guardia contro l’ossessione identitaria, per citare il titolo di un suo saggio, che caratterizza un’epoca come la nostra in cui, a fronte di processi e mutamenti di portata globale, si è portati a cercare una rassicurazione psicologica in una sorta di baricentro permanente che, conferitoci alla nascita, dovrebbe accompagnarci sino alla tomba, “proteggendoci” da ogni rischio di contatto e scalfitura: un’illusione e un artifizio, che non tiene conto della realtà dell’esistenza e delle molteplici esperienze che concorrono a formare, giorno dopo giorno, la poliedrica personalità di un individuo, non certo riducibile a rigidi schematismi e a un elenco di fattori sommario e definito una volta per tutte (doc.: Remotti). Amartya Sen, premio Nobel per l’economia, ha illustrato gli aspetti più nefasti di questo concetto, sottolineando che “l’identità può anche uccidere, e uccidere con passione”.
Il concetto di identità richiama quello di radici – “da preservare e difendere”, secondo un mantra ricorrente -, metafora su cui invita a riflettere il classicista Maurizio Bettini, perché “le immagini non sono oggetti neutri, anzi, molto spesso hanno la capacità di condizionare fortemente la nostra percezione della realtà”. Cultura, osserva Bettini, è sinonimo di dinamismo, ma la metafora arboricola spinge in tutt’altra direzione: le piante consumano l’intero ciclo della loro esistenza laddove hanno messo radici. Non così l’essere umano che, dal cuore dell’Africa, è giunto a popolare i vari continenti, riuscendo a dominare l’ambiente e a dar vita, con intelligenza e creatività, a molteplici culture evolutesi nel tempo.
Considerazioni analoghe si possono fare anche a proposito delle “tradizioni”, che, lungi dal costituire un blocco omogeneo e immutabile, risultano essere il frutto di un accurato processo di selezione, interpretazione, adattamento, trasmissione, apprendimento, se non addirittura di vera e propria invenzione, come ci hanno spiegato Eric J. Hobsbawm, Terence Ranger, Benedict Anderson: una tradizione, infatti, è tale nella misura in cui si è scelto, e si continua a scegliere, che lo sia (doc.: Bettini 1, 2).
Identità e genetica
Proviamo a chiederci chi siano i veri europei, pienamente legittimati a far parte dell’Europa e a discettare sul relativo patrimonio identitario. La risposta di Guido Barbujani, di professione genetista, potrebbe sorprendere: “volete vedere che faccia ha un immigrato africano? Guardatevi allo specchio. Volete vedere che faccia ha un vero europeo, senza se e senza ma? Troppo tardi, bisognava pensarci trentamila anni fa”.
E già, perché gli europei “autentici”, quelli originari, non ci sono più, essendo stati spazzati via da immigrati più evoluti e, a conti fatti, prepotenti: affacciatosi 40.000 anni fa ai confini sudorientali dell’Europa, Homo sapiens, dal quale tutti noi, esseri umani del pianeta Terra, discendiamo, nel giro di qualche millennio divenne il signore incontrastato del continente, scacciando – e portando all’estinzione, secondo processi non ancora del tutto chiariti dagli scienziati – l’uomo di Neandertal, ovvero colui che da circa 300.000 anni aveva popolato l’intero territorio europeo.
Noi europei, osserva Barbujani, ci saremmo comportati come “immigrati invadenti che alla fine, in un modo o nell’altro, hanno sfrattato i padroni di casa” (doc.: Barbujani 1, 2).
Anacronistiche ricostruzioni e filiazioni inverse: quando sono i figli a generare i padri
Con un briciolo di umiltà in più, in quanto discendenti da “migranti soverchianti”, irrispettosi dei diritti (e delle vite?) degli indigeni, proviamo a individuare il nucleo portante dell’essere europei, con l’avvertenza di non indulgere in ricostruzioni storiche viziate da prospettive teleologiche e letture imperniate su processualità di stampo deterministico, come se, per un imperscrutabile disegno provvidenziale, il corso degli eventi avesse dovuto necessariamente sfociare nel processo di unificazione europea.
Chiunque si accosti alla storia europea dall’antichità ad oggi avrà chiara consapevolezza del mosaico di popoli ed etnie, della pluralità di lingue, religioni e culture che hanno contrassegnato le vicende del continente. Alla luce di tale intreccio, come ha ben dimostrato il medievalista Patrick J. Geary, risulta del tutto priva di fondamento ogni teoria che, postulando una netta ed esclusiva coincidenza tra popolo e territorio, faccia risalire al Medioevo le origini delle nazioni europee, in quanto “la vera natura dei popoli europei nel corso del primo millennio era assai più fluida, complessa e dinamica di quanto immaginino i moderni nazionalisti” e la loro vicenda, nella Tarda Antichità e nell’Alto Medioevo, non è stata certo “la storia di un momento originario, bensì quella di un processo ininterrotto, intrisa dei miasmi del nazionalismo etnico”.
Anacronismi e letture ideologicamente orientate, secondo Geary, hanno “trasformato la nostra visione del passato in una discarica di rifiuti tossici” insinuatisi “nei recessi più reconditi della coscienza popolare”, esiziale fenomeno cui gli storici devono far fronte confutando le menzogne e ripristinando la verità.
Analoga decostruzione della supposta “naturalità” delle nazioni è operata, prendendo in esame i secoli XVII e XVIII, da Anne-Marie Thiesse, che ha ricostruito i processi mediante i quali un’élite intellettuale si è adoperata con passione per creare un’identità nazionale e plasmare a fondo l’immaginario collettivo: “la vera nascita di una nazione è il momento in cui un pugno di individui dichiara che essa esiste e cerca di dimostrarlo”. Una pluralità di elementi, che vanno da una rilettura “ad hoc” della storia all’esaltazione di eroi prototipi, dalla creazione di inni e bandiere alla “riscoperta” del patrimonio folcloristico, dalla lingua (talora codificata a tavolino) all’esaltazione del paesaggio, concorrono alla creazione collettiva dell’identità e se è vero che “la nazione nasce da un postulato o da un’invenzione” lo è ancor di più che “essa vive solo per l’adesione collettiva a questa finzione”. Una filiazione inversa, per cui sono i figli ad aver generato i padri e non viceversa, un sostanziale artificio, dimostratosi però in grado di attecchire come nessun altro fenomeno storico e di “contagiare” popoli e culture extraeuropee.
Alla ricerca della (delle?) identità
La cultura greca, con il suo sapere filosofico e la concezione della cittadinanza democratica, rappresenta certamente uno dei fondamentali tasselli dell’identità europea, che sempre ha fatto tesoro del suo retaggio, talora idealizzato (si pensi all’Umanesimo o al settecentesco movimento del neoclassicismo) e posto come canone estetico di riferimento. Anche la civiltà romana, in grado di creare un impero che dal vallo di Adriano si estendeva al Reno e al Danubio, comprendendo tutti i territori affacciantisi sul mar Mediterraneo, ha esercitato una forte influenza sulla storia europea per molteplici fattori, tra i quali risalta il diritto romano, che sarebbe divenuto la struttura giuridica di riferimento in Occidente, a partire dall’apogeo del Medioevo.
Nonostante il potente influsso culturale esercitato sulla futura storia del continente, va notato come l’età antica non conosca il concetto di Europa e centrale, in essa, appaia il Mediterraneo, che, lungi dal separare le varie sponde del bacino marino, funse da trafficata via di comunicazione per traffici e scambi. E’ con il Medioevo, era in cui la terraferma sottrasse la centralità al mare, e soprattutto al principio dell’età moderna che prese progressivamente forma l’idea di Europa, connotata peraltro in senso culturale e non politico. Carlo Magno, artefice di un nuovo impero in grado di conquistare buona parte dei territori del continente nel segno della cristianità, fu significativamente chiamato dai contemporanei “pater Europae” (doc.: Rossi 2). Tuttavia, secondo la maggior parte degli studiosi, è solo con l’età moderna e con la costruzione della comunità internazionale degli studiosi (chierici o umanisti) che si cominciò a definire una società e una regione “europee”.
Identità e alterità: una stringente dialettica
Per molti secoli Europa sarebbe divenuta sinonimo di difesa della civiltà cristiana e contrasto all’Islam, la cui polarità negativa avrebbe giocato un ruolo decisivo nel favorire e rafforzare un’identità collettiva “in contrapposizione a”. Una dinamica, quella identitaria per via negativa, all’opera peraltro già nel mondo greco, sprezzante nei confronti dei “barbari”, ovvero delle genti non greche e, in quanto tali, considerate inferiori.
Non attribuibile soltanto ed esclusivamente ai popoli dell’Europa cristiana – il nome di molte tribù sparse nei diversi continenti significa “uomini”, a indicare la radicale alterità di chiunque non appartenga al gruppo -, una simile dinamica etnocentrica si è rivelata oltremodo funzionale alla legittimazione del dominio e della sopraffazione, alla coesione e al ricompattamento sociale a fronte di minacce, reali o presunte, avvertite come potenzialmente sovvertitrici dell’ordine costituito e dell’universo valoriale: da Montaigne sino a Paul Ricoeur, Tzvetan Todorov, Edward W. Said, Julia Kristeva, a lungo si è riflettuto sui meccanismi psicologici soggiacenti a tale processo identitario (doc.: Mikkeli 1, 2).
Una definizione dialettica di identità
Cultura greca, diritto romano, Europa carolingia, religione cristiana, costumi del mondo romano e germanico: ad emergere è l’immagine di una civiltà in fieri, costituita da molteplici elementi strettamente intrecciati tra loro: si pensi, per fare un solo esempio, alla Chiesa, che costituirà la propria struttura organizzativa basandosi sul modello imperiale romano, e al diritto canonico, i cui ordinamenti ricalcheranno gli schemi del diritto romano. “Le varie ‘radici’ dell’Europa – ha sottolineato Pietro Rossi – possono certamente essere oggetto di una distinzione analitica; ma nella realtà è inconcepibile separarle l’una dall’altra” (doc.: Rossi 3).
In età moderna si farà strada quella modalità di pensiero e quell’approccio alla realtà del mondo che possiamo definire razionalismo. Venuta meno la deferenza nei confronti dell’autorità degli antichi e di un testo biblico da sottoporre invece a un’adeguata ermeneutica, l’Europa, a partire da Cartesio e Galileo, iniziò a percorrere il cammino che l’avrebbe condotta all’uso critico della ragione, ripudio delle credenze non verificate, metodo sperimentale, ricerca scientifica, utilizzo della tecnologia applicata, valorizzazione dell’individuo e difesa dei suoi diritti, lotta per la libertà.
Un’uscita dell’uomo dallo stato di minorità, per citare il famoso passo di Kant, che le idee illuministe avrebbero promosso, un itinerario nel segno della modernità e del weberiano “disincantamento del mondo” che negli ultimi due secoli avrebbe connotato, in maniera peculiare, la civiltà europea.
Scienza, tecnologia, capitalismo industriale di mercato, stato nazionale, cristianesimo, per seguire il ragionamento di Alberto Martinelli (doc.: Cavalli, Martinelli), sono le caratteristiche salienti e distintive di una identità europea sintetizzabile “nella costante tensione tra razionalismo e individualismo/soggettività, considerati come principi opposti e complementari allo stesso tempo”, esprimenti la costante dialettica tra libertà individuale e organizzazione sociale: non “radici di due concezioni alternative della modernità […] ma piuttosto degli elementi della stessa sindrome culturale e istituzionale”. La peculiarità europea fu dovuta non necessariamente a una sorta di eccezionale modello di sviluppo, come voleva Max Weber – la Cina per secoli sopravanzò di gran lunga l’Europa dal punto di vista economico, scientifico e tecnologico -, quanto piuttosto a una “maggiore propensione – per citare ancora Martinelli – a coniugare scoperte scientifiche, invenzioni e innovazioni tecnologiche sotto la pressione costante sia della guerra sia della concorrenza commerciale”.
Non un presupposto e una speciale attitudine originaria, ma il risultato di un intreccio di elementi, circostanze e processi articolati.
Alla luce di queste considerazioni e delle analisi proposte da autori quali Christopher Dawson, Lucien Febvre, Karl Jaspers, Federico Chabod, emerge un’Europa come “regno delle differenze”, terra dalle molteplici identità e dai complessi intrecci, il cui tratto distintivo può venir individuato nella “dialettica costante tra Weltanschauungen diverse e spesso in conflitto e lo sviluppo di una mente critica che rimette continuamente in discussione teorie e credenze egemoniche e costruisce la base del pensiero scientifico europeo” (Martinelli). Un esito frutto di una storia millenaria, segnata da conflitti, contraddizioni, cesure, che ha plasmato a fondo, al di là forse della stessa consapevolezza dei singoli, i modi di vivere e sentire degli europei: lo spagnolo Josè Ortega y Gasset, nel 1930, faceva osservare che “se oggi facessimo un bilancio del nostro contenuto mentale – opinioni, norme, desideri, presunzioni – noteremmo che la maggior parte di tutto questo non viene al francese dalla sua Francia, né allo spagnolo dalla sua Spagna, ma dal comune fondo europeo. Oggi, effettivamente, pesa molto di più in ciascuno di noi ciò che egli ha di europeo, anziché la sua porzione differenziale di francese, spagnolo, ecc.”.
Identità quindi non come forma perenne, idea iperuranica, immutabile essenza ma quale effetto di un lungo percorso, tutt’altro che piano e lineare, determinato dalle vicende storiche, dalle scelte degli uomini e non certo da un fato sovrano. “L’identità europea – ha affermato Pietro Rossi -, se esiste, non va cercata in un passato idealizzato o in un futuro sperato, ma dev’essere ricostruita nel suo processo di formazione e correlata alle diverse epoche della sua cultura”.
Da Dante al trattato di Maastricht: costruzione e decostruzione dell’identità europea
Realtà fondata, pur non saldamente, su un ethos comune e su una storia che, nel bene e nel male, ha plasmato la fisionomia del continente, l’Europa è stata, e continua ad esserlo, anche una visione e un progetto, che nel corso dei secoli è stato declinato, secondo differenti modalità, sensibilità e ideologie, da sovrani, intellettuali, filosofi.
Dalle tesi di Dante nel De Monarchia alla proposta avanzata nel XV secolo dal re di Boemia Georg von Podebrad, dall’umanesimo universale di Emeric Crucé, attivo nella prima metà del Seicento, al piano del duca di Sully, ministro ugonotto di Enrico IV, dal trattato dell’Abbé de Saint-Pierre per far regnare la pace perpetua in Europa alle posizioni di Mazzini e Cattaneo, per giungere infine al movimento paneuropeista del conte Richard Coudenhove-Kalergi, fautore negli anni Venti del secolo XX dell’avvento degli Stati Uniti d’Europa, ad Altiero Spinelli e Jean Monnet, la storia europea ha registrato un fervore intellettuale e una visionarietà prospettica improntate al sogno di alleanze generali che, tramite l’istituzione di organismi e tribunali sovranazionali, fossero in grado di dirimere le contese tra stati, impedire il ricorso alle armi e garantire pace e prosperità del continente. Nobili aspirazioni che testimoniano una volontà e un desiderio, avvertito almeno in parte del ceto intellettuale europeo, di una qualche forma di unione che, senza negare realtà e identità nazionali (per quanto labili, prima dell’Ottocento), potesse superare le logiche della ragion di Stato e tenere a freno le mire egemoniche di questa o quella potenza.
Frutto del trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993, l’Unione europea rappresenta allo stato attuale, pur con tutte le fragilità, lacune e problemi che conosciamo, la più significativa istituzione realizzata dai popoli del continente nell’ambito della cooperazione politica, economica, giuridica, sociale, culturale.
Associata, di primo acchito, a defatiganti negoziati, summit, diktat finanziari, minuziose direttive sulla dimensione degli ortaggi o sulla stagionatura dei formaggi, sulle apparecchiature elettroniche o sullo smaltimento dei rifiuti, l’Unione europea rischia di essere percepita dall’opinione pubblica come un burocratico carrozzone guidato da tecnocrati e banchieri, ben più attenti a cifre e bilanci che non alle concrete condizioni di vita di centinaia di milioni di comuni cittadini. Nell’aver perso, perlomeno in parte, la capacità di porsi quale orizzonte ideale e vitale opportunità per affrontare quelle sfide globali al cui cospetto sempre più impotente si sta rivelando la sovranità dei singoli stati, la Ue non è ugualmente in grado di competere, quanto a passioni e processi identitari, con le singole nazionalità. Il politologo francese Raymond Aron negli anni Settanta sosteneva che “non esistono animali della specie ‘cittadini europei’. Esistono solo cittadini francesi, tedeschi, italiani”, mentre lo studioso del nazionalismo Anthony D. Smith, nell’osservare negli anni Novanta che “le identificazioni nazionali posseggono vantaggi precisi sull’idea di un’identità europea unitaria”, risultando “vivide, accessibili, ben piantate, popolari e ancora ampiamente credute, almeno in senso lato”, affermava che “senza memorie e significati condivisi, senza simboli e miti comuni, senza corone e cerimonie e monumenti […], chi si potrà dire europeo nel fondo del proprio cuore, e chi sarà disposto a sacrificare se stesso per un ideale così astratto?”.
Domande aperte
Come irrobustire un senso di identità fondato su un’unità all’insegna della diversità? Come evitare il rischio insito nelle posizioni di chi, rivendicando le radici ebraico-cristiane dell’Europa e la richiesta (non accolta) di una loro citazione nel preambolo della Carta costituzionale europea, peraltro poi non ratificata, finisce col vagheggiare il ritorno a una società organica in cui la religione svolgeva una funzione normativa, cui il potere temporale doveva conformarsi? (doc.: Rossi 1) Come affrontare le sfide della società multietnica, senza transigere dai grandi ideali della Rivoluzione francese e dai principi cardine delle moderne democrazie? Come tener ferma la difesa dei principi cui si ispira e sui quali si fonda l’Unione europea, senza per questo essere preda di ossessioni identitarie, sindromi mixofobiche, pulsioni xenofobe e razziste? Come rispondere alle sirene “sovraniste”, agli euroscetticismi e a quei populismi anti-Ue, ai quali la Brexit sembra aver conferito ulteriore vigore, appeal e visibilità mediatica? Come sentirsi a pieno titolo cittadini europei senza che questa identificazione vada a confliggere con il sentimento di appartenenza nazionale o con un ancor più ampio afflato cosmopolitico? (doc.: Todorov 1, 2)
Nessuno ha la risposta in tasca e una sana diffidenza va nutrita nei confronti di chiunque sbandieri facili ricette in grado di risolvere problemi di ardua complessità. Quel che ci sentiamo di dire, come studiosi e insegnanti, è che solo un’accurata analisi storica, capace di ripercorrere i molteplici elementi ed intrecci grazie ai quali si è via via delineato nella sua peculiarità ciò che oggi chiamiamo Europa e di svellere al tempo stesso le false convinzioni e le tesi prive di fondatezza storiografica, può fornire un contributo alla formazione civile e morale delle nuove generazioni.
Bibliografia
- B. Anderson, Comunità immaginate. Origini e fortuna dei nazionalismi, Roma, Manifestolibri, 2009
- G. Barbujani, Europei senza se e senza ma, Milano, Bompiani, 2008
- M. Bettini, Contro le radici. Tradizione, identità, memoria, Bologna, il Mulino, 2011
- A. Cavalli, A. Martinelli, La società europea, Bologna, il Mulino, 2015
- F. Chabod, Storia dell’idea di Europa, Bari, Laterza, 1961
- L. Febvre, L’Europa. Storia di una civiltà, Roma, Donzelli, 1999
- P.J. Geary, Il mito delle nazioni. Le origini medievali dell’Europa, Roma, Carocci, 2009
- E.J. Hobsbawm, T. Ranger (a cura di), L’invenzione della tradizione, Torino, Einaudi, 2002
- H. Mikkeli, Europa. Storia di un’idea e di un’identità, Bologna, il Mulino, 2002
- U. Morelli, Storia dell’integrazione europea, Milano, Guerini e Associati, 2011
- D. Pasquinucci, L. Verzichelli, Contro l’Europa? I diversi scetticismi verso l’integrazione europea, Bologna, il Mulino, 2016
- F. Remotti, L’ossessione identitaria, Roma-Bari, Laterza, 2010
- P. Rossi, L’identità dell’Europa, Bologna, il Mulino, 2007
- A. Sen, Identità e violenza, Roma-Bari, Laterza, 2008
- D. Smith, Le origini etniche delle nazioni, Bologna, il Mulino, 1998
- A.M. Thiesse, La creazione delle identità nazionali in Europa, Bologna, il Mulino, 2001
- T. Todorov, La paura dei barbari. Oltre lo scontro delle civiltà, Milano, Garzanti, 2009
Sitografia
- V. Cotesta, Paradigmi per lo studio dell’identità europea, in “Quaderni di sociologia”, 55, 2011 (https://qds.revues.org/642)
- A. Martinelli, L’identità europea, in “Quaderni di sociologia”, 55, 2011 (https://qds.revues.org/645)
- A. Brusa, Un’Europa da Nobel?, in “Historia ludens”, 5 novembre 2012 (http://www.historialudens.it/component/content/article/31-formazione-attiva/la-formazione-professionale/15-un-europa-da-nobel.html)

By HajjiBaba – Own work, CC BY-SA 4.0, Link
Dossier / Alla ricerca dell’identità europea

Guido Barbujani ha lavorato nelle Università di Padova, Bologna, State of New York, Londra e attualmente insegna genetica all’Università di Ferrara. Tra i suoi libri L’invenzione delle razze (2006), Sono razzista ma sto cercando di smettere (2008, con P. Cheli), Gli africani siamo noi (2016).
- doc. Barbujani 1 (pp. 13-15)
Con uno stile brillante e presentando le più recenti acquisizioni scientifiche, il genetista Guido Barbujani invita il lettore a mettere in discussione talune presunte certezze. Le risposte alle domande su chi siano i “veri” europei e quali fattezze presenti un immigrato africano risultano spiazzanti e offrono lo spunto per un percorso didattico teso al superamento di consolidati pregiudizi.
“Io lo so chi è il vero europeo, ho pensato: è l’uomo di Neandertal. Per quasi trecentomila anni ha occupato, da solo e stabilmente, l’Europa, e anche un pezzetto d’Asia. Aveva uno scheletro diverso dal nostro, tanto che i paleontologi, quando ne scoprono uno, lo identificano senza problemi. Era un po’ più basso di noi, ben piantato, con un grande naso, la fronte bassina, e niente mento. Cacciava in gruppo, mangiava quasi solo carne, non teneva molto in ordine le sue caverne. Si pensa che il suo cervello, non più piccolo del nostro, sapesse elaborare anche idee complicate, visto che pare seppellisse i suoi morti, forse, e forse addirittura costruisse flauti. Forse aveva una sua idea dell’aldilà, se, come alcuni sostengono, in certe sepolture ha deposto dei fiori.
Da qualche anno, con le nuove tecniche di studio del DNA, abbiamo capito che i Neandertal avevano caratteristiche genetiche ben distinte da quelle di qualsiasi europeo moderno. Non erano solo fisicamente un po’ più bassi e più grossi di noi, avevano anche geni ben distinti dai nostri. In altre parole: erano creature quasi come noi, intellettualmente complesse, un prodotto molto sofisticato dell’evoluzione, ma non erano noi […] Fra cento e duecentomila anni fa, mentre l’Europa era popolata dai Neandertal, gente come noi, con un cranio come il nostro e lo scheletro pure, se ne stava dalle parti dell’Etiopia. Hanno, cioè abbiamo, fatto un primo tentativo di uscirne centomila anni fa e non è andata bene. Sono arrivati in Palestina, ma tutto lascia credere che non si siano spinti oltre, e anzi, dopo un po’ si siano estinti […] I nostri antenati africani però non si sono persi d’animo. Ci hanno riprovato, più volte probabilmente […] Alla fine, a furia di insistere, sono riusciti a sbucare di nuovo in Palestina, e forse anche a passare direttamente dal Corno d’Africa alla penisola araba. Da lì, colonizzare tutta la Terra è stato solo questione di tempo. Quarantamila anni fa si sono, cioè ci siamo, finalmente affacciati alle frontiere sudorientali dell’Europa. Era fatta: nel giro di qualche millennio sono restati solo loro, cioè noi, mentre i Neandertal sono scomparsi. L’Europa è tutta nostra da meno di trentamila anni: davvero poco per poterci dare delle arie, rispetto ai quasi trecentomila anni dei Neandertal.
Nessuno può dire con sicurezza cosa sia successo nel periodo in cui i Neandertal e i nostri antenati si dividevano lo stesso continente, a volte così vicini da potersi guardare dai versanti opposti di una valle […] Però c’è poco da fare: nella migliore delle ipotesi i Neandertaliani si sono estinti da soli poco dopo averci incontrati, nella peggiore li abbiamo sterminati noi. In un modo o nell’altro, noi siamo una delle principali cause, forse la causa principale, della loro scomparsa, e siamo gli ultimi venuti, gli immigrati: immigrati invadenti che alla fine, in un modo o nell’altro, hanno sfrattato i padroni di casa […] gli europei di una volta, quelli veri, non ci sono più […] fino a trentamila anni fa chi fossero i veri europei era chiaro, oggi è difficile dirlo, sappiamo molto meglio chi sono i veri africani perché siamo noi.
Volete vedere che faccia ha un immigrato africano? Guardatevi allo specchio. Volete vedere che faccia ha un vero europeo, senza se e senza ma? Troppo tardi, bisognava pensarci trentamila anni fa”.
- doc. Barbujani 2 (pp. 266-67)
Avendo dimostrato, con gli strumenti della genetica, come i “veri” europei si siano estinti, per ragioni non ancora chiarite, circa 30.000 anni fa, l’autore mette in luce la pluralità degli elementi che, nel corso dei secoli, hanno contribuito alla storia e cultura dell’Europa, evidenziando l’impossibilità di ridurne la complessa identità in una univoca e invariabile formula o, peggio ancora, in una peculiarità biologica.
“Gli europei senza se e senza ma non ci sono più da almeno 30 mila anni. Le radici dell’Europa attuale sono tante e hanno a che vedere con la cultura greca classica, con il cristianesimo, con l’impero romano, ma anche con l’incorporazione nell’impero romano di popoli e culture provenienti dai quattro punti cardinali, e col pensiero filosofico, giuridico e sociale che ha definito il moderno concetto di cittadinanza. Tutto questo è Europa, e non poggia su basi genetiche. Tentare di ridurre l’identità europea a una formula semplice, univoca e invariabile è un’offesa agli europei, prima ancora che agli immigrati che a questa formula sarebbero tenuti ad attenersi.
Il nostro continente in generale, e la regione mediterranea in particolare, sono sempre stati luoghi di transito e di mescolanza fra genti e culture diverse. Dove indirizzare questa mescolanza, quali provvedimenti prendere per governare lo sviluppo futuro, è un problema serio. Lo si potrà affrontare solo usando gli strumenti adatti, che non sono quelli della genetica o dell’antropologia. La scienza dimostra solo, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il diritto di appartenere a questa Europa non può derivare dalle nostre radici biologiche, superficiali ed estese per chiunque come abbiamo visto, indipendentemente dal passaporto che tiene nel taschino. Chi saranno gli europei del futuro e come vivranno dipende invece da un complesso negoziato su come amalgamare o accostare culture diverse e diversamente fornite di potere: su come farlo oggi in un insieme di stati democratici in cui affiora la tentazione di rinunciare a un po’ di libertà in cambio di un’ipotetica sicurezza, e su come farlo domani, chissà, in un unico state federale”.
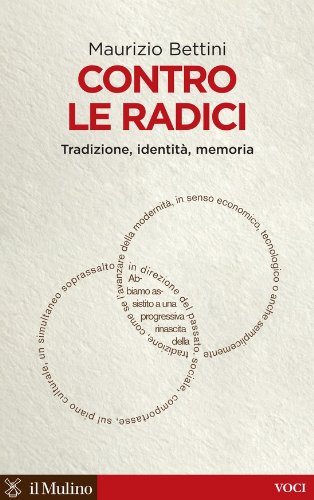
Maurizio Bettini insegna filologia classica all’università di Siena, dove dirige il Centro Antropologia e Mondo Antico. Tra i suoi libri Elogio del politeismo. Quello che possiamo imparare dalle religioni antiche (2014), Dèi e uomini nella città. Antropologia, religione e cultura nella Roma antica (2015), Con i romani (a cura di, con W.M. Short, 2014), A che servono i Greci e i Romani? (2017).
- doc. Bettini 1 (pp. 47-51)
Classicista, fautore di un approccio antropologico alla cultura greca e romana, Bettini nell’analizzare taluni concetti e metafore comunemente usate nel discorso pubblico evidenzia come tali termini celino e veicolino immagini e significati in grado di influenzare fortemente il nostro modo di percepire la realtà e orientarci in essa. Lungi dall’essere asettico e neutrale, il linguaggio rivela una portata ideologica di cui raramente si è consapevoli.
“La tradizione, infatti, non è qualcosa che viene dalla terra, che si mangia o che si respira, e neppure qualcosa che discende verso di noi da determinate alture: essa è prima di tutto qualcosa che si costruisce e che si apprende. Senza un continuo lavoro di apprendimento qualsiasi tradizione si spegne in breve tempo […].
Il fatto è che la tradizione è qualcosa che deriva in primo luogo da precise scelte di acculturazione e di apprendimento, come qualsiasi altro tipo di conoscenza […] La forza di una tradizione non deriva tanto dal fatto che essa viene dal passato, come normalmente si crede o ci viene detto, ma dal fatto che si continua a insegnarne i contenuti nel presente. O addirittura dal fatto che si comincia a insegnarne i contenuti nel presente, come avviene nel caso delle tradizioni inventate. Nella versione semplificata di questo concetto, una tradizione viene ritenuta tanto più solida quanto più è antica, ovverosia, per restare in metafora, quanto più le sue radici affondano nel passato. Non è esattamente così. Una tradizione è tanto più solida quanto più lo è l’intelaiatura che la sostiene nel presente – cioè quanto più si continua a ripetere e a insegnare che essa è forte e antica […] La tradizione si studia e si apprende. Come tale, la tradizione come noi la intendiamo si lega indissolubilmente all’esistenza della scrittura […] attraverso la quale il passato viene registrato – che poi si tratti di registrazioni attendibili, sciatte o addirittura false, è naturalmente un altro discorso”.
- doc. Bettini 2 (pp. 83-85)
Il genocidio verificatosi in Ruanda nel 1994, che secondo stime attendibili ha prodotto circa un milione di vittime, può essere considerato l’esito estremo di un processo di contrapposizione identitaria. L’autore evidenzia la natura fittizia di un’identità etnica – Hutu contrapposti a Tutsi – frutto in realtà di decisioni politiche attuate nel 1930 dalla potenza coloniale belga. Una finzione, priva di reali giustificazioni storiche, ma in grado, una volta fatta propria e interiorizzata dai membri della società ruandese, di scatenare uno spaventoso massacro in nome di una “atavica” identità da difendere.
“Quando scoppiarono i primi conflitti fra Hutu e Tutsi, in Ruanda, scoprimmo con sgomento che, in realtà, non si trattava semplicemente di un conflitto a carattere etnico – o meglio tribale, come i media si ostinano a dire quando si tratta di guerre africane. Era molto più complicato di così. Hutu e Tutsi non appartengono infatti a etnie diverse. Parlano la stessa lingua, sono difficilmente distinguibili sul piano somatico e per secoli hanno condiviso le medesime istituzioni politiche […] In questa forma Hutu e Tutsi hanno convissuto per secoli in Ruanda. Furono i missionari e i colonizzatori europei che interpretarono questi due gruppi sociali come due popolazioni differenti. Utilizzando i criteri in uso nell’antropologia ottocentesca – genetica e gerarchica nello stesso tempo -, ai Tutsi pastori «nobili», furono così attribuite origine camitiche: in altre parole, un retaggio biologico e culturale ricollegabile in qualche modo all’Occidente, attraverso la comune discendenza da Noé; mentre degli Hutu si fecero dei rozzi contadini autoctoni […] Hutu e Tutsi erano stati etnicizzati dai belgi, e ora si combattevano come due popoli differenti […] Nel 1930 i coloni belgi realizzarono un censimento, per rilasciare a ogni individuo un documento di identità. Vi si indicava se ciascuno era Tutsi, Hutu o Twa (i pigmei che rappresentano il terzo gruppo del paese). Dato che distinguere somaticamente un Hutu da un Tutsi era difficile […], fu deciso di adottare come criterio etnico discriminante il numero dei bovini posseduti da ciascuno […] Fu così deciso che gli individui maschi che possedevano dieci o più buoi erano da considerare Tutsi; gli altri, quelli che ne avevano in minor numero o non ne avevano alcuno, erano da considerare Hutu. E questo per sempre. Tali carte di identità hanno continuato a esistere, e hanno costituito il mezzo attraverso il quale i militari delle due fazioni in guerra hanno potuto identificare chi era da uccidere e chi era da risparmiare. Tutto questo, sulla base di una tradizione prodotta da altri, ma che la memoria collettiva di Tutsi e Hutu aveva disgraziatamente fatto propria”.

Alessandro Cavalli ha insegnato sociologia all’Università di Pavia, Alberto Martinelli è professore emerito all’Università statale di Milano. Di Cavalli ricordiamo Incontro con la sociologia (2002) e Corso di sociologia (2012, con A. Bagnasco e M. Barbagli), di Martinelli La modernizzazione (2008) e Mal di nazione. Contro la deriva populista (2013).
- doc. Cavalli Martinelli (pp. 32-38; spaziature non presenti nel testo)
Martinelli passa in rassegna gli elementi culturali e istituzionali che hanno contribuito a definire il profilo identitario dell’Europa, sottolineando peraltro come questo patrimonio non debba essere considerato un tutto organico e coerente ma piuttosto il risultato di un lungo processo storico, non privo di contraddizioni, lacerazioni ed effetti negativi. Un’unità raggiunta attraverso la diversità che, pur basandosi su una memoria e valori in buona parte condivisi, ha saputo ispirarsi a un progetto politico futuro.
“La civiltà della modernità è nata nell’Europa occidentale e si è poi estesa alle altri parti d’Europa, alle Americhe e al mondo intero, contribuendo allo sviluppo delle modernità multiple, ovvero delle mutevoli forme culturali e istituzionali che si sono dispiegate nelle diverse regioni del mondo anche in risposta alle sfide, minacce e opportunità derivanti dalle caratteristiche distintive della modernità occidentale. Questi valori e atteggiamenti culturali nutrirono e furono nutriti da una struttura sociale relativamente aperta e autonoma, caratterizzata da una molteplicità di élite, classi, entità etniche, religiose e politiche con confini definiti e in costante ridefinizione, frequenti interazioni fra centro e periferia, un alto grado di mobilità sociale, un sistema legale relativamente indipendente dalla politica e dalla religione e città altamente autonome. […]Iniziamo dalla scienza e dalla tecnologia europee e occidentali, con cui si intende un particolare approccio alla conoscenza della realtà fisica e umana capace di trasformare la natura al fine di soddisfare bisogni individuali e sociali. La profondità delle religioni e delle filosofie indiane e cinesi, la ricchezza del pensiero scientifico e religioso dell’Islam, lo sviluppo delle conoscenze astronomiche in Mesopotamia o nell’America precolombiana sono soltanto alcune prove del fatto che la conoscenza occidentale non è affatto eccezionale. Ciò che in essa è specifico è la sua maggiore propensione a coniugare scoperte scientifiche, invenzioni e innovazioni tecnologiche sotto la pressione costante sia della guerra sia della concorrenza commerciale. Specifica è pure la maggiore capacità di disegnare istituzioni particolarmente adatte alla formazione e alla diffusione delle conoscenze: le università medievali italiane, francesi e spagnole, le accademie scientifiche britanniche e francesi del XVII secolo, le università di ricerca tedesche del XIX secolo, i grandi laboratori di ricerca dell’America contemporanea. […]La seconda innovazione istituzionale è il capitalismo industriale di mercato. Il suo principio guida è la costante ricerca di massimizzazione razionale dell’utilità per competere con successo nel mercato. La combinazione efficiente dei fattori della produzione nell’impresa industriale e lo scambio di beni e servizi nel mercato autoregolato sono le due istituzioni fondamentali dello sviluppo capitalistico […]. Commerci e mercati si sono sviluppati anche negli antichi imperi e in gran parte del mondo non-europeo, ma la particolare combinazione di rivoluzione industriale e mercato autoregolato ha rappresentato una specificità europea, che ha fornito alla crescita capitalistica una forza e un dinamismo senza precedenti. […]La terza componente istituzionale fondamentale dell’identità europea, lo stato nazionale, è collegata in modo più controverso ai valori del razionalismo e dell’individualismo di quanto non lo siano la scienza e la tecnica o il mercato e l’impresa capitalistici. Gli stati nazionali sono l’incarnazione istituzionale dell’autorità politica nella società moderna. Lo stato nazionale è una tipica costruzione europea che è stata esportata con successo nel resto del mondo. […]La democrazia rappresentativa, ovvero un sistema politico composto da funzionari eletti che rappresentano gli interessi e le opinioni dei cittadini in un contesto di governo della legge, che si fonda sulla sovranità popolare e sul consenso dei cittadini, costituisce in effetti un quarto aspetto dell’identità europea e occidentale. La polis greca, la res publica romana, le libere città dell’Italia, della Germania e delle Fiandre nel tardo Medioevo sono stati tutti antecedenti di questa specificità europea. […]Il cristianesimo ha influenzato profondamente la cultura e le istituzioni europee talvolta come fonte di ispirazione, talaltra come termine dialettico. Da una parte, ha contribuito, insieme al diritto romano, allo sviluppo dell’individualismo europeo e occidentale […]. Dall’altra parte, la nozione dell’assenza del limite e la credenza dell’uomo quale artefice del proprio destino, tratti distintivi della mentalità moderna, sono state fortemente contrastate dalla posizione antimodernista della Chiesa cattolica […] Il fattore religioso nell’identità culturale dell’Europa non ha tuttavia comportato una semplice unità indifferenziata, sia perché altre religioni come l’Islam hanno svolto un ruolo rilevante sia per la grande diversità religiosa del cristianesimo stesso, con i suoi numerosi movimenti ereticali, lo scisma tra Chiesa ortodossa e Chiesa cattolica e la Riforma protestante.
Questi elementi culturali e istituzionali di fondo hanno contribuito a definire l’identità dell’Europa […]; non hanno tuttavia formato un insieme coerente, entrando in conflitto gli uni con gli altri […] e non hanno prodotto soltanto esiti positivi ed effetti desiderabili. […] [Bisogna avere] piena consapevolezza che l’identità europea non è solo il portato di un percorso storico comune e di una memoria condivisa, ma è anche la costruzione di un progetto futuro; non consiste nella passiva conservazione di valori passati, ma nella tensione realizzativa verso l’unità politica che richiede un impegno quotidiano dei cittadini e delle istituzioni europee. Il progetto europeo […] può essere definito come il tentativo di conseguire l’unità mediante la diversità, negando la vecchia credenza che tutto ciò che è diverso è anche ostile e rinunciando a costruire l’identità sulla contrapposizione tra «noi» e «lorio». L’identità europea è resa possibile dall’eredità culturale comune che innerva in forme e gradi diversi i vari ethnoi europei, ma può svilupparsi solo mediante la crescita di un demos europeo definito nei termini di un complesso di diritti e doveri condivisi, capace di consolidare i vincoli della cittadinanza entro istituzioni democratiche liberamente scelte”.

Docente dell’Università di Helsinki, Heikki Mikkeli si è occupato di storia della cultura europea e della scienza.
- doc. Mikkeli 1 (pp. 128-30)
L’incontro con l’altro ha spesso giocato un ruolo di primo piano nelle dinamiche identitarie. Attribuire caratteristiche negative, dall’ambito estetico a quello morale e intellettuale, a gruppi umani differenti per colore della pelle, costumi, lingua, religione, è servito a rafforzare la coesione interna, il senso di superiorità di una società sulle altre e a legittimare forme di sopraffazione e dominio. Rivolto inizialmente dai greci ai persiani, “barbaro” (alla lettera: balbuziente, colui che parla un linguaggio incomprensibile) nel corso dei secoli sarebbe divenuto un epiteto profferito nei confronti di chi, per molteplici aspetti, era ritenuto inferiore culturalmente e, in quanto tale, giustamente riducibile in uno stato di servitù o schiavismo.
“Gli antichi greci sottolineavano la loro differenza dai barbari, che per loro erano anzitutto i persiani, coloro che vivevano in Asia. Il termine «barbaro» stava per «borbottante», cioè colui che parla un linguaggio incomprensibile. I barbari erano quindi «altri», una specie di esseri non umani con cui era impossibile comunicare. Nel Medioevo il termine acquisì un secondo significato: barbare erano le genti pagane, cioè non cristiane […] All’inizio dell’era moderna si verificò uno spostamento nella definizione per cui gli europei, invece di identificarsi unicamente nella cristianità, cominciarono ad attribuire sempre più valore ai propri standard morali ed educativi. Questo per esaltare la distinzione fra se stessi e le infime genti barbariche testé scoperte.
La «scoperta» dell’America provocò negli europei un sentimento di perplessità: come considerare infatti i nativi del Nuovo Mondo, chiaramente membri della specie umana ma così radicalmente diversi dagli europei? […] Una risposta al problema fu cercata nella teoria della schiavitù naturale tratta […] dalla Politica di Aristotele. […] Lo schiavo naturale era comunque considerato da Aristotele un essere umano; però un essere la cui mente, per una ragione o per l’altra, era incapace di controllare gli istinti più basilari. Questa gente era sì in grado di comprendere le cose, ma non era nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali e dunque non del tutto capace di decidere sulle questioni che la riguardava. […] Proprio come la condizione di un animale selvaggio non poteva che migliorare con l’addomesticamento, così lo schiavo naturale poteva diventare più umano se gli si fosse consentito di osservare ed imitare i costumi delle genti libere. […]Il termine «barbaro» fu largamente utilizzato nel corso del secolo XVI per indicare le culture indiane. Juan de Matienza, un giurista spagnolo che era stato per un certo periodo in Perù, scriveva nel 1567 che gli indiani in sé sarebbero del tutto sprovvisti di facoltà razionali, però si rivelavano in grado di intendere allo stesso modo degli animali. Nel paragonare gli indiani agli animali egli dice che per essere felici basta loro avere da mangiare e bere”.
- doc. Mikkeli 2 (pp. 132-34)
Riprendendo l’analisi di Tzvetan Todorov (La conquista dell’America, Einaudi, 1992), l’autore invita alla riflessione sulle modalità di categorizzazione e percezione dell’altro e richiama un famoso passo del filosofo Montaigne, che nel XVI secolo metteva in guardia i suoi contemporanei dal rischio dell’etnocentrismo. Una lezione che, a distanza di mezzo millennio, rimane sempre attuale.
“Come ha rilevato Tzvetan Todorov nella sua analisi della «scoperta» dell’America, il 1492 fu per la Spagna un anno di confronto con due tipi di «alterità». Nel momento in cui stavano bandendo gli «altri interni», i mori e gli ebrei, dalla penisola iberica, gli spagnoli scoprivano l’«altro esterno» nel Nuovo Mondo. […] Gli europei alla vigilia del secolo XVI erano convinti di avere una cultura superiore a qualsiasi altra. E questa fede era rafforzata dalla convinzione che le altre culture avrebbero assimilato i costumi europei e si sarebbero convertite al cristianesimo. L’idea della vittoria finale della fede cristiana occupava quindi una posizione centrale per i conquistatori spagnoli.
Fede e sapere non erano tuttavia gli unici fattori in gioco nell’incontro fra europei e americani; infatti questo comprendeva anche un confronto di identità e livelli di identità. Todorov chiarisce i tre assi di localizzazione dell’«altro»:
Prima di tutto, c’è un giudizio di valore […]: l’altro è buono o cattivo, mi piace o non mi piace, o, come era più probabile dire a quell’epoca, egli è un mio uguale o un mio inferiore […] In secondo luogo, c’è un’azione di rapprochement o presa di distanza in relazione all’altro [….]: abbraccio i valori dell’altro, mi identifico con lui; oppure identifico l’altro con me stesso, impongo la mia immagine su di lui; fra la sottomissione all’altro e la sottomissione dell’altro, c’è un terzo termine, che è la neutralità, l’indifferenza. In terzo luogo, io conosco oppure ignoro l’identità dell’altro […]; ovviamente, qui non si dà un assoluto, bensì una gradazione infinita dai più bassi ai più alti stati di conoscenza (Todorov).
[…] Con il maturare del secolo XVI cominciarono a levarsi voci più critiche fra gli europei. Sebbene la conquista dell’America non fosse messa in discussione in quanto tale, le misure oppressive e il trattamento degli indiani da parte degli europei nel Nuovo Mondo cominciarono ad essere censurati. Nella seconda metà del secolo alcuni europei, come lo scettico francese Michel de Montaigne, cominciarono a propendere […] per un relativismo nell’atteggiamento verso le altre culture. Montaigne negli Essais (1580-1588) scrive che «noi chiamiamo barbarie qualsiasi cosa sia contraria alle nostre abitudini. Insomma, sembra proprio che non abbiamo altro criterio di verità e ragione che il genere e il tipo di opzioni e costumi vigenti nella terra dove noi viviamo». Queste idee tuttavia non alteravano l’opinione prevalente della superiorità degli europei sui popoli degli altri continenti. E la successiva politica colonialista e imperialista europea avrebbe continuato a considerarsi perfettamente giustificata ad opprimere i popoli di altri continenti in nome della superiorità della cultura occidentale”.
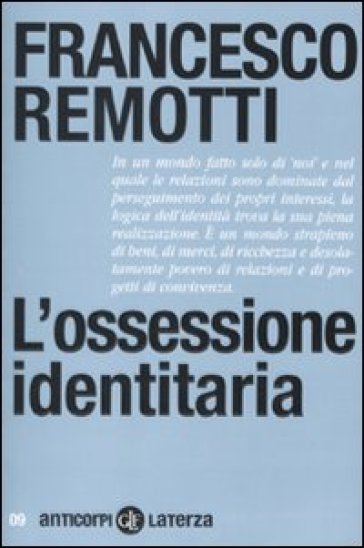
Docente di antropologia culturale all’Università di Torino, Francesco Remotti ha condotto indagini etnografiche ed etnostoriche in Africa. Tra le sue pubblicazioni Luoghi e corpi. Antropologia dello spazio, del tempo e del potere (1993), Contro natura. Una lettera al Papa (2008), Contro l’identità (2009), Prima lezione di antropologia (2009).
- doc. Remotti (pp. IX-XV; corsivo nel testo)
Al giorno d’oggi si fa un gran parlare di identità: nei dibattiti televisivi, sui social, sulle pagine dei quotidiani molteplici sono le prese di posizione, connotate spesso da toni allarmistici o addirittura apocalittici, in merito alla necessità di difendere un comune patrimonio valoriale ritenuto esposto a crescenti e temibili minacce. L’autore critica radicalmente questo concetto, evidenziando gli aspetti implausibili, mitici e perniciosi in esso implicitamente contenuti, e invita ad adottare una nuova prospettiva, foriera di proficue dinamiche sociali e interculturali.
“L’identità è un concetto non solo largamente impiegato, ma oltremodo attrattivo. L’identità – potremmo dire – si è ormai diffusa in modo contagioso, e sembra che anche le persone intellettualmente più accorte non possano fare a meno di utilizzare questa parola. Sembra che, se non si utilizzasse identità, non si potrebbe far parte del mondo attuale […] L’identità non è, infatti, più di destra che di sinistra: il suo uso è equamente distribuito. Identità è una moneta che tutti usano e senza dubbio contribuisce a creare un senso comune […] Agli occhi dei filosofi, questo concetto potrà sembrare vago nell’uso invalso nelle scienze umane e sociali, tanto quanto in storia, per non dire nel senso comune. Ma la parola di per sé è nitida, limpida, elegante, pulita. Essa trasmette infatti una sensazione di precisione, di ordine, di incontestabilità […]. E’ come se, per noi, in un mare di probabilità e di incertezze l’identità personale costituisse davvero un’isola protetta, qualcosa che offre il massimo di sicurezza, riconoscibilità, permanenza: io sono indubitabilmente io e non sono un altro, e continuo a essere io e soltanto io fino alla fine dei miei giorni (e forse anche oltre). […]La tesi che si vuole sostenere in questo libro è che identità – specialmente nell’uso che se ne fa negli ambiti sociale, politico, individuale, a livello di senso comune, oltre che scientifico – è una parola avvelenata. […] Perché e in che senso identità è una parola avvelenata? Semplicemente perché promette ciò che non c’è; perché ci illude su ciò che non siamo; perché fa passare per reale ciò che invece è una finzione o, al massimo, un’aspirazione. Diciamo allora che l’identità è un mito, un grande mito del nostro tempo. […]Gira e rigira (questa è una delle tesi del libro), l’identità rinvia pur sempre a una sostanza, ovvero all’idea di un nucleo stabile e permanente: se no, che identità sarebbe? […] Abbiamo provato a proporre un criterio per distinguere tra richieste di riconoscimento identitarie e richieste di riconoscimento non identitarie: le prime sono quelle in cui i soggetti tirano in ballo la questione della loro essenza o della loro sostanza, mentre le seconde sono quelle in cui i soggetti chiedono che vengano riconosciuti la loro esistenza (non la loro identità), le loro caratteristiche, i loro diritti, i loro obiettivi, i loro progetti. C’è una bella differenza tra le due richieste: diritti e obiettivi possono essere oggetto di dibattito, di contrattazione, anche di conflitto, mentre l’essenza richiede di essere riconosciuta totalmente e basta. L’identità (la sostanza) non è oggetto di negoziazione e di dibattito: esige di essere difesa e affermata nella sua integrità, e non sopporta di essere scalfita. Tutto ciò che proviene da fuori è una minaccia di ‘alterazione’: è una minaccia alla sua integrità, continuità, ‘purezza’.
E qui cominciano i guai, perché si sa che, quando c’è di mezzo la ‘purezza’ della nostra essenza (finta, immaginata), non c’è molto da attendere perché il sangue (reale) cominci a scorrere […] Una delle idee contenute in questo libro è che davvero non ci sia poi molta differenza tra razzismo e identitarismo. […] Ma se è ufficialmente tramontato il mito della razza, ha trionfato invece il mito dell’identità: il posto lasciato vuoto dal primo è stato comodamente occupato dal secondo. […] Il razzismo, come pericolo, è stato storicamente individuato; l’identitarismo no, o non ancora, semplicemente perché ci siamo dentro, come i pesci nell’acqua”.

Pietro Rossi ha insegnato filosofia all’Università di Torino. Socio dell’Accademia Nazionale dei Lincei, è stato a lungo direttore della “Rivista di filosofia”. Tra i suoi libri Lo storicismo tedesco contemporaneo (1956), La memoria del sapere (1988), Storia della filosofia (1993-99), opera in sei volumi diretta insieme a Carlo A. Viano, con il quale ha curato anche Le città filosofiche (2004).
- doc. Rossi 1 (pp. 12-14)
In occasione del varo nel 2003 della costituzione europea, mai entrata in vigore per la mancata ratifica di alcuni stati europei e definitivamente abbandonata nel 2007, accese discussioni aveva suscitato la richiesta, da parte della Chiesa cattolica, di un preambolo che facesse riferimento alle radici cristiane dell’Europa. Una posizione, peraltro a suo tempo non recepita, che l’autore ritiene contestabile sia dal punto di vista storico sia da quello valoriale-normativo e che ripropone ancora una volta il tema quanto mai dibattuto del “fondamento” dell’identità europea.
“Che in questo contesto storico, ben diverso da quello del secondo dopoguerra, la discussione sull’identità dell’Europa sia diventata più complessa, non deve quindi stupire. Ciò che sorprende, invece, è la tendenza a semplificarla, facendo appello a una presunta essenza dell’Europa, comunque definita. […] Proprio il rapporto conflittuale con l’Islam portava però a cercare le «radici» dell’Europa in un’altra direzione, nella religione cristiana. Ciò che distingue la cultura europea dalle altre civiltà è, in questa prospettiva, il rapporto originario con il Cristianesimo, anzi con la tradizione giudaico-cristiana […]. Ma la rivendicazione delle «radici cristiane» dell’Europa aveva soprattutto un’altra valenza: si rivolgeva non già contro l’Islam – una fede religiosa che, bene o male, riconosceva in Cristo uno dei profeti suoi precursori – bensì contro la società secolarizzata, che si è resa autonoma dalle chiese e dal loro insegnamento. Attraverso la richiesta di un «preambolo» alla costituzione europea la Chiesa cattolica ha riproposto, già sotto il pontificato di Karol Wojtyla, la concezione di un’Europa fedele alle proprie origini, e quindi disponibile a seguire, almeno nelle questioni eticamente rilevanti, il suo insegnamento. Le «radici cristiane» assumevano così una valenza normativa: diventavano il criterio fondamentale al quale la società europea, e quindi la neonata Unione, avrebbe dovuto conformarsi. In questo modo la Chiesa cattolica cercava di riconquistare, a distanza di mezzo millennio dalla Riforma luterana, l’egemonia sulla cultura europea […].
In realtà, il discorso sulle «radici» dell’Europa è un discorso non soltanto per molti versi strumentale, ma anche impostato in maniera erronea […] esso presuppone una continuità della storia europea che non c’è stata: se per identità dell’Europa s’intende il progressivo sviluppo di un nucleo originario permanente nel corso del tempo, è chiaro che essa, semplicemente, non esiste. Come tutte le altre società, anche quella europea è profondamente mutata nei secoli, e si è differenziata al proprio interno: non a caso si è spesso, e con ragione, insistito sulla pluralità culturale come un elemento costitutivo dell’Europa […]. Ma l’affermazione dell’esistenza di un nucleo originario, al quale ancorare l’identità dell’Europa, appare contestabile soprattutto quando essa diventa un principio normativo, un criterio di discriminazione di ciò che sarebbe autenticamente «europeo» rispetto a ciò che non lo è […]. Non siamo tanto di fronte a un errore storico, quanto a una mistificazione – in altri termini, di fronte a un’ideologia in veste religiosa. […][L’intento di questo libro è] mostrare il carattere problematico dell’identità dell’Europa, il continuo modificarsi dei suoi termini nel corso della storia europea”.
- doc. Rossi 2 (pp. 45-47)
Quando nasce l’Europa? In quale epoca venne avvertita, per la prima volta, la consapevolezza di far parte di una comunità su scala continentale? E quali i fattori che favorirono l’affermarsi di questo processo? Nel passo proposto l’autore situa questo momento, pur con una serie di precisazioni, nell’età carolingia, quando alla centralità del mare in età classica venne a sostituirsi, in seguito all’espansione dell’Islam, quella della terraferma. Una fase segnata dal costituirsi della respublica christiana e dall’egemonia culturale della Chiesa, che saprà modellare le proprie istituzioni su quelle dell’impero romano.
“La nascita dell’Europa viene di solito fatta coincidere con il sorgere dell’impero carolingio; e non c’è dubbio che questa data abbia un significato simbolico. Per la prima volta dopo la caduta dell’impero romano troviamo infatti una struttura politica relativamente accentrata, che pretende di esserne l’erede anche se il suo baricentro è continentale, non marittimo; ed essa si afferma per metà in regioni che erano state romanizzate fin dai tempi di Cesare, per l’altra metà oltre la linea del reno, in regioni che Roma non era riuscita a conquistare. Muovendo da questo nucleo centrale Carlo Magno riuscì a estendere il proprio dominio verso la Spagna, riprendendone agli Arabi la parte a nord dell’Ebro; verso l’Italia, sottraendola al dominio longobardo e giungendo fino a Roma; verso l’area tedesco-orientale, sottomettendo popoli germanici come i Sassoni e i Bavari, nonché i popoli slavi che si erano insediati tra la Sava e la Drava. Si trattava però di una costruzione effimera, destinata a soccombere in seguito alle lotte di successione tra i figli dell’imperatore, e soprattutto a causa del particolarismo della società feudale di cui proprio le regioni dell’impero carolingio costituirono il nucleo; né le successive rinascite dell’autorità imperiale – nel suo trapasso dalla casa di Sassonia a quella di Franconia, poi ancora nelle mani degli imperatori Svevi – riuscirà a unificare nuovamente il territorio sul quale Carlo Magno aveva esercitato il suo potere. Occorrerà attendere Carlo V perché l’impero si estenda su un ambito comparabile. […]
Che l’impero carolingio sia il nucleo dell’Europa è vero; che sia già Europa, anche se i suoi abitanti cominciarono talvolta a chiamarsi «europei», è per lo meno problematico. L’edificio che costruì Carlo Magno è piuttosto, qual è stato definito, la respublica christiana, un edificio fondato sul dominio di un popolo barbaro su altre schiatte germaniche, che trova la propria legittimazione in un ambiguo rapporto di sostegno reciproco tra potere politico e potere spirituale della Chiesa. […] Nella frammentazione della società feudale la Chiesa rappresenta, ben più di un impero il più delle volte latente, il centro di riferimento, politico e culturale, del mondo europeo”.
- doc. Rossi 3 (pp. 72-73)
In questo passo l’autore sottolinea la molteplicità e l’intreccio delle varie componenti che hanno contribuito allo sviluppo della civiltà europea e chiarisce che individuare e separare dal resto singoli elementi può avere utilità e plausibilità da un punto di vista analitico ma non certo sul piano della ricostruzione storica: l’Europa infatti è il frutto di un articolato complesso di fattori, ciascuno dei quali non può essere arbitrariamente isolato o tralasciato.
“Le componenti costitutive della civiltà europea non sono soltanto molteplici; sono anche, fin dall’inizio, intrecciate tra loro. La sopravvivenza della cultura antica è stata resa possibile dal Cristianesimo, dal lavoro di migliaia di monaci che negli scriptoria hanno copiato i testi classici e li hanno diffusi; ma da parte sua il Cristianesimo ha costruito il proprio edificio dogmatico avvalendosi di concetti e di dottrine formulate nell’antichità, soprattutto in epoca ellenistica, e la Chiesa si è costituita sulla base del modello organizzativo dell’impero romano. […] Anche il diritto canonico ha adottato gli schemi che gli erano offerti dal diritto romano […]. Analogamente, l’integrazione dei popoli barbari è stata resa possibile dalla diffusione della fede cristiana; e l’appoggio dei sovrani di stirpe germanica convertiti ha favorito, d’altra parte, questa diffusione. Le varie «radici» dell’Europa possono certamente essere oggetto di una distinzione analitica; ma nella realtà è inconcepibile separarle l’una dall’altra.
Il loro intreccio sta a base di una formazione storica che, delineata con la nascita del Sacro romano impero, si svilupperà nei secoli successivi fino a dar luogo all’Europa moderna […]. Al di là delle linee di divisione politica, l’Europa si costruì attraverso un processo di integrazione che mise insieme elemento romano ed elemento barbarico, formando un’area di comunicazione e di circolazione che abbracciava popoli diversi, unificata dalla struttura della società feudale e dei suoi costumi. Questa società è, in larga misura, di origine germanica; nasce dal prevalere dei popoli invasori sull’organizzazione municipale dell’impero: soltanto dopo il Mille si avrà un’inversione di tendenza, e le città riacquisteranno il ruolo che avevano nell’antichità. Ma la società feudale è, nonostante la sua origine, una società cristiana, nella quale le differenze di costumi (e di leggi) sono attenuate dall’adesione a una fede comune e a un comune centro religioso, che va estendendo il proprio controllo sui poteri locali, anche sui detentori dell’autorità politica”.
Tzvetan Todorov, La paura dei barbari. Oltre lo scontro delle civiltà, Milano, Garzanti, 2009

Tzvetan Todorov, nato a Sofia, dagli inizi degli anni Sessanta si è trasferito in Francia, ove è stato Direttore di ricerca onorario al Centro nazionale di ricerca scientifica di Parigi. Intellettuale di fama mondiale, tra i suoi libri ricordiamo La letteratura fantastica (1970), La conquista dell’America. Il problema dell’altro (1984), Noi e gli altri (1991), Di fronte all’estremo (1992), Memoria del male, tentazione del bene (2001).
- doc. Todorov 1 (pp. 248-51; corsivo nel testo)
Il grande intellettuale bulgaro e francese d’adozione (1939-2017) propugna per l’Europa un modello cosmopolita, in grado, senza abolire le differenze, di assicurare uguaglianza di diritti e pari status. Una visione che, nel rigettare logiche imperiali imperniate su assetti gerarchici, non si pone in antitesi al modello delle nazioni ma in una posizione di complementarietà e fedeltà ai valori del pensiero illuminista.
“L’identità europea consiste, pertanto, in una maniera di accettare la pluralità delle entità che formano l’Europa e di trarne profitto. L’Europa non è una nazione, ma una forma di coabitazione di nazioni. Si tratta sia di un aspetto culturale […] sia di un valore politico, che figura oggi nel programma dell’Unione europea. Per il modo con cui gestisce questa pluralità, l’Europa si distingue da altri grandi insiemi politici, presenti oggi nel mondo: stati multinazionali come la Russia o l’India, o stati dalla popolazione molto diversa, come la Cina o gli Stati Uniti.
Il sociologo tedesco Ulrich Beck ha proposto recentemente di indicare la via seguita dall’Unione europea come quella del cosmopolitismo e di collocarla in seno a un modello concettuale che integra le diverse maniere di vivere l’alterità culturale. […] Se i diversi ingredienti dell’insieme non sono trattati su un piano di uguaglianza, abbiamo a che fare con un impero. Esso possiede norme comuni e riconosce la diversità dei suoi costituenti, ma li tratta nella modalità della gerarchia e dell’egemonia, non dell’uguaglianza – accade così nell’impero britannico, o francese, o austroungarico, oppure ottomano (ciascuno secondo le proprie modalità). La metropoli possiede molti privilegi, rifiutati alle colonie, alle province e alle città satelliti. La cultura dominante tollera le culture minoritarie, ma non le considera al suo stesso livello.
Se non si riconoscono le differenze tra le parti che formano il tutto, ci si avvicina al modello della nazione, come nel caso della Cina o degli Stati Uniti: gli individui possono anche essere molto diversi tra loro, ma la nazione è una, con un solo governo e un solo parlamento. […] L’approccio cosmopolita, invece, non abolisce le differenze, ma attribuisce loro un quadro comune e uno statuto di uguaglianza dei diritti. […]L’idea di un’Europa cosmopolita è complementare a quella di un’Europa delle nazioni: l’una presuppone l’altra e nello stesso tempo le fornisce un quadro. […] Oggi l’Unione europea ha voltato le spalle ai tentativi di unificazione con l’uso della forza, come quelli compiuti da Carlo Magno e Carlo V, Napoleone e Hitler, e s’ispira piuttosto al modello pluralista, eredità del pensiero illuminista. […] Il singolare processo che ha condotto alla creazione dell’Unione europea a partire da una pluralità di stati autonomi e consenzienti ha prodotto un’identità unica e nello stesso tempo complessa. Essa implica che hanno dei diritti non solo gli individui, ma anche le comunità storiche, culturali e politiche rappresentate dagli stati membri dell’Unione”.
- doc. Todorov 2 (pp. 261-64)
Quali le frontiere dell’Europa? Chi ha il diritto di fare parte della Unione europea e chi può legittimamente aspirare ad esservi ammesso? L’autore propone tre criteri per l’accoglimento della domanda di uno stato che si candidi a divenire membro della UE. Criteri, secondo Todorov, dai quali dovrebbero esulare l’elemento culturale e il fattore religioso.
“I criteri espliciti per unirsi all’Unione si riducono a tre esigenze, nessuna delle quali permette di fissare le frontiere definitive dell’insieme. La prima è di ordine formale e giuridico: lo stato candidato deve accettare tutto il posseduto comunitario in materia di leggi, norme e trattati. La seconda è politica: deve essere uno stato di diritto, una democrazia liberale, vale a dire garantire l’uguaglianza rigorosa dei diritti di tutti – senza alcuna discriminazione razziale, etnica, religiosa, sessuale, dunque anche un suffragio universale effettivo – la libertà e la sicurezza degli individui contro ogni usurpazione proveniente sia da altre persone, sia dallo stato stesso. […] Infine, il terzo criterio è economico: solo gli stati provvisti di un’economia di mercato e di un certo livello di sviluppo possono chiedere di entrare nell’Unione europea; uno stato troppo povero rispetto agli altri non vi troverebbe posto. […]Accanto a questi criteri espliciti, altri, non formulati ma che sembrano naturali, sono ugualmente applicati. Per esempio l’esigenza di una continuità geografica: anche se soddisfa tutte le condizioni che definiscono il progetto politico europeo, il Canada non può farne parte – semplicemente a causa dell’oceano Atlantico! […] Un altro criterio non espresso riguarda l’estensione dei paesi candidati. Anche se la Russia soddisfacesse gli altri criteri di adesione, il suo posto non sarebbe mai all’interno dell’Unione europea: la sua superficie è due volte maggiore di quella dell’Europa comunitaria, la sua politica è quella di una grande potenza.
Bisogna aggiungere un criterio culturale a questo elenco? Lo si è potuto suggerire in occasione della candidatura turca, invocando, per contrastarla o difenderla, l’idea dell’Europa come di un «club cristiano». Ma allora si confondono storia e diritto. La religione cristiana ha lasciato […] un segno indelebile sull’identità culturale degli europei, ma ciò che l’Unione europea esige non è tanto l’imposizione dell’unità, quanto l’accettazione della pluralità […] Se l’Europa è un club, allora sarebbe un «club laico»: la sua esigenza è quella della libertà di coscienza e di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. La questione dell’adesione della Turchia non può essere risolta grazie a un criterio culturale; tutto ciò che si può chiedere su questo piano è che il paese aderisca a una politica laica. […]La politica efficace non consiste nel scegliere il realismo contro l’idealismo, o il contrario, ma nel richiamarsi a entrambi: individuare un ideale, in questo caso il benessere dei popoli europei, e fornirsi dei mezzi per raggiungerlo. […] La civiltà non è il passato dell’Europa, ma grazie alle scelte compiute dagli europei potrebbe essere il suo avvenire”.
























 Scarpe rotte eppur bisogna andar. Una storia della Resistenza in 30 oggetti, a cura di P. E. Boccalatte e M. Carrattieri
Scarpe rotte eppur bisogna andar. Una storia della Resistenza in 30 oggetti, a cura di P. E. Boccalatte e M. Carrattieri L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore
L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino
Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio
Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa
Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice
Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli
Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli L’arresto degli arlecchini
L’arresto degli arlecchini