
Le tante identità del Novecento
Il cimitero al Srebrenica-Potočari Memorial and Cemetery to Genocide Victims. Foto di a href=”//commons.wikimedia.org/wiki/User:MichaelBueker” title=”User:MichaelBueker”>Michael Büker – Own work, CC BY-SA 3.0, Link
Articolo inserito nel dossier del n. 11 della rivista
Tolleranza e intolleranza. Stranieri e diversi nel mondo contemporaneo
Abstract
Partendo dalla contrapposizione novecentesca fra totalitarismi e democrazie, l’autore individua la stretta connessione fra guerra e genocidio, di cui ricostruisce gli esempi più significativi, antecedenti e conseguenti alla definizione giuridica del crimine: gli armeni, la Shoah, il Ruanda, Srebrenica. Un’attenzione particolare è dedicata al tema del negazionismo e alle leggi che combattono il fenomeno, considerate inefficaci, se non controproducenti, in quanto non accompagnate da programmi culturali per la divulgazione della conoscenza storica. In conclusione invita a rinnovare gli sforzi di comprensione della contemporaneità, abbandonando le categorie interpretative novecentesche, ormai inadatte per capire il presente
Il Novecento tra democrazia e totalitarismi
Prima di entrare nella trattazione del tema della relazione, che sarà legata alle sollecitazioni giunte dal lavoro dei gruppi, occorre fare una considerazione preliminare: i conflitti di carattere religioso-etnico hanno avuto sempre nella storia un legame fortissimo con la politica, ma ancora di più nel ‘900, secolo in cui i poteri continuano a rimanere molteplici ma si devono costantemente commisurare con i governi, cioè con chi domina il quadro politico. A cavallo tra ‘800 e ‘900 c’è una fase di immissione delle masse nella vita politica, un aumento della loro partecipazione che da un lato spinge lentamente e inesorabilmente verso la democrazia, ma contemporaneamente genera anche forze che propendono per il rifiuto della democrazia. Così come, nello stesso periodo, c’è l’idea di un progresso inesorabile ma anche l’idea della crisi della civiltà. Non è un caso che, nel momento in cui è avvenuto l’ingresso forzato delle masse nella storia con la prima guerra mondiale e i contadini sono stati costretti a diventare cittadini in tutta Europa, si sono create rapidamente nuove forze politiche, vi è stato l’ampliamento del suffragio elettorale, in alcuni casi anche per le donne. In controtendenza, però, sono emersi i totalitarismi, che possono essere letti come risposte di tipo antidemocratico all’ingresso delle masse nella politica, caratterizzate da una forza vincente di irrazionalismo, di persuasività, che al momento era tutt’altro che scontata e percepita.
La difficoltà di riconoscere le origini dei totalitarismi
Non fu percepito in Europa nel movimento operaio e socialista, per esempio, il carattere totalitario che la rivoluzione bolscevica cominciava ad avere nei primi anni, già dal 1921 e poi in modo sempre più aperto in seguito alla morte di Lenin e alla vittoria di Stalin. Nemmeno fu percepita la portata del “Putsch” di Monaco di Hitler e la pubblicazione di Mein Kampf scritto durante la prigionia: come scrisse Viktor Klemperer[1], uno dei testimoni più acuti, nel suo diario pubblicato anche in italiano, è stupefacente il fatto che nessuno dei grandi intellettuali del tempo abbia preso sul serio quanto scritto da Hitler e valutato le dinamiche di persuasione politico-ideologica in senso razziale che ne sarebbero scaturite; se si astrae da quello che noi sappiamo, dal nazismo e dall’insistenza con cui Hitler parla soprattutto degli ebrei, ritroviamo in quell’opera molte suggestioni che ritroviamo oggi nei discorsi di grandi forze politiche europee e mondiali. È impressionante quanto Mein Kampf, di per sé un libro noiosissimo, possa essere utile dal punto di vista didattico per mostrare gli effetti persuasivi dei meccanismi di insistenza ripetuta che veicolano il messaggio social-darwinista, addirittura molto più grossolanamente dell’originale, cioè l’idea che bisogna adattarsi alla natura e individuare il nemico dell’umanità, che per Hitler si identificava nella razza ebraica.
Nuovi confini e conseguenti problemi dopo la dissoluzione degli imperi
Oltre ai totalitarismi e allo scontro tra questi e la democrazia che caratterizzò soprattutto la prima metà del secolo, il ‘900 è stato caratterizzato dalla decolonizzazione, che ha prodotto, oltre all’ingresso tra i protagonisti della storia della maggioranza dei paesi del mondo che ne erano esclusi, mutamenti fondamentali nel modo in cui viene vissuta l’identità nazionale e nell’intreccio fra questa e le appartenenze culturali e religiose, che implica legami generalmente stretti, ma modelli molto diversi tra loro.
Se facciamo l’esempio della partizione tra India e Pakistan del 1947, possiamo individuare nelle intenzioni britanniche ma anche in quelle dei partiti di maggioranza, il Congresso Nazionale Indiano e il partito dei musulmani, l’idea di dare evidenza alle differenze etnico-religiose da cui derivò il principio di configurare i confini con una logica che la storia aveva già mostrato deleteria, cioè la logica della omogeneità etnico-territoriale, già praticata con la pace di Parigi nel 1919 in cui si stabilì di ridurre a entità omogenee tutti i paesi che appartenevano agli imperi dissolti in seguito all’esito del conflitto, creando enormi problemi per le minoranze che non sarebbero stati risolti nel periodo fra le due guerre. Per certi aspetti il multinazionalismo dell’impero austro-ungarico e dell’impero ottomano prima della grande modernizzazione di fine ‘800 funzionava meglio per il rispetto delle minoranze di quanto sarebbe successo negli stati nazionali creati dopo la guerra. Nella stessa area della partizione del 1947 qualche decennio dopo ci fu quella tra il Pakistan e il Bangladesh, tra il 1970 e il 1971, due realtà caratterizzate da omogeneità religiosa ed etnica ma con profonde differenze culturali, più evidenti nella lingua e nella storia, fattori non secondari di divisione. Tutto questo ci fa capire come siano tanti i fenomeni in cui è difficile comprendere appieno il ruolo della religione.
I genocidi nascono nelle guerre
Vorrei provare ad analizzare sinteticamente all’interno dei grandi genocidi del ‘900 qual è stato il rapporto tra politica, stato, etnia, religione, cultura. Si è posto, nei lavori di questa Summer School, l’interrogativo se i genocidi siano legati alle dittature: è possibile rispondere che il legame non è necessariamente vincolato alle dittature in senso stretto; invece si può individuare una rapporto costante con le guerre ed affermare che nessun genocidio è avvenuto al di fuori di un conflitto, cioè del contesto in cui uno stato o una qualsiasi forma organizzata di potere politico decide che esiste l’occasione di portare a termine un progetto di pulizia razziale, etnica, religiosa o di classe.
La Shoah
La Shoah con il suo carattere di ideal-tipo è il momento che ha permesso, e ci permette ancora, di comprendere meglio tutti gli altri genocidi, avvenuti prima e dopo il riconoscimento giuridico del dopoguerra con la Convenzione per la prevenzione e punizione del crimine di genocidio approvata il 9 dicembre 1948.
Nella relazione del professor Remotti si ricordava questa mattina che il piano Madagascar non era un piano di sterminio; in Mein Kampf, infatti, è presente l’idea del liberarsi degli ebrei, anche se non sono definite le forme della liberazione, compito che spetta alla politica. In un primo momento sembrava sufficiente cacciare tutti gli ebrei rinchiudendoli in un mega-ghetto rappresentato da una grande isola. È nel corso della guerra, nelle sue modalità e forme acquisite sul fronte orientale con l’operazione Barbarossa, legata strettamente a un’altra idea di tipo etnico-razzista cioè l’inferiorità storico-culturale degli slavi rispetto agli ariani, che si rende possibile prima espellere gli ebrei indirizzandoli tutti in quella zona, infatti i campi di sterminio sono tutti a oriente, e iniziare una distruzione che nelle prime settimane della operazione Barbarossa viene fatta nei confronti degli ebrei e dei comunisti in modo assolutamente parallelo.
La dinamica di quel tipo di guerra e la logica sottesa di giudizio ideologico razziale, culturale ed etnico sono i fattori imprescindibili per la scelta assunta con la conferenza di Wannsee e l’idea della soluzione finale. Il genocidio che ne consegue ha come motivazione fondamentale non la religione ma la razza, come aveva a più riprese sostenuto Hitler in Mein Kampf attribuendo agli ebrei un’identità razziale e non religiosa; ne consegue che non vi sono alternative alla persecuzione, nemmeno un’eventuale conversione, in un quadro di assoluta incompatibilità della presenza ebrea con l’ordine mondiale e la nuova idea di umanità vagheggiati da Hitler. Oggi ci sembra impossibile pensare che trascorrono appena dieci anni tra il momento in cui si è iniziato a scivolare verso l’ imbuto che ha portato alla tragedia durante la guerra e la rinascita mondiale del dopoguerra, quando finalmente nella coscienza collettiva ci si propone di intraprendere il percorso che, non a caso, era riuscito ad anticipare solamente chi stava più lontano dal conflitto, il presidente americano Roosevelt. Questi, nel gennaio del 1941, quando gli Stati Uniti ancora non avevano subito l’attacco di Pearl Harbour, fece quel magnifico discorso, reperibile nella sua versione originale con la voce del presidente e utilizzabile come uno straordinario documento didattico, noto come “il discorso delle quattro Libertà”: la libertà di parola, la libertà di religione, la libertà dal bisogno, la libertà dalla paura, una sintesi di quanto sarà sviluppato nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, cioè i diritti civili e politici, quelli che i giuristi chiamano di prima generazione, e i diritti sociali ed economici, che sono quelli di seconda generazione, e poi la pace e tutti i nuovi diritti che si costituiranno intorno alla pace e progressivamente integreranno l’insieme dei diritti umani.
Il genocidio degli armeni
Tornando alle distinzioni possibili nell’ambito dei genocidi e soffermandosi in particolare su quello armeno, vi è da considerare che molti storici armeni insistono nel classificarlo anche come un genocidio religioso, operato dai musulmani contro i cristiani. In realtà si tratta di un genocidio demografico, territoriale e culturale. Demografico perché l’Anatolia, soprattutto la parte orientale, che era il cuore della popolazione e cultura armena, a partire dalla fine dell’800 fu riempita dai turchi costretti a scappare dalle zone dell’impero ottomano (Bulgaria, Serbia, Grecia) che si erano rese indipendenti e dove essi costituivano una minoranza ma che controllava il potere; questo fenomeno creò squilibrio demografico e tensioni che sfociarono nei primi grandi massacri della fine dell’800, precisamente tra 1894 e 1896. Non era l’inizio di un «lungo» genocidio, come molti armeni hanno sostenuto e sostengono, ma fenomeni che possono essere paragonati ai pogrom antiebraici in Polonia o in Russia, sempre alla fine dell’800. È innegabile la presenza di motivazioni anche religiose in questi fenomeni, ma è nel contesto della guerra che si definiscono le ragioni più profonde del genocidio, perché la minoranza armena poté essere sospettata di disponibilità al tradimento e all’alleanza con l’esercito russo che avanzava vittoriosamente a oriente. Fu, infatti, dopo la sconfitta nella battaglia di Sarikamiş, in cui l’esercito turco perse rovinosamente, che gli armeni furono individuati come responsabili della sconfitta e nei loro confronti vennero emanate in rapida successione due leggi, la legge di deportazione e la legge di confisca dei beni, in seguito alle quali furono espropriati di tutto e costretti alle lunghe marce della morte che li portarono fino ai campi del deserto della Siria, il più importante dei quali si trovava a Deir el-Zor, località che è finita sotto il controllo dell’Isis, dove arrivarono circa 800mila sopravvissuti per il definitivo annientamento. Una terza legge dell’impero ottomano, infatti, stabiliva che in ogni distretto dell’impero ottomano le minoranze non potessero avere una dimensione superiore al 5% della popolazione, percentuale che nel distretto di Aleppo saliva al 10%: siccome i superstiti armeni costituivano la metà della popolazione del distretto, si decise per la loro eliminazione. Quando i britannici liberarono Deir el-Zor erano rimasti 2500 armeni appena. In questo caso è evidente il ruolo assunto dal governo ottomano, a differenza di quanto avvenne nella Shoah in cui non ci fu una legislazione ad hoc per lo sterminio. Il giurista statunitense Stanton[2], noto per gli studi sui genocidi, ha definito alcuni passaggi che accomunano i meccanismi del genocidio, che passano attraverso la discriminazione, l’isolamento, la disumanizzazione e rendono possibile, infine, la distruzione totale.
Il genocidio dei Tutsi
Quello dei tutsi è un genocidio etnico causato da una vera e propria invenzione culturale del colonialismo introiettata, accettata e radicalizzata dal potere postcoloniale, soprattutto nella fase degli ultimi anni precedenti al governo Hutu. Nei processi svoltisi presso il Tribunale penale internazionale per il Ruanda alcuni imputati, a propria difesa, riconobbero l’insussistenza di differenziazioni etniche tra Hutu e Tutsi, mentre sulla base dei documenti della Radio Televisione Libera delle Mille Colline[3], che giorno dopo giorno indicava negli “scarafaggi Tutsi” i nemici da uccidere, è possibile percepire come la identificazione, classificazione e creazione di un gruppo etnico, in questo caso inesistente, da parte di un potere costituì la premessa al genocidio, perché la sua intenzione era quella di sterminare quel gruppo, che si credeva, o si voleva far credere, che esistesse davvero.
In questo caso si va oltre alla distinzione di tipo biologico o etnico, peraltro nel momento in cui appare con sempre maggiore chiarezza come queste differenze, da un punto di vista scientifico, siano sempre meno valide. È il caso di ricordare, a questo proposito, Luigi Luca Cavalli Sforza, morto recentemente, che è stato uno dei nostri più grandi scienziati capaci di raccontare l’unicità della razza umana e quindi di classificare come costruzioni culturali le differenziazioni che in genere fanno parte del senso comune.
Il genocidio in Bosnia: Srebrenica
Altro caso di genocidio riguarda la Bosnia, o meglio il massacro di Srebrenica, unico episodio cui siano state riconosciute dal tribunale internazionale le caratteristiche del crimine. Questo ha provocato polemiche, anche se dal punto di vista di quanto stabilito dalla legge l’attribuzione è indiscutibile: nonostante siano state risparmiate le vite di molte donne e bambini, la distruzione di tutti i maschi di una comunità equivale alla distruzione della comunità stessa. Nella convenzione del ’48 uno degli elementi che può caratterizzare il crimine di genocidio è la sterilizzazione di una popolazione, cioè impedire che essa possa riprodursi, così come la costrizione forzata, cosa che era accaduta in Armenia nei confronti dei bambini islamizzati a forza. A questo proposito ritengo opportuno ricordare che qualche anno fa, quando si cominciò a parlare anche in Turchia del genocidio armeno e vi fu consapevolezza nell’opinione pubblica grazie all’azione di alcuni intellettuali, cominciarono a diffondersi le storie di bambini armeni scampati al genocidio e islamizzati, al punto che, in seguito ad uno studio approfondito, i casi apparvero molto più numerosi di quanto avrebbero potuto essere, come se alcuni rivendicassero l’origine armena, identificandosi con la minoranza che era stata repressa, anche se non era vero. Questo fa capire la complessità delle dinamiche psicologiche e culturali che sono sottese a questi fenomeni e che durano per decenni.
I massacri in Unione Sovietica
Accanto ai genocidi possiamo trovare anche massacri che, pur spaventosi, non rientrano nella categoria, come ad esempio quelli dell’Unione Sovietica, perché lo sterminio di gruppi politici era stato escluso dalla convenzione, quindi anche da un punto di vista retroattivo non poteva essere classificato come genocidio. Sono milioni di vittime allo stesso tempo politiche e sociali, tutti i diversi tipi di oppositori e i contadini, la guerra contro i quali rivoltò completamente la topografia della società dell’URSS dell’epoca. A queste persecuzioni si accompagnano quelle rivolte alle minoranze etniche nel corso della guerra, soprattutto i Tatari, i Ceceni e gli Ingusci, che vennero deportati completamente e contro quelli che erano vissuti in zone dove l’occupazione tedesca aveva avuto successo e perciò la popolazione era stata considerata in blocco nel novero dei traditori e quindi in gran parte eliminata.
Le modalità dei genocidi sono diverse, ma accomunate dal fatto di nascere dall’intolleranza nei confronti delle minoranze da parte dei poteri. Questo aspetto è centrale: nelle democrazie il potere che si fonda sulle costituzioni dovrebbe garantire i diritti delle minoranze, la democrazia non è esercizio del potere da parte della maggioranza, ma garanzia nei confronti dei diritti di tutti, al contrario di quanto accadde nel periodo tra le due guerre mondiali, quando i totalitarismi bloccarono completamente le possibilità delle minoranze di esprimersi.
I genocidi e le legislazioni nazionali: il caso della Polonia
C’è ancora oggi una discussione molto forte in Polonia sul rapporto con gli ebrei: sappiamo che, per legge, è proibito affermare che i polacchi siano stati responsabili della persecuzione nei loro confronti, anche se ci sono prove evidenti e documentate delle responsabilità di parte della popolazione, al tempo dell’occupazione tedesca e anche dopo, quando ormai la guerra era finita, e ci furono atteggiamenti persecutori nei confronti degli ebrei sopravvissuti e ritornati nelle loro comunità. Questa legge ha diviso l’opinione pubblica, incontrato contestazioni e provocato manifestazioni: addirittura il Presidente della Repubblica, pur essendo del partito al governo, ha impedito che si arrivasse a una riforma della giustizia in nome della identità culturale nazionale che avrebbe reso le cose ancora più difficili. È innegabile che si stia costruendo in questi ultimi anni in Europa un’aggregazione molteplice di forze politiche che costituiscono una specie di internazionale dei nazionalisti, con cui bisogna capire come fare i conti, a partire dalle prossime elezioni europee.
La comunità internazionale e le questioni irrisolte: il caso della Bosnia
L’istituzione delle corti penali internazionali è stato un passaggio molto importante: si sarebbe dovuto fare già in occasione del processo di Norimberga, ma la guerra fredda ne impedì la creazione. Tuttavia non si deve ignorare che, con qualche elemento di ragione, non certo con tutte le ragioni, oggi in Africa la giustizia internazionale è vista come uno strumento neocoloniale perché la quasi totalità dei personaggi messi sotto accusa sono politici dirigenti di stati africani; così come è paradossale e insieme preoccupante che il tribunale per i crimini commessi nell’ex Jugoslavia è odiato dai serbi, dai croati e dai bosniaci perché non è riuscito a soddisfare nessuna delle parti lasciando – la Bosnia è il caso emblematico – delle memorie divise che sono pronte ad alimentare nuovi conflitti. Non succede perché c’è ancora il controllo delle missioni internazionali, ma pensiamo che a Sarajevo, dove sorgeva uno dei più bei musei storici d’Europa, oggi ne esistono tre: quello bosniaco-musulmano, quello bosniaco-croato e quello bosniaco-serbo. Pensiamo, inoltre, che i libri di testo di storia sono tre e che quello della minoranza croata viene stampato in Croazia, quello della minoranza serba viene stampato in Serbia, mentre i Bosniaci lo stampano in proprio; la stessa Unione Europea ha imposto che in questi libri di testo non si possa parlare della Bosnia dopo il 1976, avallando la rimozione pubblica totale di una memoria che, a livello familiare o di comunità, continua ad essere dirompente. Questo è un problema che dimostra la incapacità della comunità internazionale e dell’Europa di risolvere la questione, come già si era visto con gli accordi di Dayton. Del resto sono falliti persino i tentativi di fare un manuale europeo di storia europea, anche solo sulla prima guerra mondiale e con le logiche che sembrano prendere il sopravvento sarà sempre più difficile.
Il negazionismo e le leggi che lo combattono
Un tema legato a tutto questo, ma ne accenno solo, è il negazionismo. È un tema importante non solo sulla memoria ma anche sul diritto; anche l’Italia ha una legge antinegazionista che risponde ai criteri della decisione quadro del Consiglio d’Europa, che ha una formulazione improponibile, perché può punire qualsiasi negazione, sottovalutazione grossolana o minimizzazione di ogni crimine di guerra contro l’umanità così come è segnato nello Statuto di Roma, comprendendo atti di violenza la cui pratica è diffusa in tutto il mondo. Basterebbe che un giornalista, uno storico, un politico negasse il carattere di genocidio ad un fenomeno per essere messo sotto accusa, mentre i giudici hanno la possibilità di stabilire quello che è genocidio e quello che non lo è, con facoltà di intromissione nel campo della verità storica. La Francia, paese in prima linea nel mettersi in movimento nei confronti di crimini legati alla religione, vanta una nutrita serie di leggi sulla memoria, a partire dalla legge Gayssot[4] sul negazionismo della Shoah; poi ne ha emanata un’altra atta a punire il negazionismo del genocidio armeno, respinta dalla Corte Costituzionale, che rispondeva sostanzialmente alla volontà di Sarkozy di prendere i voti di mezzo milione di Armeni che dovevano andare a votare due mesi dopo l’approvazione della legge. In Italia la comunità armena conta poche migliaia di persone, in Francia, dove vive la più grande comunità dopo quella degli USA, ci sono mezzo milione di armeni; addirittura la Francia aveva fatto una legge che difendeva i risultati positivi del colonialismo, anche questa poi, per fortuna, abolita. Questa volontà statale di interferire nella conoscenza storica, cosa che avviene in tutta Europa, sottende l’idea che di fronte ad un tema reale e importante come quello del negazionismo la risposta debba essere di tipo repressivo: una scorciatoia che mette l’animo in pace e fa evitare a qualsiasi governo di prendere in considerazione misure di carattere educativo e culturale.
Le insidie di una politica solo repressiva
Io credo che una campagna fatta bene, e neanche con troppe risorse, per poter raccontare nelle scuole la storia dei genocidi che vengono negati potrebbe rapidamente diminuire la diffusione delle idee negazioniste, invece non si fa nulla se non criminalizzare e rendere in qualche modo i siti negazionisti, spesso gestiti da giovani, come dei fari di eroismo della libertà d’espressione; è un tema importante che non dobbiamo sottovalutare, perché, ad esempio, negli Stati Uniti la possibilità di poter dire qualsiasi cosa, anche negare un fatto storico evidente come la Shoah, è ammesso se non comporta anche istigazione all’odio e altro di simile. Infatti negli Stati Uniti opera un intellettuale che è considerato fra i campioni dei diritti umani, Noam Chomsky, che per ben tre volte ha contribuito al negazionismo: la prima volta scrivendo la prefazione ad un libro di Faurisson, il più noto fra i teorici negazionisti francesi, anche se poi si è giustificato affermando che non conosceva bene i contenuti del volume[5]; la seconda volta, in modo molto più ponderato, agli inizi del genocidio in Cambogia, pubblicò un lungo articolo insieme ad un collega asserendo che le accuse rivolte ai khmer rossi erano una menzogna occidentale per colpire i grandi risultati del comunismo, salvo poi ricredersi e nel 1995 riconoscere il carattere di genocidio a quanto avvenuto[6]; infine Chomsky scrisse una nuova prefazione a un libro negazionista, questa volta sul genocidio dei Tutsi, sostenendo che non è stato un genocidio perché anche i Tutsi hanno ammazzato gli Hutu. E’ un modo curioso di identificare il problema, rifiutando realtà acclarate dal punto di vista giudiziario[7].
Non esiste il pensiero unico liberale
Si sente spesso affermare che nella realtà odierna vi sia un’omologazione al pensiero unico liberale: difficile condividere questa affermazione se guardiamo a Erdogan in Turchia, a Putin in Russia, a Trump negli Stati Uniti, alla Le Pen o a Salvini: di liberale non hanno nulla e quindi mi sembra difficile pensare che il liberalismo, politicamente interpretato soprattutto da Macron, sia il pensiero unico di questo mondo. All’interno di queste forme di pensiero autoritarie dobbiamo essere capaci di individuare le differenze. Se invece si vuole sostenere che il capitalismo è accettato come unica realtà, è vero, come è vero però anche che il capitalismo nel corso del ‘900 si è talmente diversificato che non possiamo pensare che sia una cosa unica quello che esiste in Italia, negli Usa, in Cina, in Nigeria, in Russia. Probabilmente sì se si valuta che l’essenza del capitalismo risieda nell’esistenza della proprietà privata, ma penso che oggi sia necessario fare delle analisi del tipo di strutture complessive, sociali, economiche e politiche esistenti, che non rispondono più a quelle categorie con cui abbiamo interpretato il mondo nell’800 e anche nel ‘900: serve un grande, ma necessario sforzo per comprendere quello che ci sta attorno.
Note:
[1] Viktor Klemperer (1881-1960), filologo tedesco di origine ebrea; l’opera cui si fa riferimento è: “Testimoniare fino all’ultimo : diari 1933-1945” a cura di Walter Nowojski, con la collaborazione di Hadwig Klemperer; edizione italiana a cura di Anna Ruchat e Paola Quadrelli, con prefazione di Cesare Segre, Mondadori, Milano, 2000.
[2] Stanton, G. H., The Eight Stages of Genocide, Washington, Genocide Watch, 1998.
[3] Stazione radio del Rwanda che trasmise per un anno, dal luglio 1993 al 1994, incitando gli Hutu alla violenza e all’odio razziale contro i Tutsi
[4] La legge del 13 luglio 1990 proibisce e sanziona penalmente le tesi revisioniste; è così definita dal nome del suo promotore, Jean-Claude Gayssot
[5] L’opera di Robert Faurisson cui si fa riferimento è Mémoire en défense contre ceux qui m’accusent de falsifier l’histoire. La question des chambres à gaz, pubblicato nel 1980
[6] L’articolo, scritto insieme ad Edward S. Herman, comparve sulla rivista The Nation il 6 giugno 1977
[7] Si tratta del libro The politics of genocide, scritto da D.J. Peterson e Edward S. Herman e pubblicato nel 2010



















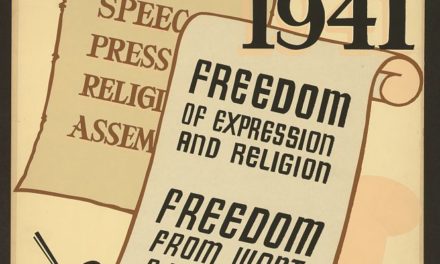

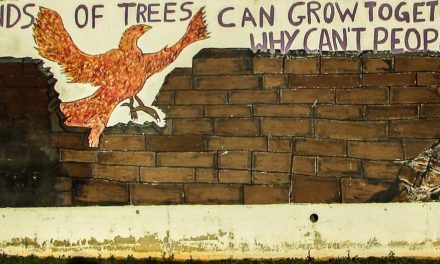
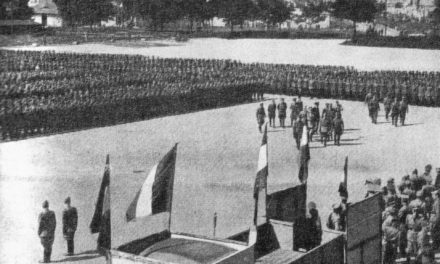
 L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore
L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino
Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio
Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa
Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa Storia passionale della guerra partigiana di Chiara Colombini
Storia passionale della guerra partigiana di Chiara Colombini Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice
Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli
Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli L’arresto degli arlecchini
L’arresto degli arlecchini