
Nazionalizzazione delle masse, costruzione delle cittadinanze e delle identità nazionali, inclusioni ed esclusioni
Testo della conferenza rivisto dall’autore e trascritto a cura di Enrico Pagano e Luciana Ziruolo.

Heuberg 17 luglio 1944, Benito Mussolini passa in rassegna i reparti della divisione “Italia”. Fotografia d’epoca, Pubblico dominio, Collegamento
Abstract
L’autore riflette sui processi di nazionalizzazione delle masse e di costruzione delle cittadinanze che caratterizzano il profilo dello stato-nazione otto-novecentesco, impostato sull’idea di omogeneità etnica, non senza contraddizioni e compromessi, in particolare sul tema della tolleranza. Particolare attenzione è dedicata al caso italiano e alle sue peculiarità storiche, tra cui si evidenziano l’invenzione, l’applicazione e l’esportazione del fascismo e la particolare carica assunta dall’esperienza colonialista, seppure di minore durata rispetto ad altri paesi, che sono stati fattori condizionanti nella costruzione della cittadinanza italiana. La crisi contemporanea dello stato-nazione fondato sull’omogeneità etnica apre prospettive contrastanti: il ritorno al nazionalismo e all’intolleranza o la multiculturalità.
Premessa
Il processo di costruzione delle nazioni, un processo storico di enormi dimensioni e portate, è un fenomeno che è studiato da più discipline scientifiche. Ad esempio, gli psicologi sociali lo esaminano a livello individuale, o di piccoli gruppi direttamente osservabili nella ricerca sul campo e nella pratica clinica. I cultori della sociologia storica disegnano grandi affreschi. Gli storici, inevitabilmente, lo vedono come un processo storico, con permanenze e variazioni nel tempo.
Per l’Europa il processo di costruzione del cittadino – che è lo stesso di quello della costruzione dello straniero – ha com’è noto ormai alcuni classici quali le opere dello storico George Mosse, che a proposito della creazione delle nazioni ha parlato di nazionalizzazione delle masse[1] e Eric Hobsbawm[2], di cui una assieme con l’africanista Terence O. Ranger[3].
Non si consideri inappropriata la presenza, al fianco di Hobsbawm, di uno studioso di civiltà extraeuropee: parallelo al processo dell’espansione coloniale, la costruzione delle nazioni europee ‘produsse’, o ‘inventò’, non solo la figura dello straniero ma anche quella del suddito coloniale, del nero, o del giallo, o del bruno, da incivilire da parte del bianco.
I temi della guerra e del colonialismo in questa luce non appaiono allora del tutto fuori luogo, e possono fornire una spiegazione del fatto che a parlare di nazionalismo, intolleranze e razzismo abbiano chiamato uno storico militare e del colonialismo[4].
Peraltro, viviamo oggi una fase storica assai peculiare. Il processo plurisecolare di costruzione delle nazioni, e degli Stati-nazioni, e in particolare degli Stati di diritto, conosce un momento di crisi, o di trasformazione. La tolleranza, che aveva accompagnato, dalla Rivoluzione francese in poi, quindi dalla curvatura degli Stati nazionali in Stati di diritto e in democrazie sino ad oggi, sta radicalmente indebolendosi, così come peraltro gli Stati di diritto e le democrazie. V’è ormai chi parla esplicitamente, anche da noi, di crisi delle democrazie liberali[5]: e in esse della tolleranza verso l’Altro. V’è chi parla di caos nelle relazioni internazionali, e torna ad accennare alla possibilità di guerra[6].
Il processo di nazionalizzazione
I processi adesso accennati sono enormi, rispetto alla possibilità – in questa sede – per poter parlarne nel dettaglio. Ci si limiterà quindi a qualche aspetto.
Abbiamo già affermato come, per capire il concetto di “straniero”, si debba storicamente partire dai processi di nazionalizzazione e di costruzione delle cittadinanze. Lo stato-nazione contemporaneo, otto-novecentesco, con i suoi apparati, ha giocato in questo un ruolo decisivo.
Ad esempio, l’estensione otto-novecentesca dell’obbligo scolastico fu parte di un’esperienza diffusa in Europa e negli Stati Uniti, e solo molto più lentamente nel resto del mondo. A scuola si insegnò a essere cittadini, a distinguere l’amico dal nemico, il nostro gruppo dall’altro gruppo, gli italiani dagli austriaci. Nel nostro Paese ciò fu particolarmente evidente al tempo dell’Italia liberale, dal 1861 al 1914. Ciò che gli italiani ebbero imparato ad essere dal 1861 al 1914 lo misero in pratica fra il 1915 e il 1918. Non diversamente, quello che gli italiani del ventennio fascista ebbero imparato a scuola e nelle varie istituzioni del regime dal 1922-25 al 1940 lo misero in pratica dal 1940 al 1943 (e per certi versi, anche nelle loro reazioni, dal 1943 al 1945).
Nel frattempo, mentre il processo di nazionalizzazione si sviluppava, altri processi erano in moto. L’Italia, come Stato nazionale, arrivò molto tardi rispetto ad altri Stati europei all’esperienza coloniale diretta, per ragioni dovute alla sua tardiva unificazione. Tuttavia, anche quella per gli italiani fu un’esperienza costitutiva della costruzione del cittadino, della nazionalità, dell’essere italiano. Come Paese ce ne siamo orse dimenticati dal 1945 in poi perché l’Italia perse le proprie colonie nel 1943 e quindi non ha potuto svolgere la riflessione sul passato coloniale nazionale, la rielaborazione del lutto della perdita del ruolo di potenza coloniale, che altri Paesi svolsero al tempo della decolonizzazione. Ad esempio, intellettuali come Camus e Sartre presero parte ai processi di rielaborazione francese della perdita delle colonie; gli italiani non ebbero aiuti paragonabili, troppo pochi intellettuali della Repubblica si impegnarono a decolonizzare le menti, visto che i territori africani erano stati persi già prima della sua costituzione (Somalia a parte).
Fu così che gli italiani della Repubblica si dimenticarono dell’esperienza coloniale, che pure era stata parte importante della esperienza nazionale.
Inclusioni ed esclusioni
È forse qui opportuno introdurre un concetto relativo alla cittadinanza che pure ha legami strettissimi con la teoria, e la pratica, della tolleranza.
Lo stato-nazione europeo otto-novecentesco evidenzia alcune peculiarità rispetto ai modelli statuali dell’antichità classica, non solo greca o romana, e ai suoi stati-città, così come alle città, agli stati o agli imperi medievali, per finire poi con gli stati dell’Europa moderna. Esso infatti si basa su un concetto che in tutte queste esperienze statuali precedenti non c’era, cioè la base omogenea della popolazione, appunto il popolo inteso come nazione. L’omogeneità è alla base della nazione: gli italiani popolano l’Italia, i francesi popolano la Francia, gli inglesi popolano la Gran Bretagna. Questo mette in grandi difficoltà le minoranze in ciascuno di questi Stati: la storia tragica dei catari o dei rom, per non dire degli armeni, misura la radicalità di questi processi di costruzione etnica degli Stati nazionali otto-novecenteschi europei. Ancora più chiaro è la questione, se si pensa ai territori coloniali: la cittadinanza dei ‘bianchi’ della madrepatria si fonda su un’esclusione dei sudditi coloniali d’Africa o Asia dall’accesso a tutti i diritti nazionali invece da parte dei cittadini, da parte degli europei. Gli stati di diritto e le democrazie, lentamente costruiti a partire dalla Rivoluzione francese, gli stati dell’Ottocento-Novecento, segnati dalla devoluzione del potere dalle mani del monarca a quelle del popolo attraverso le proprie rappresentanze parlamentari, si fondano su questa ambiguità, su questa contraddizione. L’inclusione del popolo in quanto nazione si fonda su un’esclusione.
La stessa cosiddetta ’ascesa delle masse’ come soggetto di rilevanza politica fra ottocento e Novecento, il riconoscimento cioè del suffragio universale e la ridefinizione del corpo politico-elettorale della nazione, si basa su questo duplice processo di inclusione (nella madrepatria) e di esclusione (nelle colonie). Certo questo non nega che quando il fondamento dell’unità politica di uno Stato non si basa più sul principio per cui la divinità ha incaricato il re e la sua dinastia di gestire il potere, bensì su quello della rappresentanza della nazione, della legittimazione dal basso, cioè popolare, è evidente che qualcosa di molto importante è stato cambiato, è successa una rivoluzione. In casi estremi, prima in Inghilterra a metà del Seicento e poi in Francia alla fine del Settecento, il re perse la testa in senso non figurato. Il nazionalismo fu insomma un’ideologia rivoluzionaria, all’inizio, così come lo fu l’idea di stato-nazione. Questa idea però si attuò fin dall’inizio su processi di esclusione non meno che di inclusione. Anche se nelle Costituzioni si leggeva che finalmente lo stato-nazione rappresentava tutti, in realtà alcuni rimanevano non rappresentati.
Il processo di nazionalizzazione rafforzò queste esclusioni. A scuola, uno dei tanti contesti in cui si costruiva la nazione e si forgiava l’idea di cittadino (e di straniero), si insegnò il “tutti”, tralasciando di parlare degli esclusi. La scuola fu insomma uno dei tanti strumenti attraverso cui lo Stato nazionale nazionalizzò i propri cittadini. Accanto alla scuola le bandiere, gli stemmi, i canti nazionali, l’inno nazionale, il servizio militare, i mass-media operarono nella stessa direzione. Attraverso questa larga quantità di strumenti lo Stato convinse i propri cittadini di essere parti di una stessa nazione. Eugen Weber, nel suo Da contadini a francesi[7], descrive il processo di nazionalizzazione appunto dei cittadini dell’Esagono tra Otto e Novecento: prima erano ‘solo’ contadini, non sapevano di essere francesi. Lo Stato lo insegnò loro: contemporaneamente insegnò che i tedeschi erano i loro nemici, e che gli africani e gli asiatici erano i loro sudditi[8].
La crisi dello stato-nazione
Questo processo di nazionalizzazione, va ricordato, prevalse ma non eliminò altre identità. Le identità, in ogni individuo, o gruppo sociale, o Stato nazionale, sono sempre plurime ed in precario e conflittuale rapporto. Anche se alcune identità, rafforzate da particolari istituzioni e in particolari contesti, possono prevalere – avere l’egemonia – su altre il loro carattere plurale deve essere assunto e tenuto di conto.
Creare un’identità nazionale che prima non c’era fin^ con il convivere con altre identità: riprendendo l’esempio di Weber, nell’Esagono si passò da contadini a francesi, ma rimasero i francesi del nord e quelli del midi, gli operai e gli imprenditori, i repubblicani e i nostalgici della monarchia, gli uomini e le donne. E questa pluralità di identità è inattaccabile dallo stato nazionale.
Lo stato nazionale su questo non vinse, anzi forse non mise nemmeno in conto di combattere o vincere creando un’identità unica. In tal senso si mossero solo i regimi totalitari, e quindi sostanzialmente il fascismo, il nazismo e, in parte, l’Unione Sovietica.
Saltando molti passaggi per ragioni di tempo, per arrivare subito all’attualità, è evidente che questa resilienza delle plurime identità non facilitò le cose allo Stato nazionale, allo Stato di diritto, in particolare alle democrazie[9].
La crisi attuale dello Stato nazionale è anche legata a questa realtà. Non è, cioè, una crisi solo dovuta alla globalizzazione, alla crisi economica, all’attività di partiti o movimenti secessionisti, localisti o nativisti. Il fatto è che molte questioni contemporanee non sono più a dimensione di Stato nazionale, e quindi lo mettono in difficoltà. Fra le altre, una ragione di questa crisi è interna, e sta appunto nella resilienza, o nei revival, di altre identità non nazionali; un’altra ragione sta, com’è noto, che, nella più odierna contemporaneità, lo stato-nazione entra in crisi di fronte al rafforzarsi di altre realtà istituzionali e politiche: sono realtà sovranazionali, createsi o rafforzatesi negli ultimi decenni (si pensi all’Organizzazione delle Nazioni Unite, alla galassie di istituzioni internazionali ad essa legate, all’Unione europea ecc.: ma si tratta solo di esempi dei legami internazionali e transnazionali che ormai ‘stringono’ lo Stato nazionale). Ed altre ancora ce ne sono: si pensi alle esperienze transregionali, che legano territori di più stati per risolvere problematiche che non trovano soluzione se affidate agli Stati nazionali.
Lo Stato nazionale vive insomma oggi una sua crisi profonda da cui si può uscire probabilmente in tanti modi. Fra i vari, due sono ben chiari, ed opposti. Da un lato sta la via dell’ulteriore indebolimento degli Stati nazionali e il trasferimento di poteri a realtà sovranazionali. Dall’altro sta l’irrigidimento degli Stati nazionali, con un iper-nazionalismo che ai più avvertiti appare del tutto fuor di tempo ma che ad alcuni offre invece ancora molte opportunità, e che elettoralmente pare funzionare. (Questa biforcazione di possibilità ha impatto immediato sui temi di cui dibatte la presente Summer School, perché per un verso si indebolisce il profilo dello straniero e si aumenta quello della cittadinanza plurinazionale, mentre nell’altro verso si insiste su una cittadinanza di livello nazionale e quindi sulla esasperazione del profilo dello straniero.)
Uno studioso molto importante, il filosofo tedesco Jürgen Habermas, di fronte alla constatazione del fallimento dello Stato nazionale non ripropone un nuovo nazionalismo, ma un patriottismo costituzionale[10] attraverso il quale si possa innescare una positiva gara emulativa tra gli Stati, senza intenti di prevalenza o sopraffazione dell’uno sull’altro. Non teorizza, in altre parole, un primato fondato sull’identità, ma suggerisce di esaltare i valori e i principi sanciti nel patto costituzionale, che diventa così una caratteristica che unifica e contraddistingue.
Si tratta di questioni complesse e difficili da declinare in un momento di transizione quale quello che viviamo, in cui tutti sono costretti a ripensare se stessi e le categorie con cui hanno operato.
La tolleranza
La storia della tolleranza (di quella, diciamo, moderna) corre parallela alla storia degli Stati nazionali[11].
In fondo i suoi primi esempi, che si distaccano dal contesto e dalle sue accezioni prevalenti, sono quelli della tolleranza religiosa, benignamente ‘concessa’ dai capi di Stato moderni a comunità e individui che praticavano credi religiosi diversi da quelli del monarca e, per questa via, dello Stato. Anche la tolleranza da parte degli Stati moderni coloniali nei confronti delle pratiche religiose, e culturali, delle popolazioni soggette all’Oltremare può, per certi versi, essere apparentata alla più nota tolleranza religiosa. Così, trattato di Westfalia e processo di creazione di Stati moderni, con tutto quanto – in linea di tendenza – avrebbe portato alla nazionalizzazione delle masse; Riforma protestante, guerre di religione ma anche tolleranza religiosa; espansione europea e imposizione del potere coloniale ma anche civilizzazione e tolleranza delle culture e dei culti locali furono processi diversi ma intrecciati fra loro.
Ciò detto, oggi, tolleranza è un termine che gli storici maneggiano con molte delicatezze, e qualche imbarazzo[12]. La tolleranza religiosa moderna, nata dalla crisi dell’universalismo cristiano, è diventata un elemento caratteristico dell’Europa divisa in stati e nazioni. D’altro canto, a meno di non sprofondare in uno stato di guerra permanente, con quella rottura emersa la realtà di identità e religioni diverse, di mondi diversi, e con questo gli Stati, e i monarchi, dovevano venire a patti. Da qui l’‘invenzione’ della tolleranza, con la compresenza di sudditi protestanti accanto a quelli cattolici. Un’invenzione di successo perché, pur contraddetta da sanguinose guerre di religione, instaurò una pace sociale. Fu questo il punto più alto della storia della tolleranza moderna.
C’erano state altre forme storiche di tolleranze preesistenti. Ce n’erano state nell’esperienza antico-romana, ce n’erano state di minore successo o tentativi mancati, per esempio nella lotta con l’islam. Ma fu, quantomeno nel recinto continentale europeo in età moderna, e dopo le guerre di religione, che la tolleranza funzionò al tempo stesso come riaffermazione della potenza monarchica che si manifestava nella benevolenza del re che tollera che alcuni pensassero o credessero in maniera diversa dalle istituzioni, e come concessione di diritti.
Ovviamente, già allora non mancarono le limitazioni (e le esclusioni): non tutte le sette protestanti furono riconosciute, alcune furono ferocemente perseguitate ecc. Nel momento stesso in cui si tollerarono alcuni culti, si alzò l’intolleranza verso altri: la tolleranza raramente, anche in età moderna, fu universale. Ad esempio, in ambito protestante, si limitarono i diritti dei calvinisti o in alcuni casi dei valdesi. Inoltre, non si era di fronte al riconoscimento di diritti, bensì all’elargizione di concessioni. Non c’era libertà e democrazia: era il re che si acconciava a concedere il permesso di praticare culti diversi da quello istituzionale.
Con la rivoluzione francese molto di questo cambiò: dopo il 1789 si parlò meno di tolleranza, ma la si praticò, e si cominciò a parlare di diritti universali, di fraternità e uguaglianza.
Poi, in particolare nel corso dell’Ottocento, ma anche dentro stesso il processo rivoluzionario francese, prevalse però la logica dello stato nazionale. Un esempio illuminante, in cui, tra l’altro, il discrimine coloniale è rappresentativo, riguarda il caso di Haiti. Là un capopopolo locale, Toussaint Louverture, decise di sollevare i sudditi haitiani sperando che ad essi la Rivoluzione voglia lasciare la stessa libertà dei francesi. Il potere rivoluzionario, invece, represse con violenza le aspettative di tolleranza[13]. Era solo l’anticamera di una realtà contraddittoria che vide il liberalismo europeo coloniale ottocentesco e primo-novecentesco ampliare costantemente, per quanto lentamente, i diritti politici – il suffragio – ai sudditi della madrepatria e negare invece la cittadinanza piena ai sudditi coloniali.
Non senza quindi questi evidenti limiti e contraddizioni, si può concludere che la storia della tolleranza in Europa (religiosa come politica) abbia avuto un certo successo.
La crisi della tolleranza
Le cose hanno cominciato però ad andare in crisi.
Dapprima, fra le due guerre mondiali, con i regimi fascisti e totalitari, in quanto tali nemici della democrazia, dell’estensione dei diritti e della tolleranza.
Ma poi anche nei Trenta anni gloriosi del grande sviluppo economico europeo (1945-1973). Ciò avvenne anche perché, all’interno di questa fase storica, si crearono aspettative e soggettività che volevano andare oltre la tolleranza, nel senso di concessione, e che volevano invece il riconoscimento di diritti pieni e inviolabili dell’individuo e dei popoli.
Anche se la tolleranza quando nacque fu rivoluzionaria, con il tempo diventò qualcosa di insopportabile per molti. Rileggere alcune aspre pagine che Marcuse scrisse sulla (contro la) tolleranza permette di ritrovare la sua definizione in negativo in quanto valore borghese che impedisce l’espressione della soggettività[14]. Marcuse criticava che la borghesia tollerasse che alcuni volessero pensare in maniera diversa, ma non accettasse che tutti potessero farlo. In fondo, anche Franz Fanon non voleva mendicare tolleranza ma chiedeva indipendenza e democrazia[15].
Gli affanni della tolleranza si moltiplicarono poi nell’età globale, negli ultimi decenni. Gli studiosi della storia della tolleranza, tra cui si segnala Maria Lanzillo[16], i cui libri sono peraltro ottimi strumenti anche didattici, osservano che nell’età globale questo tipo di tolleranza non funziona più: sono scomparsi i margini economici e politici per poter distribuire risorse reali e simboliche a chi vuol pensarla in maniera diversa a livello religioso o politico, si affermano nuove intolleranze e chiusure.
E inoltre oggi, la tolleranza, che ha sempre avuto un profilo sostanzialmente individuale – era il re a concedere al singolo credente la libertà di pensarla in maniera diversa – riguarda gruppi interi di popolazione, comunità, popoli. I migranti si spostano oggi con le proprie fedi, con i propri pensieri e vogliono essere riconosciuti come gruppi, non individualmente. La vecchia tolleranza non serve più.
Inoltre, proprio per la gigantesca novità del grandioso fenomeno dello spostamento delle popolazioni in un mondo in movimento – non si deve pensare che le migrazioni riguardino solo noi in Europa[17] – le identità si radicalizzano e si moltiplicano le intolleranze nei paesi di accoglienza.
Che si chiamino Trump, Le Pen, Horban, Salvini o Alternativ für Deutschand, che si parli di Stati uniti d’America, Francia, Ungheria, Italia o Germania, nella realtà globale attuale si moltiplicano al tempo stesso richieste radicali di riconoscimento radicale da una parte (di gruppi, e non più di singoli individui) e intolleranze radicali da parte di chi riceve. Tutti questi movimenti e contesti sono fra loro diversi, ma robusti fili di continuità legano questa contrapposizione fra richieste di diritti e contrapposizioni nativiste. Sono storie contemporanee che hanno una lunga storia[18]. Le inclusioni così come le esclusioni odierne hanno in Europa una storia lunga, che rimonta alla costruzione dello Stato nazionale, e alla storia dell’espansione europea: hanno radici che non possono essere sottovalutate.
Quale soluzione dare al problema? Noi come storici non abbiamo nessuna soluzione. Il nostro compito, già difficile di per sé, è quello di riuscire a capire come le cose si sono strutturate in un mondo sempre più complesso.
Quello che è certo è che le identità sono oggi plurali. Lo erano anche prima, ma oggi lo si vede ancora più chiaramente.
Il caso italiano
Queste larghissime linee generali possono servire da guida anche per comprendere meglio ciò che è avvenuto, e avviene, in Italia.
Il caso italiano non è un’eccezionalità, ma ripete – sia pure con molte peculiarità – la norma operante in Europa e anche fuori d’Europa. La principale di queste peculiarità storiche sta nel fatto che rispetto agli inglesi e ai francesi gli italiani abbiano avuto uno Stato nazionale unitario solo da poco più di un secolo e mezzo, periodo però in cui sono successe alcune cose che anche altrove erano successe.
Quali sono alcune di queste specificità? Ad esempio che la cittadinanza in Italia, dall’Unità ad oggi, sia sta basata sul cosiddetto ius sanguinis. Poteva cambiare qualche mese fa, poi il cambiamento non c’è stato. In altri Stati, per la diversa complessità delle locali storie moderne e contemporanee, se non medievali, non è così. Vi insiste un testo di Alberto Maria Banti, Sublime madre nostra[19], una storia del nazionalismo italiano molto utile e importante, anche se non sono del tutto condivisibile. Banti, in maniera più chiara che altri, ha specificato, da storico, che il diritto di cittadinanza italiana si basa sullo ius sanguinis. Se un punto di distinzione può essere individuato, è che, da storico culturale, Banti abbia analizzato tutto questo a livello dei ‘testi’ nazionali e nazionalisti, identificando un codice di base e una continuità di parole, testuale, cosa che lo porta a sottolineare la strutturale continuità, anzi talora l’identità fra testi dedicati o determinanti la cittadinanza in Italia fra periodo risorgimentale, Italia liberale, prima guerra mondiale e persino fascismo, per non dire seconda guerra mondiale e Repubblica, arrivando sino al presidente Ciampi. Se è vero che da un punto di vista testuale e retorico la continuità ci sia, si potrebbe osservare che dietro parole simili o uguali stiano realtà storiche, politiche, sociali ed economiche enormemente diverse. Il nazionalismo – per dire – di Crispi non è lo stesso di Giolitti, né quello di Benito Mussolini e tantomeno quello di Ciampi. Questi politici italiani di diverso periodo e orientamento pensavano cose diverse, anche se spesso usavano (drammaticamente) le stesse parole, e certo gli atti politici sottesi o decisi erano enormemente diversi: anche quando, purtroppo, e qui Banti ha ragione da vendere, la cittadinanza rimane in tutti i loro periodi e sino ad oggi ispirata ai criteri dello Jus sanguinis.
Un’altra specificità nazionale, che ha ricadute immediate sulla questione della tolleranza (o meno) in Italia sta nella breve esperienza democratica del Paese. Rispetto ad altre nazioni gli italiani hanno conosciuto un periodo liberale dal 1861 al 1922 a suffragio limitati: nel 1861 solo il 2% degli italiani aveva la cittadinanza politica; la riforma del 1913 allargò in maniera significativa l’elettorato (maschile), ma bisognò arrivare al 1019 per avere il suffragio universale maschile e arrivare al 1946 per avere anche quello femminile: un po’ poco, un po’ tardi, come nascita di un’esperienza democratica di cittadinanza politica. Inoltre, il liberalismo oligarchico del periodo tra il 1861 e il 1922 contraddistinse l’Italia molto più di altri paesi. Nella Germania di Bismark c’era al tempo il suffragio universale; la Francia era a suffragio universale dal 1848, limitato nel 1850 ma subito ripristinato da Napoleone III. Gli italiani hanno avuto quindi una assai breve esperienza di voto diretto e di partecipazione politica (maschile) e poi hanno vissuto un’esperienza di fascismo totalitario (peraltro, un’invenzione italiana). Non direi, come ha detto un politico italiano che adesso versa in difficoltà economico-giudiziarie, che Mussolini sia stato il più grande statista del secolo; sicuramente è stato l’inventore di un regime che l’Italia ha esportato nel mondo. In Germania il fascismo totalitario, cioè il nazismo, è durato dal 1933 al 1945, in Italia quasi per un tempo doppio.
Gli italiani hanno avuto, inoltre, un’esperienza coloniale limitata, breve: ciononostante intensa, ‘emozionante’[20]. È durata per sei decenni, rispetto ad altri Paesi che hanno avuto una storia di colonizzazione di sei secoli, ma ha enormemente appassionato e mosso gli italiani. E la decolonizzazione delle menti, dopo la decolonizzazione politica causata dalle sconfitte belliche, non ha potuto essere radicale quanto avrebbe dovuto essere necessaria.
Tutto questo ha alimentato un’intolleranza nazionale verso gli altri, un’intolleranza verso le minoranze esterne, verso i sudditi coloniali.
Tutto ciò non può non essere messo in relazione con la breve, troppo breve, esperienza democratica degli italiani: dal 1945 ad oggi, che – rispetto ad altri Paesi – è un tempo significativamente minore. E se la democrazia è l’unica esperienza che può rafforzare la tolleranza politica, gli italiani l’hanno avuta per un tempo piuttosto breve.
Quando si ragiona sul (ri)sorgere di nazionalismi e intolleranze, chiusure ed esclusioni, in Italia, non si dovrebbe dimenticare queste ragioni di lunghissimo periodo.
Il razzismo degli italiani
In conclusione, se guardiamo alle vicende recenti da questa prospettiva di lungo periodo e multisecolare, una prospettiva che intrecci nazionalizzazione, colonizzazione e intolleranze, non dovremmo chiederci se gli italiani sono razzisti, quanto perché non dovrebbero esserlo, con questa esperienza alle spalle[21].
E questo non perché gli italiani e le italiane siano stati imbevuti, come si diceva un tempo, dalla lue razzista. È la storia, nella sua concretezza politica e istituzionale, a spiegare molto di tutto ciò: lo Stato nazionale unitario, qui arrivato in ritardo, ha dovuto con più forza che in altri luoghi insistere nel creare il cittadino italiano. Lo ha creato in base allo ius sanguinis e gli ha spiegato che aveva dei nemici acerrimi, che era un grande colonizzatore e che toccava a lui insegnare agli altri che cos’era la civiltà. È lo Stato nazionale che ha posto il problema dello straniero e del suddito coloniale, e che continua a porlo in maniera anacronistica oggi quando – come Stato nazionale – sta fallendo o ha già fallito. In effetti, sarebbe ormai tempo di riconoscere che storicamente l’esperienza dello Stato-nazione basato sull’idea di omogeneità etnica e nazionale è finita. Sarebbe necessario farlo almeno oggi, nel momento in cui la nostra società è ormai multiculturale.
Ha fallito perché c’è stata l’Unione europea, perché ci sono le regioni, perché ci sono i migranti. Per certi versi hanno ragione politici come Umberto Bossi e Matteo Salvini a dire che lo Stato nazionale è sotto attacco, se addirittura non è finito, e che dobbiamo salvarci: ma sbagliano rimanendo attaccati a idee che non sono più attuali. Come in Europa, le inclusioni così come le esclusioni odierne hanno una storia lunga, che rimonta alla costruzione dello Stato unitario, e alla storia dell’espansione europea: come in Europa, hanno radici che non possono essere sottovalutate.
Come già detto qui, non conviene pensare oggi in Italia come un secolo e mezzo fa, quando pure era rivoluzionario concedere la tolleranza agli ebrei. Oggi non è più questione di tolleranza (e nemmeno di integrazione: parola che andrebbe sottoposta a critica). È questione, più che problema, di convivenza[22] (come evoluzione e superamento della vecchia tolleranza). Non è certo con muri alti o porti chiusi che si può pensare di affrontare un problema così complesso.
Guardare al passato o guardare al futuro
Nel Paese si parla (e se ne era parlato anche in questa sede, nei gruppi di insegnanti frequentanti la Summer school da cui questo testo prende le mosse) di burqa e di divieti ad indossarlo pubblicamente.
Siamo con questo in un territorio assai delicato, al limite della richiesta di un diritto, perché sarebbe un diritto vestirsi come si vuole e anche credere come si vuole. Così come dovrebbe essere un diritto anche non credere nella metafisica e nel post-mortem. L’importante, ci pare, è che non si violi quello che è un diritto di altri.
Ma tutto ciò oggi cade nel momento del fallimento, se non della fine, dello Stato nazionale. Pensare ancora in termini di tolleranza oggi e non riconoscere i diritti degli stranieri è, alla luce di un’analisi storica, francamente intollerabile nel senso di non sostenibile.
Il problema, in questo, non è costituito soltanto dai gruppuscoli che di queste intolleranze fanno un’ideologia, un vanto e una pratica, cioè dai piccoli gruppi radicali o da coloro che in qualche modo hanno solo da guadagnare da queste teorie: il problema è se tali teorie inquinino le aree più moderate del paese, il problema è se esse conquistano un’egemonia e una maggioranza di consensi.
Si dovrebbe quindi cambiare il vocabolario politico, e forse l’obiettivo. È rilevante che la destra moderata insieme all’estrema destra abbia raggiunto la maggioranza in molti Stati europei, non solo o tanto che la piccola estrema destra (che c’è stata sempre, più o meno grande) sia arrivata al venti per cento sull’onda della crisi economica. In Europa, chi studia la geografia e la storia del voto politico osserva che dal 1945 in poi queste destre radicali hanno raccolto costantemente voti fra l’1 al 4% degli elettori. In Italia lo hanno fatto con maggior successo, e da noi c’è stato addirittura un partito nostalgico del passato fascista che è stato presente in Parlamento dal 1948 e che ha raggiunto in alcuni momenti anche il doppio di quel consenso elettorale medio europeo.
Ma questo appare agli studiosi dei movimenti radicali e intolleranti non così grave quanto il fatto che, oggi, le idee di esclusione di separazione di questi gruppi stanno inquinando il discorso politico nazionale, in diverse nazioni, nella civilissima Europa. Il punto è che queste destre possono così diventare condizionanti nei confronti delle destre moderate. Il punto è quello per cui parti del Paese, imponendo la propria agenda che è tecnicamente ‘reazionaria’ perché guarda allo Stato nazionale del passato mentre oggi esso è in trasformazione e in crisi, in un momento in cui dovrebbe invece guardare al futuro. Questa pare essere la novità storica, e proprio il contrario di quello che si dovrebbe fare.
Purtroppo non sempre si ha consapevolezza di questo chiasmo, di questo paradosso: mentre il mondo cambia, v’è chi guarda ancora al passato.
Ciò che quindi pare preoccupante per chi guarda a queste vicende da una prospettiva storica è il cosiddetto senso comune, quello che ‘la gente’ pensa, le idee diffuse, le sciocchezze divulgate, le battute di spirito che non dovrebbero far ridere (anzi, fanno piangere se ci si pensa davvero). Purtroppo fanno piangere solo chi ci ha pensato, gli altri continuano a ridere.
Conviene ripetere in conclusione che non è che gli italiani siano intolleranti o razzisti: ci si dovrebbe invece chiedere, in Italia, perché dovrebbero non esserlo.
Una prospettiva di riconoscimento, di democrazia, di sviluppo, di Europa – perché solo in Europa è possibile pensare soluzioni per alcuni degli enormi problemi che stanno di fronte allo Stato nazionale e ai suoi cittadini – sorge invece dalla conoscenza della storia è la stessa prospettiva che ci fa vedere come gli intolleranti, anche in Italia, non sono un accidente o un caso fortuito legato a questo o a quell’errore di questo o quell’uomo politico o una quantità trascurabile: sono lo sbocco (ovviamente, mai inevitabile, come sempre nella storia) di un lungo passato.
Ciò detto, è bene che gli italiani sappiano che nell’Europa contemporanea e del post-Guerra fredda siamo la prima grande nazione democratica ad avere al governo forze di estrema destra. Gli intolleranti non sono la rivelazione del carattere degli italiani, sono il prodotto di una storia, delle dinamiche dello Stato nazionale, di una congiuntura: e, purtroppo, anche della povertà delle alternative.
Note:
[1] Il riferimento è, in particolare, all’opera La nazionalizzazione delle masse. Simbolismo politico e movimenti di massa in Germania (1812-1933), Bologna, Il Mulino, 1975
[2] Eric J. Hobsbawm, Nazioni e nazionalismo dal 1780. Programma, mito, realtà, Torino, Einaudi, 1991;
[3] Eric J. Hobsbawm, Terence O. Ranger (a cura di), L’invenzione della tradizione, Torino, Einaudi, 1987.
[4] L’autore di queste pagine si permette di rinviare, fra l’altro, ai suoi Oltremare. Storia dell’espansione coloniale italiana, Bologna, il Mulino, 2002; Guerre contemporanee. Dal 1945 ad oggi, Firenze, Giunti, 2008; Guerre vecchie, guerre nuove. Comprendere i conflitti armati contemporanei, Milano, Bruno Mondadori, 2009.
[5] Recentissimo Andrea Graziosi, Il futuro contro. Democrazia, libertà, mondo giustoBologna, il Mulino, 2019.
[6] Tommaso Detti, Giovanni Gozzini, L’ età del disordine. Storia del mondo attuale 1968-2017, Roma Bari, Laterza, 2018.
[7] Eugen Weber, Da contadini a francesi: la modernizzazione della Francia rurale, 1870-1914, Bologna, Il Mulino, 1989.
[8] Ad esempio cfr. Ulrich Wehler Nazionalismo. Storia, forme, conseguenze, Torino, Bollati Boringhieri, 2002.
[9] Colin Crouch, Postdemocrazia, Roma-Bari, Laterza, 2003.
[10] Jurgen Habermas, La rivoluzione in corso, a cura di Mauro Protti, Milano, Feltrinelli, 1990.
[11] Maria Laura Lanzillo (a cura di), La questione della tolleranza : gli autori, i dibattiti, le dichiarazioni, Bologna, Clueb, 2002.
[12] Maria Laura Lanzillo, Tolleranza, Bologna, il Mulino, 2001.
[13] Cfr. ancora Histoire de la France coloniale, in due volumi (il primo J. Meyer, J. Tarrade, A. Rey-Goldzeiguer, J. Thobie, Des origines à 1914, Paris, Colin, 1991; e il secondo J. Thobie, G. Meynier, C. Coquery-Vidrovitch, C.-R. Ageron, 1914-1990, ivi, 1990).
[14] Robert Paul Wolff, Barrington Moore Jr., Herbert Marcuse, Critica della tolleranza, Torino, Einaudi, 1968.
[15] Frantz Fanon, I dannati della terra, prefazione di Jean-Paul Sartre, Torino, Einaudi, 1962; e Id., Opere scelte, a cura di Giovanni Pirelli, prefazione di Giovanni Jervis, Torino, 1971.
[16] In particolare Maria Laura Lanzillo (a cura di), La questione della tolleranza : gli autori, i dibattiti, le dichiarazioni, cit.
[17] Giovanni Gozzini, Le migrazioni di ieri e di oggi : una storia comparata, Milano, Bruno Mondadori, 2005.
[18] Francisco Bethencourt, Razzismi. Dalle crociate al ventesimo secolo, Bologna, il Mulino, 2017.
[19] Alberto Mario Banti, Sublime madre nostra. La nazione italiana dal Risorgimento al fascismo, Bari-Roma, Laterza, 2011
[20] Nicola Labanca, Oltremare, cit. Così come tutta l’opera di Angelo Del Boca, da Gli italiani in Africa Orientale, Laterza, Roma-Bari 1976-84, e Gli italiani in Libia, ivi, 1986-88, a Italiani, brava gente?, Vicenza, Neri Pozza, 2005.
[21] Sempre esemplare, a nostro avviso, Paola Tabet, La pelle giusta, Torino, Einaudi, 1997.
[22] Francesco Remotti, Somiglianze. Una via per la convivenza, Roma-Bari, Laterza, 2019.



















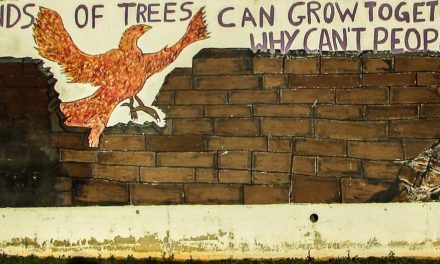


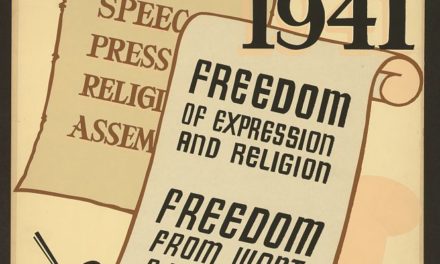
 L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore
L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino
Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio
Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa
Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa Storia passionale della guerra partigiana di Chiara Colombini
Storia passionale della guerra partigiana di Chiara Colombini Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice
Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli
Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli L’arresto degli arlecchini
L’arresto degli arlecchini