
La “trista historia” delle ore di storia
Alla conclusione di un anno così particolare – per il quale l’aggettivo drammatico non è scelto per effetti di retorica spicciola – abbiamo deciso di proporre una riflessione dai toni leggeri. Un modo per farvi sorridere, insomma. Valentina Petri, l’autrice, è un’insegnante vercellese affatto sconosciuta al pubblico dei docenti italiani. Classe 1977, ha studiato presso il Liceo Classico Lagrangia e si è laureata in Lettere Moderne presso l’Università del Piemonte Orientale. Ha iniziato a insegnare nel 2006, dopo molti anni alla scuola secondaria di primo grado. Di ruolo dal 2012, ha preso servizio presso l’istituto Professionale Francis Lombardi di Vercelli, dove tuttora lavora.
Blogger per diletto, dal 2017 gestisce la pagina Facebook Portami il diario, che oggi conta più di 52.000 followers. Nel mese di settembre 2019 uno dei suoi post è stato letto a Recanati – in occasione dell’inaugurazione del Colle dell’Infinito ad opera del FAI –, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Scrive e commenta l’attualità del mondo della scuola su un blog de «Il Fatto Quotidiano». A maggio scorso è uscito per Rizzoli il suo primo romanzo, Portami il diario – la mia scuola e altri disastri.
Le abbiamo chiesto di raccontarci cosa succede nelle sue ore di storia. E lei lo ha fatto con il tono ironico che è nel suo stile.
Non c’è niente che ti faccia capire qual è il tuo posto nel mondo, a scuola, più del momento in cui, a settembre, scopri come sono state spartite le cattedre. In genere si tratta di una situazione di cui prendere atto e basta, senza manifestazioni di piazza o moti di rivolta: inspiri, la accetti e dici “Obbedisco”. Un po’ come l’attribuzione del cassetto in sala insegnanti: non hai possibilità di sceglierlo, prendi sempre quello che è rimasto e che ti hanno lasciato gli altri. Gli altri scelgono il meglio. E il meglio, è ovvio, è italiano. “La cattedra” è la cattedra di italiano. Mica quella di storia e geografia. Anche agli amici, quelli a cui hai il coraggio di dire che lavoro fai, e che ti chiedono: “Cosa insegni?” tu rispondi, per far prima: “Italiano. Lettere”.
Alle medie soprattutto, ma anche alle superiori, negli istituti in cui non c’è la separazione tra italiano e storia e filosofia, la materia principe, la disciplina cardinale, l’asso pigliatutto, resta sempre l’italiano. Persino i genitori, quando iniziano a baccagliare tutti gli open day, dossierando le scuole, le offerte formative, prendendo informazioni sui corsi facoltativi di balalaika e i potenziamenti di lancio del giavellotto, prendendo appunti sugli orari, la composizione classi e l’attribuzione dei docenti, si fanno sempre tra loro l’immortale domanda: “E di italiano, sai già chi avranno?”. Tutto il resto è noia.
Il triste fato delle ore di storia è una trista historia. Le ore di storia sono dei rimasugli da usare come tessere da incastro per comporre il quadro orario e raggiungere il fatidico numero delle invidiatissime 18 ore, quelle che, nell’opinione pubblica, sono le uniche trascorse dai docenti italici a lavorare e non a sorseggiare flute di spumante in riva al mare. Addirittura, questo pacchetto di ore viene talvolta accorpato creando mostruose cattedre in cui lo sventurato si ritrova a dover trasmettere soltanto le sue conoscenze di storia: diciotto dico diciotto ore, tutte di storia e geografia. Le ho avute anch’io queste cattedre-rimasuglio, in cui entravo e uscivo da tutte le classi in modo compulsivo: tre mesi per abbinare i nomi alle facce e la punizione dantesca di parlare sempre e soltanto praticamente di un’unica materia, ma non seguendo un seppur vago ordine cronologico, no, saltando avanti e indietro nel tempo che neanche il Dottor Who. Certo siamo tutti d’accordo che lavorare in una cava di pietra con una palla al piede sotto il sole di agosto sia probabilmente parecchio più faticoso, ma io ricordo ancora con orrore certe mattine in cui dalle otto alle nove spiegavo la rinascita dopo l’Anno Mille, dalle nove alle dieci il fascismo, dalle dieci alle dodici per due lunghissime ore le guerre di religione del Cinquecento, e l’ultima ora, tanto per non farsi mancare niente, un bel ripasso dei regni romano-barbarici. Uscivo da scuola sinceramente stupita dell’esistenza delle automobili e sufficientemente rintronata da farmi investire. E ci vuole anche una bella elasticità mentale eh, senza neanche un’ora di tregua, lì in mezzo, per spiegare la subordinata temporale o fare una rinfrescante parafrasi. Tutto questo, poi, davanti a un uditorio che nel migliore dei casi mostra garbato disinteresse e nel peggiore una fiera opposizione, palesata da gesti che simulano il suicidio.
In particolare, nei ruggenti anni delle medie, ho avuto un alunno dallo spiccato senso dell’arte drammatica che mi ha sempre manifestato con fantasia il suo disamore per la storia. Probabilmente ce l’abbiamo avuto tutti, prima o poi, uno che il primo giorno di scuola, appena ti vede, ti si avvicina con l’aria di uno che vuole soltanto rendersi utile e ti dice, pacato “Io, comunque, prof, volevo dirle che la storia la odio”. Ecco. Lui, capelli lisci da samurai tenuti fermi da un codino mozartiano, occhi affilati e sopracciglia molto più espressive di un sacco di attori hollywoodiani, era esattamente il prototipo dello studente che ti fa pregare di notte, con fervore manzoniano, sperando di vederlo assente a lezione. Lui era l’Impermeabile. Non c’era lezione, periodo, personaggio storico in grado di smuovergli la benché minima curiosità. Non aveva niente di personale contro la mia persona, semplicemente, ho imparato ben presto a non immergere i miei occhi nei suoi durante la lezione, a meno di non desiderare di sprofondare in un abisso di profonda depressione capace di minare la mia autostima di insegnante. Era diventato una sfida, tra me e l’Impermeabile. Non ambivo a fargli amare la materia, ma quanto meno a fargli alzare gli occhi da quel suo quadernetto dove passava il tempo a schizzare disegni. Anche piuttosto bellini. Gli alunni più faticosi rivelano sempre talenti accuratamente nascosti, da loro stessi per primi. Io mi preparavo monologhi appassionati, rubavo ai grandi divulgatori le curiosità più golose, davo sfoggio di abilità tecnologiche preparandomi slide, spezzoni di film in costume, frammenti di documentari. Sarei arrivata a chiedere a un vecchio compagno di studi, oggi collezionista, di prestarmi una spada medievale, per tentare di colpire la sua immaginazione, o in alternativa il mio petto in un estremo gesto di disfatta. C’è giusto questo problema che a scuola non si possono portare le armi, quindi ho dovuto desistere, ma resto dell’idea che sarebbe stata una mossa niente male. Tuttavia, nulla. Il massimo che ho ottenuto è stato uno sbadiglio da far impallidire l’Urlo di Munch. Gli piacevano molto le morti celebri, però. Quindi non era Impermeabile del tutto, perché aveva cominciato ad accogliere il mio ingresso in classe manifestando la sua sincera insofferenza per la storia e ogni volta che entravo in aula accompagnava il mio tragitto porta-cattedra producendosi in tremende convulsioni. Mi diceva che si sentiva come Alessandro Magno in preda alle febbri malariche, anche se poi accusava il suo compagno di banco di avergli avvelenato la coca cola; si contorceva in preda ai deliri vagheggiando le sue legioni perdute a Teutoburgo come Augusto. La cosa in qualche modo deve averlo divertito e sono convinta che, con il tempo, qualche cosa deve aver imparato dalla mia materia perché una volta si è fatto accoltellare con i righelli ventitré volte come Cesare, mentre un’altra volta si è accasciato sul banco con la sciarpa in testa mimando la morte di Marat. Chissà cosa si sarà inventato l’anno successivo, non lo saprò mai perché il rio destino della supplente è quello di portare avanti il lavoro di qualcun altro e lasciarlo prima che sia compiuto. Una grande lezione di storia anche questa, a ben pensarci.
Questo per dire che l’insegnamento della storia, nelle patrie scuole superiori di primo e secondo grado, è da sempre un po’ considerato non dico un ripiego, ma una notevole seccatura, dovuta principalmente al fatto che il programma è mostruoso, il tempo sempre meno e le incombenze burocratiche – che implicano interrogazioni, valutazioni, compilazioni di griglie contenenti non meglio precisati obiettivo – sempre più asfittiche e impegnative. In più, un po’ questi benedetti ragazzini hanno anche ragione. Hanno passato tre anni, alla scuola elementare, a studiare gocce di storia in minuscole pillole. L’intera terza elementare è dedicata a quei bestioni estinti che vanno sotto il nome di dinosauri e alle meraviglie della preistoria. In quarta affrontano una carrellata confusa di antiche civiltà sulle quali troneggiano i greci, mentre in quinta finalmente scoprono l’esistenza dei romani. Chi scrive è una fiera sostenitrice del fatto che una volta, quando le elementari erano più povere e non c’erano i corsi di pittura su ceramica e cucina macrobiotica, lo studio sommario ma continuativo del periodo che andava dall’antichità alla storia contemporanea fosse, con tutti i suoi limiti e la sua aneddotica, una buona idea. Adesso invece i ragazzini delle elementari hanno tre anni a disposizione per farsi l’idea che la storia sia quella materia fatta di schemoni e mappe concettuali colorate, piena di date, piena di nomi e piena di gente morta da un sacco di anni.
Tranne per qualcuno, eh, perché il piccolo nerd appassionato c’è sempre. Ce l’abbiamo avuto tutti, in classe, uno che vive per i dettagli. Me n’è capitato più d’uno, in classe, di quelli che non vedono l’ora di coglierti in fallo e di dimostrare la loro competenza acquisita nel corso di svariate letture alternative di cui tu, docente ignaro, non sei a conoscenza. Quegli alunni che sanno esattamente quanti opliti sono stati schierati in ciascuna delle guerre persiane, quanti carri armati sono stati necessari per valicare le Ardenne, quante volte Mazzarino era solito soffiarsi il naso mentre conferiva con la reggente al trono. Io ho avuto un alunno micidiale, una macchina da guerra, con occhiali alla Harry Potter, ciglia chilometriche e occhi di bragia, che non mi ha dato tregua per un lunghissimo anno scolastico, il primo in cui ho ottenuto l’incarico annuale. Ha trascorso il tempo chiedendomi dettagli su ogni cosa. Ero arrivata a farmi persino i bigliettini, come gli studenti che copiano, cercando di prevenire le sue domande. Ogni azione militare io abbia avuto l’ardire di nominare era oggetto di approfondita analisi, mentre il resto della classe si divideva tra coloro che stramazzavano svenuti sul banco e quelli che prendevano i pop corn per godersi il mio tentativo di svicolare dalle sue grinfie. Un giorno in cui mi ero sentita piuttosto efficace, divulgativa ma precisa, dopo aver riempito lavagne piene di campagne belliche, battaglie, trionfi e cadute, ho sentito il suono della campana e ho assaporato per un attimo, come Napoleone, il profumo della vittoria. Invece nell’intervallo mi si è avvicinato, fiero e sfacciato, e mi ha detto che comunque avrei anche potuto spiegare il perché Napoleone avesse l’abitudine di portare la mano infilata nel panciotto. Ho capito come dev’essersi sentito il Corso a Waterloo.
Ma non è colpa mia né di nessuno, storia la si deve fare sempre in fretta, correndo come se un giaguaro affamato ci stesse alle calcagna. Secoli e secoli da macinare senza sosta, valutando, recuperando, semplificando, schematizzando e naturalmente personalizzando perché, si sa, la didattica è inclusiva, al centro c’è lo studente e noi siamo bravissimi. In questa corsa a ostacoli, secondo la meravigliosa periodizzazione voluta dalle ultime riforme, i nostri studenti arrivano alla veneranda età di tredici anni a scoprire chi diavolo fosse gente come Garibaldi. A volte, se il percorso scolastico è stato un po’ accidentato, la scoperta arriva più tardi. Prendiamo il caso del pluribocciato. Egli è un personaggio leggendario che alberga in ogni scuola secondaria inferiore di primo grado. Egli è più alto della media. Ha alle spalle vicende di vario tipo, ampiamente dibattute durante svariati consigli di classe, ordinari e straordinari; ha visto le sue prodezze narrate su registri cartacei e digitali; ha alimentato la sua fama raccontando alle nuove leve sempre nuovi e truculenti dettagli. Se è stato ammonito per aver inciso la superficie del banco, tre anni dopo racconta in giro di aver istoriato con la lama del serramanico l’avambraccio del suo compagno di banco, solo perché questi aveva avuto l’ardire di non lasciargli copiare la verifica sui Longobardi. Fatto sta che il pluribocciato, spesso, arrivato fortunosamente in terza media che ormai ha l’età per guidare la moto, la voce di un baritono verdiano e un accenno di barba, decide di dedicare la sua piena attenzione ad alcune lezioni, così, tanto per provare nuove esperienze. Ed è stato in uno di questi momenti di grazia che io, ad una mia terza media, ho iniziato una lezione di storia del Risorgimento, esaltandomi per questo momento di storia patria. Ad un certo punto immagino di non aver potuto fare a meno di citare la spedizione dei Mille (quella vera, non quella che si fa abitualmente al cambio d’ora per andare ai servizi) e la figura di Garibaldi. L’ho visto sobbalzare, il pluribocciato. L’ho visto alzare lo sguardo verso di me. L’ho visto alzare la mano. Tenendo conto che non stava per chiedermi di uscire – in genere, si alzava e usciva, perché chiedere? –, gli ho concesso facoltà di parola con viva curiosità. E lui mi ha detto “Prof? Ma lo sa che io abito in via Garibaldi? E non ho mai saputo chi fosse!”. E’ stato un bel momento, di quelli in cui senti che il tuo lavoro ha un senso. Però forse bisognerebbe riflettere anche sul senso di presentare certe vicende così tardi, nel programma.
Fortuna che alle superiori si rifà tutto da capo. Almeno al professionale, dove insegno io, è così. Cinque lunghi anni davanti per erudire i cittadini di domani su tutte le più importanti questioni storiche mai affrontate. Però è come negli esercizi di giocoleria, dove a ogni livello si inseriscono anche nuovi elementi di difficoltà. Infatti, misteriosamente, gli alunni aumentano e le ore diminuiscono. Sono sinceramente stupita che non ci diano un hula hop da far girare alla caviglia. Il primo anno, tagli di qua e taglia di là, di storia c’è un’ora. Il programma prevede di passare dal Big Bang all’ascesa di Ottaviano Augusto. Lo ripeto piano piano scandendolo. Anche liquidando a settembre qualche milione di anni in qualche milione di schemi, restano otto mesi. Facciamo due conti, che non è mica vero che gli umanisti non sanno fare le quattro operazioni. 1 ora a settimana per 8 mesi= 32 ore mal contate perché poi ci sono feste e ponti e sagre e balli a palchetto. Dal 3500 avanti Cristo, così a spanne, fino alla battaglia di Azio sono comunque 3438 anni. Altro che Azio, viene da dire. 3438 diviso 32 ore fa circa 107 anni a lezione. Io dovrei entrare, fare l’appello velocissima e spiegare non meno di 107 anni per volta. Se poi ho intenzione di somministrare una verifica, perché le verifiche si somministrano come le supposte di tachipirina da mille, la volta dopo devo parlare come i Cipmunks a velocità doppia e spiegarne 214. A me prende un po’ l’affanno certe volte. Una lotta impari, che in confronto i trecento spartani contro tutti quei persiani avevano solo delle balle nonché poco da lamentarsi, che ci sono battaglie perse in partenza decisamente più faticose. Al triennio, però. E’ lì che finalmente una si sente arrivata. “Dove insegni?”. Al triennio. E’ una cosa tipo notte degli Oscar, lo dici articolando bene le sillabe e lanciando sguardi di commiserazione a quei tapini che ancora arrancano con gli Assiri e i Babilonesi che sfuggono sulla carta muta come palline di mercurio. Tra l’altro questo esercizio di mettere davanti a dei preadolescenti, abituati a ricorrere a Google maps, le cartine mute è una crudeltà gratuita che deve finire. Io l’ho fatto per anni, ritrovandomi a correggere gli elaborati sotto effetto dell’alcol, per sopportare la vista della penisola iberica piazzata in Scandinavia e del Reno disegnato lì a scorrere gaio e felice tra i Balcani.
Al triennio hai di fronte studenti che studiano storia ormai da qualche anno, che dovrebbero dimostrare dimestichezza con la disciplina, con il suo lessico specifico, con tutta la cassetta degli attrezzi che serve per affrontare i dieci secoli che li separano dall’esame di maturità. Me la ricordo, la mia prima lezione di storia in una terza superiore. Al professionale, eh, ma non so quanto siano diverse le altre scuole.
Settembre, il tepido calore di una tarda mattinata, il sole che entra dalla finestra. Io che non vedo l’ora di lanciarmi in un appassionato monologo ispirato a quei mille video del professor Barbero – che sia benedetto ora e sempre! –, certa di catturare l’uditorio come fa lui quando gesticola e potrebbe parlare anche del mio vicino di casa, tanto lo ascolteremmo tutti rapiti lo stesso. Gli alunni, invece, preferirebbero sul serio sapere qualcosa del mio vicino di casa, che tra l’altro è un tizio misterioso e non so bene che lavoro faccia. Uno di loro mi guarda, con l’aria perplessa dell’orata messa su di un letto di ghiaccio in pescheria, e poi mi chiede: “Scusi, ma lei, cosa insegna?”. “Storia” rispondo piuttosto sicura. “No”, ribatte, piuttosto sicuro anche lui. Ora, va bene che insegnare significa mettersi in discussione, ma non credo si intenda fino a questo punto. Poi chiarisce: “No, lei insegna italiano a quelli di quarta”. Che è vero. Mi dimentico sempre che per gli studenti noi sappiamo una cosa sola. Non ci chiederebbero mai un consiglio su di un’altra materia, per loro non abbiamo fatto un percorso di studi monografico che ci ha imposto di conoscere solo e soltanto una disciplina. Che un docente di italiano sappia risolvere un’equazione di secondo grado o si ricordi un verbo irregolare inglese non è una cosa da prendere in considerazione. Quindi se io insegno italiano, italiano sia. “E poi, scusi, prof, ma è sicura che ci sia ancora storia, nel triennio? Ma davvero? E c’è da comprare il libro? Ma io pensavo avessimo finito!”. Tanto per iniziare l’anno scolastico con una bella iniezione di entusiasmo. E poi, prima ancora che io abbia avuto modo di rassicurarlo, quanto meno sulla necessità di acquistare il libro, ecco zan, la grande domanda: “E a cosa serve? Tanto sono tutti morti”. Dàgli torto.
Al triennio i sedicenni e i sedicenti sedicenni costituiscono affollatissime classi multietniche in cui per mesi tu, docente di storia, la smetti di insegnare la tua materia e ti metti a fare catechismo, perché di fronte hai una platea di gente che non ha la più pallida idea di cosa tu stia parlando mentre infili uno dietro l’altro concetti teologici imprescindibili per comprendere il Medioevo.
Spiegare la lotta per le investiture a certe fanciulle che hanno in mente soprattutto la propria manicure diventa una delle più faticose torture tra le svariate disavventure che la funzione docente comporta. Perchè sì, il medioevo è un sacco affascinante quando te lo racconta Alberto Angela – sempre sia lodato! – ma diventa una sòla micidiale a meno di non farlo passare per le maglie di qualche videogioco a tema.
Ce li ho, in classe, i nerd appassionati di videogiochi storici che non hanno la più pallida idea di quando il medioevo si collochi ma saprebbero giostrare in un torneo meglio di Ivanohe, se solo gliene dessimo la possibilità. Ecco, dovremmo introdurre le rievocazioni storiche, a scuola, come materie curricolari, quanto meno per la possibilità che si tramortiscano tra loro con una lancia e stiano buoni buoni nel banco per un po’. Anche perché spesso la dotazione è sempre quella, ardesia, gesso e tanta simpatia, quindi non è che le lezioni siano interattive più di tanto. Invece dovremmo. Perché ormai ci chiedono mica di instillare conoscenze (e te credo, con 107 anni a botta, cosa mai potrò infondere? Posso giusto provare con l’imposizione delle mani), ma di far acquisire competenze. Che io mi sono sempre chiesta, ma in storia, cosa faccio acquisire? Mica dobbiamo insegnar loro a maneggiare una clava (ci riescono già benissimo nell’intervallo, usando gli ombrelli), né a mummificare un compagno (anche questo riuscirebbero a farlo, se solo nei bagni della scuola pubblica ci fosse la carta igienica). No, credo che si tratti più di una questione di competenze educative. Infatti tutti i progetti che vanno sotto il roboante nome di “educazione a” finiscono inesorabilmente nelle ore di storia. Tanto sono moltissime, come no. Ogni tanto qualche governo, in modo assolutamente bipartisan, si rende conto che gli studenti devono essere maggiormente educati in qualcosa: lo studio della costituzione, il diritto, la cittadinanza, la convivenza civile, ma anche la conoscenza del cammino dei diritti dei lavoratori, la parità di genere, l’educazione all’affettività, e non ultima anche la buona educazione. Si annuncia in maniera roboante l’inserimento di questi innovativi concetti nei programmi scolastici, ci si bulla di non gravare sulle casse dei contribuenti e si precisa, con scrittine piccolissime come quelle che ci sono in fondo ai contratti truffaldini, che il tutto è da considerarsi parte di un pacchetto unico con le ore di storia. Le stesse ore in cui, con passo da bersagliere, devo mitragliarli di conoscenze, che non hanno poveretti, per arrivare a finire dignitosamente il programma in quinta provando magari ad arrivare un po’ più in là del mitico secondo dopoguerra (ma il secondo quadrimestre della quinta è sempre piuttosto affollato di vacanze, gite, escursioni, sempre che non ci si metta di mezzo anche una pandemia e ci si ritrovi tutti a casa ad arrancare con le connessioni zoppe. Non ci si crede, ma succede). Io poi ci credo se ‘sti ragazzini la storia un po’ non la capiscono, un po’ non la amano. Anzi, ancor di grazia se di tanto in tanto ce n’è uno che sia appassiona e ci strema con le domande, ci sfianca con i suoi interrogativi, ci sfinisce con le sue curiosità. Sarebbe già tanto se almeno restassero quelle.
Tipo la storia del povero Napoleone, che metteva la mano nel panciotto a massaggiarsi il petto perché aveva la gastrite.
Chissà se Napoleone ha mai fatto lezione di storia, al professionale, al pomeriggio.
Mica è venuta solo a lui, la gastrite.























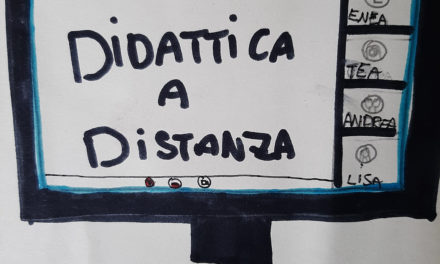
 L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore
L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino
Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio
Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa
Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa Storia passionale della guerra partigiana di Chiara Colombini
Storia passionale della guerra partigiana di Chiara Colombini Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice
Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli
Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli L’arresto degli arlecchini
L’arresto degli arlecchini