
Il cinema a scuola: quale esperienza e quale metodologia? Riflessione sulla memoria della Shoah tra visibilità e invisibile
Scena tratta dal finale di Au revoir les enfants, di Louis Malle (Francia, 1987).
Screenshot dell’autrice.
Abstract
L’educazione all’immagine come pratica e come riflessione sul mondo contemporaneo. La messa in crisi di alcune pratiche didattiche che riducono il cinema a veicolo di mero contenuto, per favorire al contrario uno sguardo complesso su quello che è un linguaggio specifico e un’arte da decodificare e comprendere dal punto di vista estetico e formale. Quali interrogativi pone in particolare il cinema della Shoah? L’impossibilità di rappresentazione di quel che è stato e l’etica della narrazione pongono una riflessione ulteriore sul confine tra visibilità e invisibile, sul limite dello sguardo, per sfuggire a banalizzazioni o, peggio, spettacolarizzazioni sul tema. Fondamentale è il ruolo e la consapevolezza dei docenti nel proporre alle giovani generazioni alcuni esempi, ma anche una rinnovata metodologia didattica che ponga il “visuale” nella giusta considerazione.
___________________
Image education as practice and as reflection on the contemporary world. The questioning of certain didactic practices that reduce cinema to a vehicle of mere content, in order to favour, on the contrary, a complex look at what is a specific language and an art to be decoded and understood from an aesthetic and formal point of view. What questions does the cinema of the Shoah pose in particular? The impossibility of representing what it was and the ethics of narration pose further reflection on the boundary between the visible and invisible, on the limit of the gaze, in order to escape trivialisation or, worse, spectacularisation on the subject. Fundamental is the role and awareness of teachers in proposing examples to the younger generations, but also a renewed didactic methodology that places the ‘visual’ in its proper consideration.
PREMESSA: Il mondo delle immagini
Le immagini oggi sovrastano le parole nel mondo della comunicazione e la scuola non può non tenerne conto. Guardare una fotografia e guardare una parola scritta o una frase implicano uno sguardo totalmente diverso, la mente è chiamata a operazioni intellettive diametralmente opposte. Un tempo si era chiamati a studiare per lo più testi scritti, i manuali erano quasi privi di immagini, l’attenzione si concentrava sul significato veicolato attraverso i segni sulle pagine, lettere/grafemi/parole/frasi appunto. Quando capitava di incappare in una foto ci si fermava a guardare, ma sembrava comunque un elemento puramente accessoria allo scritto. Oggi la scuola procede in un certo senso ancora in questa direzione, anche se i libri di testo offrono apparati iconografici e audiovisivi sofisticati, impensabili fino a qualche decina di anni fa, per non parlare della rete: la didattica procede per lo più “a parole” scritte e orali, eppure le immagini pongono un cambiamento di forte impatto, secondo un processo inarrestabile, spostando il discorso su un piano totalmente altro.[1]
I ragazzi e le ragazze su questo sono in realtà interlocutori perfetti, perché sono in qualche modo sia artefici che fruitori dello stesso cambiamento in atto, essendo nati e cresciuti dentro un orizzonte visuale. Il mondo visibile appartiene a loro in tutti gli ambiti comunicativi dai video su Instagram o TikTok agli emoticon su Whatsapp e ci si chiede: ne sono consapevoli? Stanno perdendo le parole? Come la scuola assume il ruolo di guida sulla strada della consapevolezza critica/interpretativa del linguaggio delle immagini? Quanto la didattica è pronta e preparata a cambiare sé stessa, a non continuare ad essere solo verbale? Quanto i docenti sono consapevoli che non basta preoccuparsi del testo scritto o che il proprio ruolo assume nuovi contorni?
Talvolta la scuola è interprete attiva dei cambiamenti che avvengono nella società; spesso è chiamata ad attrezzarsi più o meno rapidamente per fornire le risposte adeguate a questioni estremamente attuali, urgenti e delicate, ma in questo caso sembra mostrare qualche difficoltà. Spesso il visuale entra nella scuola ancora per il contenuto, come se si potesse trascurare il linguaggio specifico, l’importanza formale-estetica, gli effetti più profondi che lo veicolano e allo stesso tempo lo fondano.[2] Ignorare la portata, i contorni, le potenzialità dell’educazione all’immagine si traduce in un arretramento, in un impoverimento, in un impossibile conservatorismo senza senso, in un rifiuto di qualcosa che in realtà è già in atto e che pone diversi interrogativi (come l’isolamento del soggetto nel mondo perennemente interconnesso). Da parte della scuola l’assunzione di un ruolo, di una responsabilità su questo piano è in realtà decisivo.
C’è forse un ritardo? Dipende, perché alcune scuole (o per lo meno alcune classi) sono all’avanguardia, mentre altre molto meno. E questo avviene mentre nella comunicazione e nella società tutto procede ad una velocità incredibile, tra continui aggiornamenti e sperimentazioni in tutti gli ambiti.
La scuola oggi offre momenti, occasioni, progettualità, anche molto importanti, ma in maniera ancora sporadica (non strutturata nel curriculum), in cui l’audiovisivo o la fotografia o l’arte sono veicolo di analisi e creatività, pur non conquistando il centro dell’attenzione. La didattica non si interroga a sufficienza su cosa sia il ‘pensiero visuale’, il processo che mette in atto o fa dell’immagine il centro della propria azione e non solo l’ancella di contenuti verbali. Scardinare a poco a poco la programmazione tradizionale, il linguaggio della metodologia adottata, le lezioni in aula, favorendo trasversalità e pensiero critico diviene però quanto mai cruciale.
Non si può continuare a far riferimento allo studio per lo più di pagine scritte, occorre sollecitare una riflessione critica che cammini anche per immagini, per suoni e immagini. Le parole naturalmente saranno sempre fondamentali, chiamate a tradurre la realtà che nell’immagine trova più immediata rappresentazione; le parole sono quanto mai necessarie per decodificare, offrire interpretazione, tradurre appunto. Anche perché spesso si tratta di avere a che fare con ciò che è irrappresentabile o non-visibile: tradurre in parola l’invisibile e l’immaterialità di ciò che l’immagine nasconde o semplicemente non-mostra, il fuori-campo; darle parola significa, dunque, comprenderla.
Occorre davvero interrogarsi per pensare la didattica attraverso una comunicazione “non verbale”, diversa per modalità e impatto: un film, una foto, un’opera d’arte non come evasione dalla routine di pagine scritte, di lezioni frontali, ma come documento su cui impiantare lo studio, la riflessione, la scoperta e la ri-creazone di quanto appreso. Forse questo potrebbe portare all’auspicato apprendimento, che dell’insegnamento è connubio indivisibile, nel segno del coinvolgimento attivo dei soggetti implicati.
CINEMA E SCUOLA
Se quanto espresso in premessa è riconosciuto come reale, il cinema in quanto arte delle immagini in movimento può essere d’aiuto, a patto che lo si guardi nella giusta prospettiva.
Ai nostri giorni le sale cinematografiche sono piuttosto disertate dalle nuove generazioni che fruiscono dei prodotti audiovisivi, dei media in genere, in tutt’altro modo rispetto al passato: l’uso contemporaneo di più mezzi di comunicazione; i tempi da una parte ridotti (le visioni sono brevi e accelerate) e dall’altra dilatati (si vede sempre e ovunque) di una generazione sempre connessa; la mole di offerta via computer, smart tv, cellulare di un numero sempre crescente di film, serie, videoclip ecc. portano necessariamente altrove.[3] I ragazzi e le ragazze sono da una parte ‘esperti’ e dall’altra immersi senza coscienza critica in una dimensione totalmente visiva che solo apparentemente dominano (quanto ne sono in realtà dominati?). I passaggi continui di informazioni sembrano non richiedere la rielaborazione personale, la scelta consapevole, il confronto critico, se non in rare occasioni.
Tornare in sala o far entrare il linguaggio cinematografico in aula può allora voler significare avvicinare ragazze e ragazzi a una dimensione di approfondimento di ciò che credono già di conoscere, privilegiare la trasversalità e il pensiero critico. Gli aspetti di scoperta di uno sguardo diverso sulla realtà circostante e sulle proprie conoscenze acquistano così un enorme valore, dentro una dimensione di confronto e dialogo che talvolta sembra dimenticato.
L’essenziale non è solo ciò che si vede, ma soprattutto come. Chiedersi perché alcuni film o video colpiscono, significa capire ad esempio come sono fatti.
Sul piano della didattica occorre allora ripensare alcune pratiche, studiare e aggiornarsi: le scelte degli insegnanti di cosa mostrare, di come farlo e con quali strumenti diventano di fondamentale importanza nella valorizzazione anche di un patrimonio che è a nostra disposizione. Non si tratta più di andare al cinema come evasione dalla routine scolastica, o per rispondere alle richieste di un Calendario civile che richiede di essere in qualche modo rispettato, ma cogliere l’occasione per un vero coinvolgimento delle nuove generazioni in una dimensione di esperienza importante di scoperta, stupore e conoscenza: lo si fa insieme. Si parte da una pratica che sembra apparentemente non originale, si giunge ad effetti di meraviglia che l’arte di per sé suscita. E se da una parte ci chiediamo: quanti giovani sanno davvero guardare un film? Dall’altra ci interroghiamo su quanti docenti siano in grado di procedere senza far errori su un terreno anche per loro solo in apparenza conosciuto.[4]
In realtà in molti casi si tratta di cambiare stile d’insegnamento. Occorrono alcuni passaggi essenziali su cui riflettere. Si prepara la visione di un film in sala, si sceglie esattamente l’opera da mostrare, si pone l’attenzione su alcune scelte stilistiche, si fa conoscere il contesto dentro cui è stato prodotto quel film, si ascoltano le osservazioni dei giovani fruitori e si apre una dimensione di scambio non indifferente: l’operazione è complessa e l’insegnante è chiamato a privilegiare una complessità che rischia altrimenti – se non la distorsione – almeno la semplificazione (nella comunicazione social si riduce tutto a un “like”).[5]
Occorre allora programmare in modo diverso, pensare il tempo come produttivo (non una perdita del tradizionale tempo-scuola), interpretare il cambiamento come sfida e farlo insieme al resto del corpo docente, stabilendo con gli studenti e le studentesse un confronto proficuo che solleciti la ricerca, la curiosità, la conoscenza, il confronto e la rielaborazione personale e collettiva insieme.
Il dibattito sulla pedagogia del cinema a scuola è antico e ormai ricco di studi, eppure in Italia non ha prodotto ancora un effettivo riconoscimento, pur avendo una fioritura di ricerche notevole e avanzata. Non è un caso che in questi ultimi anni in Italia – come già altrove avviene da decenni – il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Istruzione e del Merito stiano finanziando progettualità,[6] con cui far entrare il cinema nella didattica in ogni ordine e grado, mettendo in evidenza l’importanza strategica degli esperti: “si intende operare per il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni nella comunità scolastica. Perché questo obiettivo sia pienamente realizzato, è necessario non solo predisporre percorsi formativi differenziati per ordine di scuola e per fasce d’età, ma anche provvedere preliminarmente a una accurata selezione e formazione dei formatori”.[7]
UN ESEMPIO E UN PARADIGMA ALLO STESSO TEMPO: LA SHOAH
A gennaio, complice anche la macchina della distribuzione cinematografica, non è raro che una classe sia chiamata a guardare un film sul tema della Shoah. Perché un film? Un film italiano o straniero? Nel secondo caso in VOS o doppiato? Recente o un classico? Cosa esattamente si va a guardare? Si tratta di Storia, di memoria o di ‘semplice’ finzione? Cinema della realtà? Chi è dietro la macchina da presa? Una donna o un uomo? Come vengono utilizzati il colore, la musica, i costumi? Il montaggio cosa svela? Dove siamo, in Italia, in Francia, nella Germania di allora o nella Polonia di oggi? Che impatto ha su chi guarda?
Ci si chiede mai tutto questo e molto altro?
La Shoah ricopre nel cinema un ruolo particolare: non è uno dei tanti temi del Novecento, non una pagina di Storia semplice da trattare, non qualcosa su cui è ammesso sbagliare. Se ciò è vero in generale, si consideri come questo assuma un valore ancor più carico di responsabilità in ambito scolastico. Il rischio e la critica possono essere racchiusi in una parola: banalizzazione. Ma il pericolo della spettacolarizzazione non è da meno.[8]
La complessità del tema richiede uno sguardo più attento, una visione particolare e in un certo senso problematica. I film, i documentari, i corti sono talvolta illuminanti, altre volte soltanto qualcosa di trascurabile o peggio di ‘cattivo gusto’. Il rapporto che si stabilisce con la necessità di verità storica fa i conti perennemente con l’inevitabile tradimento di essa. Se ogni ripresa – anche quella documentaria – porta con sé la parzialità dello sguardo di chi riprende, facendo i conti inevitabilmente, per mancanza non solo di tempo ma anche di spazio, con punto di vista, taglio e montaggio, dobbiamo allora essere in grado di saper decodificare questa “lingua” universale.[9] La realtà che vive in un continuum impossibile da riprodurre, cede il passo alla creazione artistica: al cinema si deve chiedere non di essere fonte oggettiva, calco di verità assolute, bensì opera soggettiva e linguaggio specifico al pari delle altri arti (letteratura, pittura, architettura, fotografia ecc.). Non si deve confondere documento storico e finzione del film,[10] così come occorre distinguere le vittime (la morte) dai sopravvissuti, i “sommersi” dai “salvati”.
Siamo sempre alle prese con una parzialità e con una dimensione soggettiva; e se questo è il punto di partenza, ci si potrebbe chiedere allora quale sia il valore, l’importanza, la forza del suo punto d’arrivo.
Il cinema di finzione o documentario attraverso sé stesso esprime di per sé la potenza delle immagini. Guardare assume il significato di immagazzinare in un certo modo quanto viene raccontato: vedo, osservo, comprendo e apprendo allo stesso tempo. La riflessione in seguito decompone e riordina, scopre livelli, insegna qualcosa (un particolare o questione centrale che sia). La riflessione permette anche di scegliere cosa tenere e cosa scartare, così come ‘cosa’ e ‘come’ approfondire ulteriormente.
Quando si tratta di Shoah questi aspetti non sono affatto trascurabili, soprattutto se siamo in un ambito didattico/educativo. Non si tratta solo di un discorso di etica che si coniuga con l’estetica, quanto di fare i conti con qualcosa che per sua stessa natura è ‘irrappresentabile’, non visibile, mai assoluto, quanto parziale e intoccabile. Eppure l’effetto sui fruitori è eccezionalmente potente, nonostante o forse proprio grazie alla sua particolare natura.[11]
I prodotti visivi che riguardano la Shoah sono oggi migliaia: si pensi alle interviste video dei testimoni, dei testimoni dei testimoni, ai documentari di ricostruzione di luoghi ed eventi, ai numerosi film di finzione, agli sceneggiati, alle serie e all’animazione che ha acquisito nel tempo una propria fisionomia. Perché? Perché il tema ha in sé il potere di scuotere/interessare la coscienza collettiva (pubblica?) come pochi altri. Perché il racconto è inesauribile e sembra necessitare di continui tasselli che si aggiungono ad altri senza mai ridisegnare completamente il mosaico, quasi come se la ricerca di una spiegazione porti in realtà verso un puro calcolo infinitesimale senza soluzione.
La filmografia stessa sulla Shoah è complessa, seguendo uno sviluppo non lineare: la “linea che passa dal silenzio traumatico […] alla rielaborazione del lutto fino ad arrivare alla istituzionalizzazione della memoria accompagnata dalla proliferazione” di opere.[12] All’inizio si fatica a produrre opere su questo, a parlarne, o meglio a “mostrare ciò che è stato”. Se ci si pensa le prime tracce sono i documentari in presa diretta girati nel 1945, subito dopo la liberazione. Il primo fu curato tra gli altri anche da un giovane Alfred Hitchcock, inviato dalle autorità britanniche, quasi un disvelamento senza apparenti filtri. Nel 1948 apparve della regista polacca (reduce dei campi) Wanda Jakubowska L’ultima tappa (Ostatni etap),[13] il primo film ad essere ambientato ad Auschwitz che con ‘semplicità’ offre un quadro realistico delle condizioni di vita e di morte nel campo di sterminio. Poi fondamentale fu nel 1956 di Alain Resnais Notte e nebbia, che mostra materiali d’archivio per mostrare la vita nei lager.
In Italia la questione vive tra rimozione e senso di colpa.[14] Gillo Pontecorvo nel 1960 con Kapò[15] sconfina nella finzione, si tratta di un film, che venne molto criticato, ma fu anche un grande successo: lo sguardo interpretativo si fissa sulla protagonista ebrea che per sopravvivere diviene carceriera. Un esempio di creazione cinematografica che è importante indagare proprio per il “come” usa la macchina da presa (ad es. lo zoom): porta forse alla spettacolarizzazione di qualcosa che rifiuta per sua natura qualsiasi rischio in tale direzione? Più discreti L’oro di Roma[16] di Lizzani (1961) e Il giardino dei Finzi Contini[17] di Vittorio De Sica (1970, premiato con l’Oscar) che si fermano al di qua dei campi di concentramento, sulla storia delle leggi razziali, della paura della deportazione, della responsabilità degli italiani. Una questione quest’ultima difficile da affrontare e sempre un po’ edulcorata.
Il punto di svolta arriva per il mondo intero con Claude Lanzmann e il suo documentario monumentale sullo sterminio degli ebrei dal titolo Shoah[18](1985), che rappresenta un punto fondamentale di elaborazione del tema, in direzione ostinata e contraria: le interviste diventano il veicolo della messa in opera. Sopravvissuti ebrei, testimoni polacchi ed ex nazisti assumono il carattere di unici portatori del racconto, coloro che nel presente dell’intervista ricordano e riportano alla luce le proprie memorie, ritornando sui luoghi. La ripresa delle reazioni rappresentano un valore aggiunto alla memoria storica, legando in qualche modo presente e passato.
Sono queste le opere che meriterebbero di essere conosciute e discusse a lezione? Sicuramente sarebbe interessante metterle a confronto, far riflettere ragazzi e ragazze su cosa sono storia, memoria, finzione in un’opera cinematografica. Non basta comunque commuovere con Il bambino con il pigiama a righe[19] o Un sacchetto di biglie[20] (2017 di Christian Duguay): siamo davanti ad un panorama ben più complesso. A seconda di età, percorsi, interessi molte sono le opere degne di essere scelte, alcune davvero preziose per come sono realizzate. In Italia alcune non hanno spesso circolato, ma oggi con la rete è possibile recuperare, fare ricerca, scoprire. Qui si indicano solo alcuni esempi tra quelli che – anche per motivi di durata – potrebbero essere davvero scandagliati in profondità.
Nel 1961 in Polonia Janusz Morgenstern (di religione ebraica, unico sopravvissuto della sua famiglia) gira Ambulans,[21] un corto di 11’, che senza parole (se non il discorso di Hitler al Reichstag posto all’inizio) mostra in un luogo indecifrato (seppur ‘riconoscibile’) un’ambulanza che giunge su un piazzale desolato dove sono alcuni bambini con il loro maestro. L’irrealtà dei gesti naturali di bambini che giocano stride con quello che sta per accadere. Filo spinato, soldati tedeschi, l’abbaiare di un cane, un tubo di scappamento che porta il fumo all’interno dell’ambulanza in cui sono destinati a salire maestro e scolari per una fine tragica che non viene mostrata. Il film è su un procedimento vero: così venivano sterminati gli ebrei prima della costruzione delle camere a gas. Si procede ad una rappresentazione fortemente metaforica e simbolica, per qualcuno anticipando un’attenzione etica simile a quella di Lanzmann. Perché il lager in realtà non può essere descritto, soprattutto il tempo d’attesa della morte, l’assurdità di quanto accadeva senza un “perché”, come ha evidenziato nel 1947 Primo Levi in Se questo è un uomo.[22] L’assenza di parola del film vuol allora indicare l’assenza di qualsiasi spiegazione, in cui si consuma la tragedia in un non-luogo di solo cemento, filo spinato e polvere, per trovare nello spazio dell’ambulanza lo spazio del vuoto assoluto, del buio totale, della morte per gas, della fine dell’infanzia. Sarebbe interessante vedere con una classe quelle immagini, provare a capire le scelte e interpretare gli effetti, approfondire i dettagli tra visibilità e invisibile. Smontare sequenze, scene, soggetti, punto di vista per poi capirne il senso.[23]
L’assenza e la sottrazione tornano anche in un altro corto Türelem[24] (tradotto Con un po’ di pazienza) di László Nemes del 2007, in cui la routine di un’impiegata in un ufficio non meglio precisato collabora alla macchina della morte nazista. Tutto rivive in una singola sequenza di circa 10 minuti con la particolarità della macchina da presa che mette a fuoco soprattutto la donna su cui è, lasciando lo sfondo evocato più che altro attraverso il campo uditivo, il sonoro fuori cornice. Il film non ha bisogno di doppiaggio: un’unica parola tedesca “Los!” [“Vai!”]. I suoni sono quelli tipici di un ufficio (la scrittura a macchina, lo stampigliare del timbro), l’abbaiare di un cane e un pianto femminile. La protagonista con i suoi gesti incarna un punto di vista, mostra lo sfondo per come lo ascolta distrattamente, il suo movimento è lo stesso della macchina da presa.[25] Il guardare alla fine da una finestra mostrerà allo spettatore la cruda realtà del contesto storico: il bosco in cui sono spinti dai nazisti gli ebrei deprivati dei loro averi e della loro dignità; l’indifferenza di una burocrazia pericolosissima.[26]
Non è semplice scegliere di rappresentare la Shoah: si è passato dalla semi-invisibilità degli Anni Cinquanta (anni di rimozione collettiva) alla forte presenza del tema, tanto che ogni anno intorno alla data della sua commemorazione escono almeno due/tre titoli con distribuzione nazionale e internazionale. Lo spazio pubblico e in particolare quello cinematografico ha così creato quello che per alcuni è diventato un genere. Hollywood e il cinema americano hanno contribuito in un certo senso a generare un campo specifico di indagine (che rientra anche negli Holocaust Studies) e di rappresentazione in cui lo spettatore è portato per lo più all’immedesimazione. Ma il cinema non si riduce a questo. A scuola non possiamo lavorare solo su questo piano o lasciare che sia l’unico effetto.
La questione posta e su cui non sempre si ragiona sufficientemente a scuola è il connubio tra rappresentabilità/irrappresentabilità: il limite dello sguardo. Inoltre la dimensione della memoria e del ricordo merita di andare oltre la commemorazione per “interrogare la costruzione mediale dei ricordi”, perché “non è mostrando cento film su Auschwitz che il ricordo acquista e mantiene la sua forza”, piuttosto analizzando come il cinema insieme all’esposizioni museali della Storia “definiscono un orizzonte decisivo per pensare l’intreccio di pratiche narrative e pratiche della memoria”.[27] Le architetture museali del resto si fondano sull’idea di allestimento e messa in scena simile ad un set cinematografico. La Shoah per questo vive la contraddizione di non poter esser rappresentata e dall’altro di dover essere presente come lezione etica dell’evento stesso. Il cinema in qualche modo quando si inserisce esattamente all’interno di tale contraddizione, frattura, ‘buco nero’, abisso indicibile riesce negli esiti migliori, di più ricco valore. L’immaginario collettivo trova uno scambio proficuo con le pratiche della ricerca storica e su questo bisogna continuare a interrogarsi.
Il cinema ha avuto e ha del resto un ruolo nella costruzione della memoria pubblica e di quella collettiva attraverso lo sguardo filtrato del racconto, similmente a quanto accade per certi versi in letteratura e in particolare con la poesia.[28] Una certa diversificazione d’approccio c’è stata nei differenti Paesi, così come nelle scelte operate rispetto a commemorazioni, costruzioni di musei e monumenti, conservazione della memoria e investimenti nella ricerca storica; su questi aspetti sarebbe interessante coinvolgere ragazzi e ragazze per una riflessione critica.
Allo stesso tempo sarebbe interessante considerare un elemento aggiuntivo che proviene da alcuni studi di “teoria dell’immagine” e che appare essenziale, l’interrogarsi su come è cambiato il nostro stesso vedere. Quanto i limiti dello sguardo e del vedere sono messi in crisi proprio quando si tratta di Shoah? Ciò che le immagini mostrano in realtà rivelano anche (o forse soprattutto) quanto è celato, traendo da esso anche la propria legittimazione. Questa questione permette di osservare con maggior attenzione il fuori campo, il vuoto, il senso di sottrazione a cui si è fatto cenno proprio negli esempi appena riportati. Michele Guerra a questo proposito riflette su come, a suo avviso, si “deve difendere la ‘causa dell’invisibile’ e ripensarne la radice attraverso ciò che ci è dato vedere”.[29]
Il salto in questa direzione risulta di evidente importanza nel discorso da intavolare con le nuove generazioni, portandole a riflettere criticamente su ciò che guardano o non guardano, su ciò che è loro offerto e ciò che viene loro nascosto. Far capire loro che vedere, guardare, osservare non sono la stessa cosa, e che nello sguardo del visibile si nasconde molto di ciò che rimane per sua natura o necessità invisibile. Lavorare su questo si crede che sia oltre che urgente, anche di straordinario arricchimento. Chi sa “vedere”, saprà leggere la realtà circostante, possederà un proprio punto di vista fondato e cosciente.[30]
In questo senso la sfida educativa all’interno di un mondo complesso, globale e perennemente connesso diviene permettere di comprendere il visuale oltre i confini fissati dall’immagine, di entrare nel visibile con uno sguardo critico, nutrito di riflessione e di ‘dubbio’. Questo comporta per i docenti un cambio di passo, una didattica rinnovata e una metodologia efficace che porti a fissare l’attenzione più sul come rispetto al cosa, più sul modo/metodo che sui contenuti ed il cinema come arte e linguaggio può rappresentare in questo uno strumento di comprensione della realtà storica e formazione in termini di cittadinanza di fondamentale importanza.
Bibliografia
- A. Bergala, Pour une pedagogie de l’audio-visuel, in Audiovisuel et fprmation des enseignants, Insitut Nationale de Richerche Pédagogique, Parigi 1994.
- A. Bergala, L’ipotesi cinema. Piccolo trattato di educazione al cinema nella scuola e non solo, Cineteca di Bologna, Bologna 2008.
- M. Brignani e G. Carrara, Storia globale, cittadinanza multipla e pensiero complesso: le sfide educative della scuola di oggi e di domani, in “Novecento.org”, n. 16, agosto 2021. DOI: 10.52056/9788833139883/09.
- M. Cousins, Storia dello sguardo, Il Saggiatore, Milano 2018.
- G. De Luna, Cinema Italia. I film che hanno fatto gli italiani, UTET, Torino 2021.
- M. Guerra, Il limite dello sguardo.Oltre i confini delle immagini, Raffaello Cortina editore, Milano 2020.
- M. Guerri, Ancora immagini della Shoah? Günther Anders e la fiction “Holocaust”, in “Novecento.org”, n. 15, febbraio 2021. DOI: 10.12977/nov387.
- C. Hassan, Cinema e Shoah, in International Journal Of Psychoanalysis And Education, Vol. IV, 2012, pp. 162-175.
- A. Minuz, La Shoah e la cultura visuale. Cinema, memoria, spazio pubblico, Bulzoni, Roma 2010.
- A. Minuz e G. Vitiello, La Shoah nel cinema italiano, in Cinema e Storia. Rivista di studi interdisciplinari, a. II, n. 2, Rubbettino editore, Roma 2013.
- S. Murri, Sign(s) of the times. Pensiero visuale ed estetiche della soggettività digitale, Meltemi editore, Milano 2020.
- V. Pisanty, Che cosa è andato storto? Le politiche della memoria nell’epoca del post-testimone, in “Novecento.org”, n..13, febbraio 2020. DOI: 10.12977/nov309
- D. Vicari, Il cinema, l’immortale, Einaudi, Torino 2022.
Note:
[1] Si rimanda all’importante lavoro di M. Cousins, Storia dello sguardo, Il Saggiatore, Milano 2018.
[2] Cfr. S. Murri, Sign(s) of the times. Pensiero visuale ed estetiche della soggettività digitale, Meltemi editore, Milano 2020.
[3] Recenti e molto interessanti le riflessioni sul tema di D. Vicari (Regista e Docente/Fondatore/Direttore artistico della Scuola d’arte cinematografica Gian Maria Volonté di Roma) in Il cinema, l’immortale, Einaudi, Torino 2022.
[4] Sempre un punto di riferimento su questo terreno A. Bergala, Pour une pedagogie de l’audio-visuel, in Audiovisuel et fprmation des enseignants, Insitut Nationale de Richerche Pédagogique, Parigi 1994. In Italia il suo L’ipotesi cinema. Piccolo trattato di educazione al cinema nella scuola e non solo, Cineteca di Bologna, Bologna 2008, per un approccio non convenzionale al cinema.
[5] Cfr. sulla questione della complessità M. Brignani e G. Carrara, Storia globale, cittadinanza multipla e pensiero complesso: le sfide educative della scuola di oggi e di domani, in “Novecento.org”, n. 16, agosto 2021. DOI: 10.52056/9788833139883/09.
[6] Si rimanda in particolare al quadro normativo (attivato dal 2016) per capire meglio intenti e modalità: https://cinemaperlascuola.istruzione.it/strumenti/cips-riferimenti-normativi/.
[7] Cfr. in Le Linee guida per il cinema nella scuola (2021) https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/be78e33bc8ca0c99bff70aa174035096/DECRETI/Accordi/protocollo_MIC-MI__Cinema_Scuola_-signed-signed.pdf.
[8]Cfr. su questo tema interessanti spunti di riflessione di M. Guerri, Ancora immagini della Shoah? Günther Anders e la fiction “Holocaust”, in “Novecento.org”, n. 15, febbraio 2021. DOI: 10.12977/nov387.
[9] P. P. Pasolini è molto chiaro su questo quando parla del suo passaggio dal friulano e dall’italiano alla lingua universale del cinema: https://www.youtube.com/watch?v=3MMOu94eFwI.
[10] Su questo C. Hassan, Cinema e Shoah, in International Journal Of Psychoanalysis And Education, Vol. IV, 2012, pp. 162-175.
[11] Cf. A. Minuz, La Shoah e la cultura visuale. Cinema, memoria, spazio pubblico, Bulzoni, Roma 2010.
[12] Cfr. Hassan, 2012, p.171.
[13] Ostatni etap, di W. Jakubosja (Polonia, 1948).
[14] Si veda sull’intera questione da diversi punti di vista il numero monografico a cura di A. Minuz e G. Vitiello, La Shoah nel cinema italiano, in Cinema e Storia. Rivista di studi interdisciplinari, a. II, n. 2, Rubbettino editore, Roma 2013. Sul rapporto tra cinema e storia G. De Luna, Cinema Italia. I film che hanno fatto gli italiani, UTET, Torino 2021, in cui un capitolo è dedicato a Raccontare l’”l’indicibile”: La vita è bella, 1997 (pp. 46-54).
[15] Kapò, di G. Pontecorvo (Italia, 1960).
[16] L’oro di Roma, di C. Lizzani (Italia, 1961).
[17] Il giardino dei Finzi-Contini, di V. De Sica (Italia, 1970).
[18] Shoah, di C. Lanzmann (Francia, 1985).
[19] The Boy in the Striped Pyjamas, di M. Herman (USA, Regno Unito, Unghezia, 2008).
[20] Un sac de billes, di C. Duguay (Francia, Canada, Repubblica Ceca, 2017).
[21] Ambulans, di J. Morgenstern (Polonia, 1961).
[22] P. Levi, Se questo è un uomo, F. De Silva, coll. “Biblioteca Leone Ginzburg” n. 3, I ed., Torino 1947.
[23] Oggi visibile in rete https://www.youtube.com/watch?v=I0pwxuGdQfo&t=11s.
[24] Turalem, di L. Nemes (Ungheria, 2007).
[25] Lo stesso regista utilizzerà questa tecnica in Il figlio di Saul del 2015, facendone un tratto distintivo del suo cinema.
[26] Visibile in rete https://www.youtube.com/watch?v=5g1FIkw9CYM.
[27] Cfr. Minuz, 2010, p. 46.
[28] Edith Bruck nella sua postfazione a Versi vissuti. Poesie 1975-1990, EUM, Macerata 2018 scrive: «Di che cosa scrive un poeta se non dell’assenza, di ciò che manca sia dentro che fuori?» (p. 233).
[29] M. Guerra, Il limite dello sguardo.Oltre i confini delle immagini, Raffaello Cortina editore, Milano 2020. Volume interessante non solo per gli esempi presi in esame, ma per la capacità di rifarsi ad “una consapevolezza formale e stilistica che ha inciso sulle modalità di trasmissione e di narrazione della Shoah”, privilegiando la “scelta di tenere insieme il fatto e la forma” (pp. 9-10, il corsivo è nel testo).
[30] Su una riflessione critica della questione e su alcune contraddizioni della nostra società si rimanda a V. Pisanty, Che cosa è andato storto? Le politiche della memoria nell’epoca del post-testimone, in “Novecento.org”, n..13, febbraio 2020. DOI: 10.12977/nov309.
























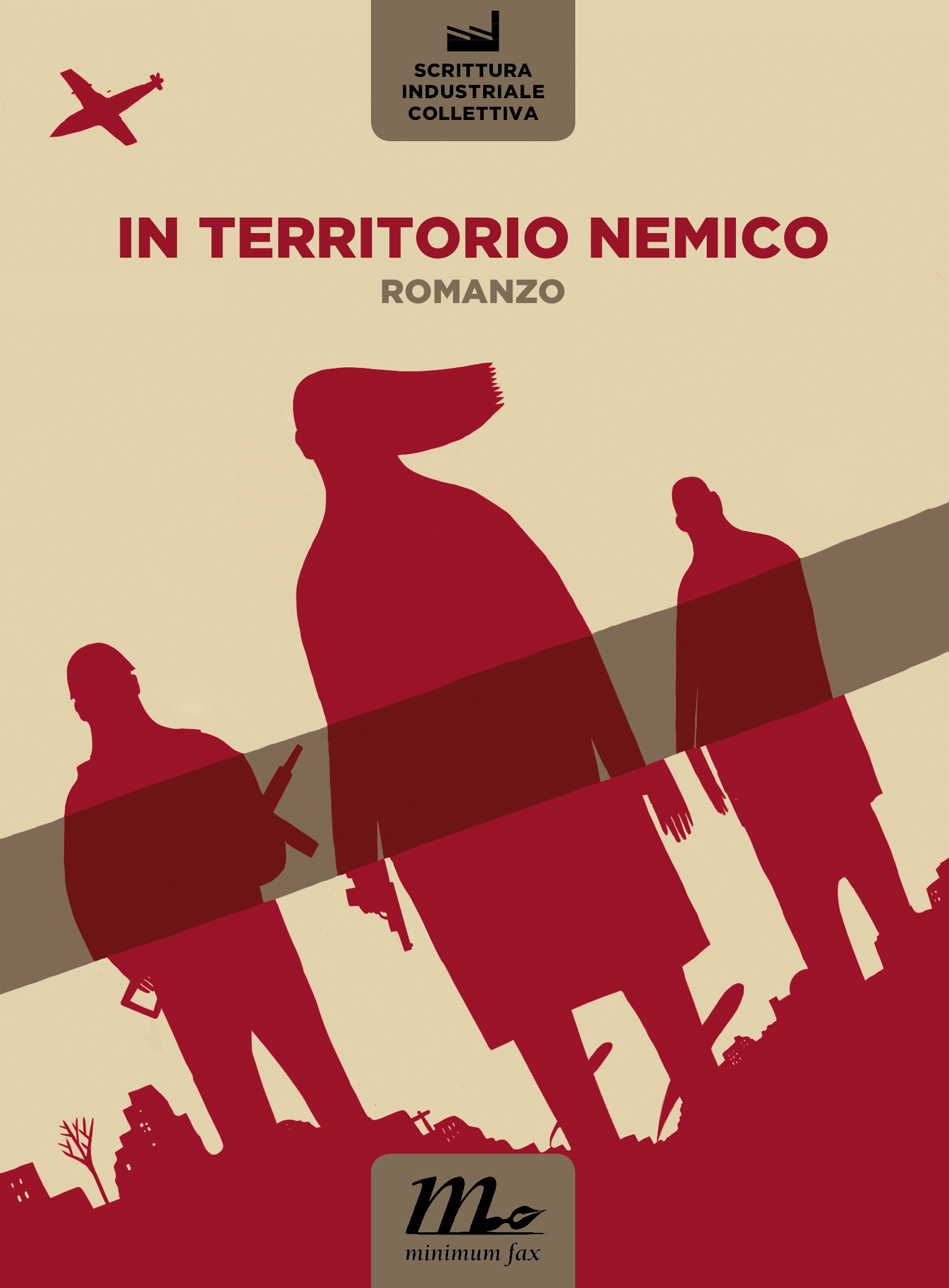
 Scarpe rotte eppur bisogna andar. Una storia della Resistenza in 30 oggetti, a cura di P. E. Boccalatte e M. Carrattieri
Scarpe rotte eppur bisogna andar. Una storia della Resistenza in 30 oggetti, a cura di P. E. Boccalatte e M. Carrattieri L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore
L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino
Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio
Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa
Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice
Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli
Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli L’arresto degli arlecchini
L’arresto degli arlecchini