
Lost in translation: un futuro per la memoria
L’intervento proposto è una rielaborazione della lezione tenuta il 15 gennaio 2016 nell’ambito del corso sulle deportazioni organizzato nel 2015/2016 dall’ANED di Verona, in collaborazione con il Dipartimento di Culture e Civiltà dell’Università veronese, con l’Ufficio scolastico territoriale VII e con il Comune di Verona.
Si può trasmettere la memoria?
Deportazioni, memoria, memoria delle deportazioni: su tutto questo, è senz’altro possibile trasmettere conoscenze, anche se cosa, come, con quali metodologie comunicare non è affatto scontato e solo con grandi semplificazioni si può ridurre al leggere qualcosa, ascoltare qualcosa.
Ma la domanda da cui vorrei partire riguarda la possibilità di trasmettere memoria, che è una cosa in parte diversa dalla trasmissione delle conoscenze. A quali condizioni la memoria può essere acquisita? Fino a che punto è possibile che la memoria di una generazione entri e si sedimenti nella memoria di un’altra? Non, cioè, venga semplicemente rappresentata, ma diventi un elemento importante dell’identità individuale e collettiva, venga più propriamente vissuta?
Si potrebbe dire che questo, in fondo, non ha particolare importanza, nel momento in cui esiste la conoscenza. Ma una conoscenza appropriata e anche critica si può avere anche sulla guerra del Peloponneso o sulle guerre napoleoniche. E dunque, che cosa rende diversa e diversamente significativa per noi la storia e la memoria della deportazione rispetto a quelle? Che cosa ce la rende vicina? Ed è poi vero che i nostri giovani studenti sentono questa vicenda come vicina, e non come cristallizzata in un passato remoto non molto diverso, alla fin fine, da tutte le altre pagine del libro di testo? Su questo, naturalmente, è a loro che bisognerebbe lasciare la parola, e dunque questo intervento sarà molto più un suggerimento di interrogativi e piste di discussione che non un ricettario di “cose che si possono fare”.
Memoria ed esperienza
Una prima osservazione è che la memoria può restare viva solo se non perde il proprio legame con la dimensione dell’esperienza. E “l’esperienza (Jedlowski) non ha a che fare con ‘dati’, ma con la sedimentazione e l’elaborazione di ‘vissuti’. […] Chi è il più ricco di informazioni, può a volte essere il più povero di esperienza”[1].
E dunque: che legame ci può essere, ora, tra la memoria delle deportazioni e l’esperienza di chi vi si avvicina oggi? Proviamo ad inquadrare il problema, per definirlo meglio: memoria ed esperienza si legano strettamente, in generale, nella formazione dell’identità, individuale e collettiva. Implicano processi di lungo periodo e intrecciano la lunga durata della narrazione con l’orientamento presente dell’azione. Fin dai tempi più antichi, ai grandi miti di fondazione così come alle figure leggendarie di eroi, condottieri e martiri non si chiedeva di essere storicamente attendibili, ma di porsi come ancoraggio e garanzia di un sistema di valori, di regole, di appartenenze che garantivano la continuità e la solidità di una comunità presente, il suo auto-riconoscimento e la sua capacità di confrontarsi con l’altro da sé. La memoria collettiva, quindi, vuoi che si manifestasse nell’oralità della tradizione omerica vuoi che, in tempi molto più recenti, si codificasse in immagini, simboli, riti, racconti, diventava radice dell’identità del gruppo e nello stesso tempo delineava un orizzonte di valori e riferimenti capace di orientare la presenza e l’azione della comunità nel mondo presente e verso il futuro.
Un processo del genere, peraltro, comportava a sua volta due condizioni necessarie: la condivisione della memoria e la sua continuità. Condizioni che oggi, nella nostra realtà attuale, e in particolare nella nostra realtà nazionale, sono fortemente in discussione.
Memorie dominanti
Per M. Halbwachs (I quadri sociali della memoria, 1925) la memoria collettiva è “un’immagine del passato che in ogni epoca si accorda con i pensieri dominanti della società”: è dunque, per eccellenza, una memoria condivisa e, in quanto tale, è sentita come un patrimonio comune. Questo non significa necessariamente che sia l’unica memoria presente e significativa. Lo è nei regimi totalitari, che fanno del controllo sulla memoria e perfino dell’invenzione della memoria uno strumento essenziale per la costruzione del consenso e il perseguimento della stabilità sociale. Il riferimento letterario più importante e più conosciuto, in questo senso, è sicuramente il romanzo di Orwell “1984”. Ma se invece preferiamo rivolgerci ai documenti storici e fare riferimento alle vicende italiane, basta pensare all’uso che il fascismo ha fatto sia del passato remoto (l’Impero romano) che di quello più recente (dalla mitologia risorgimentale alla canonizzazione di immagini e modelli legati alla prima guerra mondiale). Questa memoria monca, alterata, asfittica e imposta non è però una vera memoria sociale, ma piuttosto uno strumento (efficace!) di consolidamento del potere.
Memorie delle minoranze
In situazioni socio-politiche più aperte avviene invece che rispetto alla memoria dominante si differenzino ed eventualmente si contrappongano altri filoni di memoria: possiamo chiamarli memorie delle minoranze.
In alcuni casi si tratta di gruppi che conservano una propria forte dimensione identitaria e affidano alla memoria il compito non solo di trasmettere, ma di salvare culture e valori che avvertono come minacciati. Minoranze consapevoli (ebrei nella diaspora, valdesi nelle valli piemontesi, gruppi politici emarginati o messi al bando) che alimentano un proprio mondo di narrazioni, riti e simboli che possono essere di volta in volta accettati e tollerati, oppure invece rifiutati e condannati da parte della cultura dominante.
In altri casi invece la memoria alternativa non è il frutto di un lascito tramandato, ma piuttosto l’oggetto di una faticosa ricerca: è la memoria dei gruppi subalterni, dei vinti, o più semplicemente di quei soggetti a cui la cultura dominante non ha mai riconosciuto il diritto di avere una voce, anzi che in molti casi non ha riconosciuto (e talvolta non riconosce tuttora) come soggetti pienamente umani: schiavi, servi, popoli colonizzati, masse operaie dopo l’esordio della rivoluzione industriale e, in ogni tempo, donne.
Per molto tempo queste memorie sono state considerate come materiali di scarto. Stavano nelle stalle e nelle cantine, erano chiacchiere di femmine e brontolii di maschi malcontenti e un po’ bestioni, spesso descritti come violenti e mezzo ubriachi. Erano, a differenza di quanto detto prima, patrimonio di gruppi non organizzati, a cui non si riconosceva la capacità e la possibilità di possedere una propria storia e un proprio percorso: soggetti senza identità.
Memorie sommerse e storia orale
La ricerca intorno a queste memorie sommerse ha avuto, in Italia, un importante punto di partenza tra gli anni Sessanta e Settanta, sulla scorta del lavoro di Ernesto De Martino e nello sviluppo di una cospicua fioritura di ricerche sul campo condotte con diverse metodologie, dall’etnomusicologia (canto popolare e sue successive elaborazioni non solo come folklore, ma come oggetto di vera indagine filologica e storica) alle prime indagini condotte con gli strumenti della storia orale (interviste registrate al magnetofono, storie di vita), che era, all’epoca, una novità recente (la Oral History Association nasce negli USA nel 1967, e la Oral History Society in Gran Bretagna nel 1969).
Cosa si cercava e cosa si voleva? Si voleva ricostruire una storia “dal basso” e dare parola a chi non l’aveva mai avuta: in primo piano la classe operaia e le donne. Dare coscienza di sé a chi era stato privato non solo della propria voce, ma della propria identità e del proprio ruolo sociale. Ritrovare la memoria come modo per collocarsi nel mondo in una posizione diversa da quella della silenziosa subordinazione, elaborare coscienza per produrre lotta e cambiamento. C’era, in questo, un’evidente motivazione di carattere politico e, se vogliamo, ideologico. C’era l’idea che la memoria collettiva non è mai un fatto neutrale e che su questo si giocano prospettive di vita e strategie per il futuro. Che, insomma, il gioco della memoria, condivisa o alternativa, è legato non solo al “cosa siamo stati”, ma molto al “cosa vogliamo/vorremmo essere”.
Nella memoria codificata della maggioranza, quella che “si accorda con i pensieri dominanti della società”[2] come si diceva, così come nelle memorie delle minoranze e nelle memorie alternative, è comunque presente l’idea di un progetto (di conservazione o di rinnovamento), la prospettiva di un domani.
La oral history, peraltro, è stata inizialmente vista, e in parte lo è ancora, con una certa diffidenza da parte della storiografia “accademica”, spesso legata ad una visione del documento non solo necessariamente rigorosa, ma anche in qualche modo feticistica (malgrado gli insegnamenti autorevoli di Jacques Le Goff).
Il panorama è cambiato, però, nel momento in cui alle ricerche sui “soggetti senza storia” si è affiancata la raccolta, sempre più ampia e organizzata a partire dagli anni Ottanta, delle testimonianze dei sopravvissuti alla deportazione e ai campi di sterminio. Anche questa, come vedremo, si pone in qualche modo come una memoria alternativa, nel senso che per molto tempo è stata memoria non riconosciuta, in parte chiusa nel silenzio o condivisa solo in piccoli gruppi. Almeno fino a quando non si è aperta quella che Annette Wieviorka ha definito “l’era del testimone”.
L’Italia repubblicana
Nell’Italia repubblicana, dopo il 1945, si è formata una memoria largamente condivisa, almeno nei suoi riferimenti generali, se non in tutti i suoi contenuti. I suoi cardini forti si chiamavano: antifascismo, liberazione nazionale, Costituzione, Resistenza (anche se, fin da subito, non interpretata da tutti nello stesso modo). Anche nel nostro caso questa non era l’unica memoria, ma l’altra, quella fascista e repubblichina, era una “memoria non autorizzata”. Esclusi dall’ “arco costituzionale”, gli eredi di Salò celebravano i loro riti commemorativi a Predappio in un’indifferenza (abbastanza) generale.
Questo almeno fino al 1995, quando, durante il congresso di Fiuggi, l’allora segretario Gianfranco Fini mise fine alla storia del MSI e tentò, con la nuova etichetta di Alleanza Nazionale, di rimettere in pista il vecchio movimento neofascista come nuovo soggetto inserito nel contesto politico nazionale.
L’anno dopo, il 9 maggio 1996, l’onorevole Luciano Violante, nel suo discorso d’insediamento come Presidente della Camera dei Deputati, lanciò un messaggio che fece sobbalzare molti: “Mi chiedo se l’Italia di oggi – e quindi noi tutti – non debba cominciare a riflettere sui vinti di ieri; non perché avessero ragione o perché bisogna sposare, per convenienze non ben decifrabili, una sorta di inaccettabile parificazione tra le parti, bensì perché occorre sforzarsi di capire, senza revisionismi falsificanti, i motivi per i quali migliaia di ragazzi e soprattutto di ragazze, quando tutto era perduto, si schierarono dalla parte di Salò e non dalla parte dei diritti e delle libertà”. Gli applausi arrivarono soprattutto dai banchi della destra.
“Pacificazione”?
L’intento è in parte comprensibile: siamo negli anni che seguono il tracollo di quella che è stata definita come Prima Repubblica, in un paese lacerato tra terrorismo, stragi di mafia e corruzione politica, agli albori di quella che sarà l’epoca lunga del berlusconismo. È forte l’esigenza di restituire stabilità al Paese e di guardare avanti. Ma l’argomento scelto da Violante si rivela presto discutibile e pericoloso. L’autore stesso, in interventi successivi, si sentirà a costretto a chiarire, a ritornare sul punto, magari aggiungendo frasi ancora più imbarazzanti, come nel caso del riferimento – davvero incomprensibile ed evidentemente sessista – al “soprattutto le ragazze”.
Si apre la strada proprio a quanto a parole era stato negato: “un’inaccettabile parificazione tra le parti”, in cui l’indagine storica seria (sulla guerra civile, sulle violenze partigiane, sulla complessità del movimento resistenziale) viene offuscata da semplificazioni propagandistiche e conclusioni di comodo che comunicano, di fatto, un concetto molto semplice: fascisti e antifascisti erano tutti uguali. Si riproduce un vizio antico e mai risolto di questo Paese, quello del compromesso, della messa al bando di una ricerca delle responsabilità, individuali e collettive, di quanto era accaduto. E allora non è casuale che Silvio Berlusconi, nei lunghi anni in cui ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio, abbia ostentatamente evitato di essere presente alle cerimonie di commemorazione del 25 aprile.
L’invenzione della memoria
Negli stessi anni avvengono altre trasformazioni. È del 1996 la prima edizione della “Festa dei popoli padani”, organizzata da Umberto Bossi con partenza dalle sorgenti del Po nel Monviso e arrivo a Venezia: ampolle con l’acqua del “sacro fiume”, immagini di Alberto da Giussano, celebrazioni del giuramento di Pontida, autorevole zampata del leone di San Marco vanno a comporre un variopinto mosaico, sulla base del quale si rilancia tra l’altro energicamente l’uso del dialetto, la virilità del turpiloquio, il diritto alla volgarità, il maschilismo, il razzismo. Che importa poi se le giustificazioni storiche di tutto ciò risultano piuttosto frammentarie e vacillanti e quelle geopolitiche costruiscono un mondo e gli danno un nome, Padania, che poco appartiene alla vicenda reale dei territori che vi si vorrebbero includere? Che importa se in alcuni casi (Verona può essere un esempio) la contiguità con personaggi e movimenti della destra più estrema è visibile e conclamata?
Ciò che conta è trovare le immagini e i linguaggi più adeguati per dare voce a malcontenti antichi e più recenti, a interessi che si ritengono non rappresentati e anche a un filone mai del tutto estinto di ostilità nei confronti dello Stato unitario, di localismo e particolarismo non più mediato dai complessi equilibrismi instaurati dalla vecchia DC. I seguaci della Lega Nord inneggiano alla secessione, e si può discutere fino a che punto questo sia un obiettivo reale, ma non può sfuggire come sia una carta utile al consolidamento di un nuovo bacino elettorale, che si spera di veder crescere rapidamente.
Avviene allora un fenomeno inusitato e paradossale rispetto a quanto ricostruito finora: l’identità del gruppo non nasce e non si appoggia su una memoria preesistente quanto piuttosto il contrario: è la costruzione della memoria il passo che precede la formazione del soggetto politico. A pezzi e a frammenti, brandelli del passato vengono recuperati e in qualche modo cuciti insieme perché possano offrire un autorevole riferimento a un movimento completamente nuovo. Siamo, cioè, all’invenzione della memoria.
Memorie armate e memorie ritrovate
Non a caso i protagonisti più avvertiti hanno cominciato a sforzarsi di trovare più forti ancoraggi per consolidare e difendere l’identità nazionale, anche recuperando parole e tradizioni che sembravano ormai distanti e annebbiate.
Il 1° marzo 2001 il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, commemorando a Cefalonia il massacro dei soldati italiani del settembre 1943, si rivolge ai pochi superstiti della strage facendo appello anche ai tanti scomparsi: voi, dice, «decideste consapevolmente il vostro destino, e dimostraste che la Patria non era morta. Anzi con la vostra decisione ne riaffermaste l’esistenza». Nella vicenda di Cefalonia e nella scelta di fedeltà dei militari italiani riconosce il «primo atto della Resistenza, di un’Italia libera dal fascismo». E contesta esplicitamente le posizioni di quanti nell’8 settembre hanno visto piuttosto “la morte della patria”.
Eppure “Patria” era un termine che da molto tempo si cercava di non usare. Appesantita da troppe stratificazioni e ricordi degli usi che ne erano stati fatti durante il Ventennio e nella guerra, la parola era come sfigurata, piegata a usi politici che ne deformavano il senso. Rimetterla in circolazione fu un gesto significativo (anche le parole hanno una storia e sarebbe importante imparare a non usarle a caso).
Dopo Ciampi, Giorgio Napolitano lancia, nel 2011, una straordinaria campagna di informazione e commemorazione intorno al 150° dell’Unità d’Italia. L’obiettivo è coinvolgere il Paese in modo massiccio, passando attraverso le scuole, le associazioni culturali, le realtà istituzionali e locali a tutti i livelli. A chi conosca con un minimo di dettaglio le vicende del Risorgimento italiano non possono certamente sfuggire le contraddizioni, le grandi idealità e anche i grandi limiti, del movimento che porta alla proclamazione del Regno d’Italia nel 1861. Ma non è questo in questione, e nemmeno penso che si possa ridurre tutta l’operazione del 2011 al contrasto verso le forze centrifughe rappresentate dalla Lega Nord, ma anche verso componenti presenti nelle realtà meridionali. Quello che si cerca, ancora una volta, è di stabilire delle radici su cui costruire una prospettiva di futuro. Magari semplificando un po’ la narrazione storica, magari aggirando il problema che Piero Gobetti, e dopo di lui Carlo Rosselli, avevano formulato fin dalla nascita del regime: il fascismo è stato “l’autobiografia della nazione”?
Continuità
L’altro carattere forte di una memoria condivisa è la sua continuità nel tempo. Tornando alle vicende del 1943-45 e alla nascita dell’Italia repubblicana, non si può sfuggire alla sensazione che si tratti di un altro mondo, molto diverso da quello in cui viviamo ora. Delle forze che furono protagoniste di quella storia (partiti politici, movimenti, militanti, intellettuali) nessuna, praticamente, è sopravvissuta.
E non si tratta di sopravvissuti in senso fisico, come singoli. Alcuni, anche se molto anziani, ci sono ancora. Si tratta, piuttosto, del passaggio di un’eredità ideale e politica; passaggio che si è interrotto o, meglio, è stato rifiutato. Non senza ragione, per tanti versi.
Ma il problema è che il nuovo che si è affermato con la cosiddetta seconda repubblica – presto saremo alla terza? – non ha sedimentato identità, costruito punti di riferimento a lungo termine e non ha prodotto soggetti collettivi in grado di coagulare significati e di dare un senso al proprio agire e al proprio essere nel mondo oltre a quello dell’immediato “ora e subito”. La smemorataggine è diventata la regola, affermazioni decisive e solenni impegni possono essere dimenticati e smentiti nel giro di poche settimane o mesi, l’importante è invece essere svegli e reattivi nella risposta immediata. Conclusione: in un paese sempre più privo di memoria, il filo tra le generazioni si è rotto, non nei confronti dei giovani di oggi, ma già dei loro genitori, di quelli che sono stati ragazzi negli anni Ottanta.
Se a questo si aggiunge tutto ciò che, già dall’immediato dopoguerra, è stato occultato, rimosso, accantonato, ci si rende conto di quanto complesso possa essere oggi il tentativo di ricostruire una trama sensata di relazioni tra il nostro mondo e quella realtà.
Smemorati
Contrariamente a quanto è avvenuto in un passato anche non lontano, la situazione di oggi non è quella di dover confrontare o contestare una visione del mondo, un’interpretazione della storia o un messaggio identitario dominante. Non si tratta di dare identità a soggetti emarginati dalla memoria o dalla storia in contrasto con un sistema d’idee prevalenti. Si tratta piuttosto di affermare l’importanza di possedere delle idee e dei punti di riferimento (senza possibilmente indulgere alla retorica o cadere in nuovi fondamentalismi) piuttosto che il niente. Questa perdita della dimensione temporale, questa rincorsa dell’eterno presente, che non prevede un futuro a lungo termine perché non prevede un progetto, tende a far evaporare la dimensione del ricordo e con essa la consistenza del nostro stare nel mondo.
Si vive in un cinema nel quale ogni giorno vengono proiettate immagini più o meno inquietanti e affascinanti, destinate a svanire un attimo dopo. E, tuttavia, non è detto che questo ci vada bene, ed ecco il fiorire di una variegata offerta di informazione e divulgazione storica, di vario spessore e qualità, che però trova ascolto e richiama attenzione, come una necessità di recuperare delle radici per non essere trascinati nella dimensione dell’inconsistenza.
In una situazione di questo genere, il recupero della storia e della memoria non è un’ovvietà, ma è una scelta: un’assunzione di responsabilità.
Proteggere le parole
Recuperare la storia e renderla comprensibile per chi non l’ha vissuta significa anche prendersi cura delle parole. Le parole sono un oggetto molto delicato: l’involgarimento e la banalizzazione del linguaggio politico, per esempio, non è solo un problema estetico. Se così fosse, potrebbe riguardare il buon gusto, o il “buon tono”, come diceva Giacomo Leopardi parlando di ciò che manca agli italiani.
Il fatto è che nel corso di un tempo breve anche le parole si sono usurate. Perfino quelle che avevano una storia tanto lunga e autorevole da sembrare immortali. Non parliamo di quelle che sono state dichiarate obsolete (ad esempio destra e sinistra), ma di quelle grandi, di quelle che una volta stavano scritte nelle bandiere: libertà, giustizia, democrazia, diritti… Parole grandi che sono state abusate, stravolte, usate per tutti gli scopi possibili, fino a renderle irriconoscibili. Significati che ci sono scivolati tra le mani.
Anche novità, modernità, riforme richiamano concetti plastici che si possono prestare a vari usi e scopi (a voler essere moderni si potrebbe dire che sono parole multitasking).
Eppure la domanda resta: la storia, allora, come facciamo a dirla? Democrazia, diritti… Troviamo sia diventato fragile e ambiguo il vocabolario su cui contavamo di più, e questo proprio nel momento in cui il mondo che credevamo di conoscere vacilla pericolosamente e non possiamo pensare di risolvere le nostre faccende stando chiusi nei nostri confini. E quindi avremmo bisogno di più competenze, di più conoscenze, di più storia e di più discernimento – insomma avremmo bisogno di studiare per capire quello che sta succedendo e di trovare le parole giuste per dirlo – sapendo che le parole non solo descrivono, ma costruiscono le cose, costruiscono l’immagine e l’orizzonte del mondo in cui ci muoviamo e creano le condizioni per abitarlo, per viverci.
Responsabilità
Si può allora provare ad utilizzarne due, due di quelle parole che non stanno sedute a capotavola nel banchetto degli slogan: responsabilità e dignità. Tentiamo.
Responsabilità: siamo responsabili di quello che è avvenuto non perché ne portiamo la colpa, ma perché ne portiamo i segni. Non davanti a un tribunale, ma davanti al compito di essere noi, oggi, parte in causa nella nostra storia e nella storia del mondo. Parole grosse? Non se pensiamo che essere protagonisti della storia non sia necessariamente impugnare una bandiera per mettersi, come si diceva una volta, “alla testa delle masse”, ma possa essere anche imbarcarsi su un gommone bucato oppure chiudere la finestra per non sentire quello che succede in strada. Per essere parte in causa ci sono tanti modi, oggi come ci sono stati ieri, e tutti questi modi comportano una scelta, fosse pure quella di dire “non me ne importa niente”.
Prendiamo la storia, e non più solo la memoria, delle deportazioni: da declinare, non a caso, al plurale, come giustamente si è fatto nel titolo dato dall’ANED veronese al suo corso di lezioni[3]. Questa è una storia che non compare subito e anzi, per vari aspetti, è tuttora una storia da scoprire, in parte largamente indagata e in parte quasi ignota.
Deportazioni e silenzi
Quando, nel 1947, Primo Levi propone a Einaudi la pubblicazione di Se questo è un uomo, la risposta è un rifiuto. E il rifiuto non viene da un personaggio qualsiasi, ma da Cesare Pavese. Il libro uscirà con una piccola casa editrice, la De Silva, e sarà ripreso da Einaudi più di 10 anni dopo, nel 1959. Di Levi, peraltro, è ben nota la narrazione del sogno del prigioniero, sogno ricorrente in lui come in tanti altri che hanno vissuto la stessa esperienza: è il sogno di ritornare a casa, di rivedere le persone care, la sorella, gli amici e di voler raccontare, finalmente raccontare il lager, la fame, le violenze, la morte. Ma di accorgersi presto che nessuno lo ascolta, che gli altri sono indifferenti, assenti. “Mia sorella mi guarda, si alza e se ne va senza far parola”. Allora nasce una disperazione ancora più profonda, una pena desolata.
Il silenzio ha coperto per molti anni la storia della deportazione, almeno in Italia: è questione aperta se e quanto questo giudizio si possa estendere e generalizzare altrove. Silenzio storiografico (scarse e ancora lacunose le prime ricerche avviate dopo la fine della guerra) e, soprattutto, silenzio pubblico. Nel clima del dopoguerra che si va rapidamente arroventando nelle nuove dinamiche della guerra fredda, in una Germania divisa e in un’Italia avviata a una faticosa ricostruzione, le nuove logiche delle alleanze e delle contrapposizioni sembrano richiedere una presa di distanza, un tentativo di ricacciare indietro le ombre di un passato che si vorrebbe considerare come una parentesi, dolorosa, angosciosa, ma per fortuna chiusa e finita. Così la memoria dei sopravvissuti rimane una “memoria non autorizzata” e non riconosciuta: una ferita che suscita vergogna, soprattutto in chi non può, come possono, per esempio, i deportati politici, associare alla propria personale tragedia l’orgoglio di una scelta compiuta, di un’opposizione consapevole. Per moltissimi ciò che rimane è l’umiliazione, il degrado, la privazione di ogni residuo di umanità. E’ la vergogna delle vittime uno degli aspetti più inquietanti.
Gli anni Ottanta
Bisognerà arrivare agli anni Ottanta perché il problema riemerga con forza, sia nei risultati della ricerca storiografica che nella relazione con i testimoni. Esce nel 1985 il monumentale lavoro cinematografico di Claude Lanzmann, Shoah. Lo studio storico di Raul Hilberg, La distruzione degli ebrei d’Europa, pubblicato in una prima edizione nel 1961, vede un’edizione tedesca nel 1982 e una prima edizione italiana solo nel 1995. Nel frattempo, però, le indagini si moltiplicano. Una tappa significativa, nel nostro paese, è la pubblicazione, nel 1987, del lavoro di Anna Bravo e Daniele Jalla La vita offesa. Storia e memoria dei Lager nazisti nei racconti di duecento sopravvissuti.
Ma in questo quadro c’è un nodo che s’impone e impone domande che non possono trovare risposta solo nella consueta strumentazione dello storico. Questo nodo si chiama Auschwitz, soluzione finale, Shoah: lo sterminio degli ebrei. Ed è un interrogativo che coinvolge l’autocoscienza dell’Occidente e la sua cultura, l’interrogativo sulla modernità e sulla relazione tra tecniche e valori, l’interrogativo sulla responsabilità, sulla colpa, sull’identità dei soggetti che sono stati protagonisti e attori fondamentali. Le domande che si aprono sono di ordine filosofico, etico e politico e riguardano il presente e il futuro possibile.
Se siamo stati capaci di questo (se qualcuno è stato capace), che cosa possiamo ancora aspettarci dal nostro mondo razionalizzato, tecnicizzato, efficiente fino all’orrore? Le risposte sono diverse e anche molto divergenti, allora come oggi, ma il tema è decisivo.
Shoah
Negli anni, dunque, la questione della Shoah assume una dimensione specifica e trova una risonanza mediatica fino a quel momento ignota. Nell’anno scolastico 2000-2001, a Verona, l’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, in collaborazione con il Provveditorato agli Studi e con la commissione provinciale per la didattica della storia del Novecento, organizza un’indagine rivolta a studenti delle classi quarte di 17 scuole superiori di tutti gli indirizzi. Il tema è L’immaginario della Shoah e l’obiettivo è quello di ricercare che cosa sia presente nelle pre-conoscenze, nelle sensibilità, nei quadri mentali dei giovani interpellati prima che la scuola provveda istituzionalmente ad un intervento didattico organizzato. Vengono raccolti e analizzati 382 questionari. All’esame delle risposte colpisce il fatto che, a prescindere dalle informazioni più o meno dettagliate possedute dai ragazzi, l’immagine più ampiamente diffusa tra di loro sia quella risultante da due film usciti negli anni precedenti, Schindler’s List di Spielberg (1993) e La vita è bella di Benigni (1997). Due film che ottengono un vastissimo successo di pubblico e che, pur nelle rilevanti differenze, hanno in comune il fatto di presentare una lettura, in qualche modo, in positivo: dalla parte dei buoni, dei giusti, una memoria che si apre alla speranza e non disdegna il lieto fine. In questa versione, assai ben confezionata e ben poco inquietante, la Shoah riesce finalmente a diventare oggetto di una comunicazione di massa.
Il dovere di ricordare
All’impatto mediatico si unisce l’impegno più direttamente politico: a Stoccolma, il 26-28 gennaio del 2000, si tiene un Forum internazionale nel corso del quale si approva una dichiarazione che impegna i governi a promuovere la conoscenza e la riflessione sull’Olocausto tra le giovani generazioni. Di seguito, nel luglio dello stesso anno, il parlamento italiano approva la legge che istituisce il Giorno della Memoria e ne fissa la data al 27 gennaio. La memoria si fa pubblica e diventa obbligo istituzionale. Nel giro di pochi anni si assiste a un passaggio rapido dal silenzio al clamore: dove per molto tempo c’era stata la sofferta esperienza della testimonianza individuale e il lavoro paziente e spesso difficile di studiosi e ricercatori, ora prevale la logica della commemorazione. Mentre si allarga lo spettro delle iniziative, alcune di alta e altissima qualità altre meno, la logica dell’accumulo quantitativo sembra a volte prevalere sulla necessità della riflessione e dell’approfondimento. Ne è un esempio l’iniziativa avviata da Steven Spielberg subito dopo la produzione di Schinler’s List, di cui discute, tra l’altro Annette Wieviorka nel libro prima citato. Nel 1994 Spielberg fonda la Survivors of the Shoah Visual History Foundation che, nel giro di pochi anni, raccoglie circa 39.000 interviste videoregistrate, di ebrei. Le interviste sono strutturate su uno schema rigorosamente predisposto in anticipo per quanto riguarda la durata e la distribuzione degli argomenti trattati, protocollo applicato in modo uguale in tutti i Paesi. L’ambizione è quella di sostituire le testimonianze alla storia, il risultato è piuttosto quello di una “industrializzazione del ricordo”, che perde in tal modo ciò che ha di più prezioso, la sua singolarità e lo spessore dell’individualità, mentre, d’altra parte, sembra sfuggire il fatto che nessuna raccolta di ricordi singoli può pensare di sostituirsi all’attività di indagine e di riflessione dello storico. Alle montagne di cadaveri si contrappongono le montagne di videocassette, e il risultato può essere ugualmente straniante. Se Auschwitz, come dice Enzo Traverso, “celebrava il trionfo della morte reificata”, il rischio diventa anche quello di reificare la memoria, e quindi la vita.
Quante memorie?
Un’altra conseguenza di questi sviluppi è che la memoria ebraica dello sterminio tende sempre di più a separarsi da quella delle altre deportazioni. L’altro grande filone molto vitale è quello della memoria dei deportati politici antifascisti. Questo ha trovato uno spazio naturale nell’associazionismo, nonché nella rete nazionale degli Istituti Storici della Resistenza e nelle istituzioni culturali e politiche che fanno riferimento alla memoria civile. L’ANED ne è un esempio importante e dalla stessa ANED è nata nel 1999 la Fondazione Memoria della Deportazione di Milano, attiva sul piano della documentazione e della divulgazione. Se invece si fa riferimento alle “altre deportazioni”, lo scenario è molto meno ampio e completo. Sia che si tratti dei Rom, dei deportati per motivi sessuali o sociali o religiosi, il quadro è molto meno omogeneo e l’indagine è solo parziale e non largamente conosciuta. Solo in tempi molto recenti, per fare un ultimo esempio, si è sviluppato il lavoro e l’interesse intorno agli Internati Militari Italiani, a lungo rimasti in una sorta di limbo o di “terra di mezzo” della storia, come soggetti difficili da definire e da catalogare decisamente come vittime. Dunque, c’è ancora molto da fare.
Quali memorie? Il Giorno del Ricordo
Nello stesso tempo, però, a ridosso delle iniziative legate all’istituzione del Giorno della Memoria, si è scatenata una sorta di rincorsa alla ricerca di altre memorie sommerse da recuperare e rivalutare. Eventualmente da utilizzare come una specie di contrappeso. Non sfugge a questa logica l’avvio del percorso parlamentare che porterà all’istituzione del Giorno del Ricordo, sulle foibe, l’esodo istriano e la storia del confine orientale, con la legge del 30 marzo 2004. Inizialmente presentata dai deputati di Alleanza Nazionale Roberto Menia e Ignazio La Russa, la proposta di legge suscita una nutrita serie di proteste e polemiche e viene vista da diverse parti politiche, ma anche da molti storici, come un’aperta contrapposizione sia alla memoria della Shoah sia alla memoria della Resistenza e alle celebrazioni del 25 aprile. Solo un complesso lavoro in parlamento permetterà di riportarne, almeno in parte, la logica a quella di una necessaria presa in carico, sul piano storico e politico, di una drammatica serie di eventi non riducibili soltanto alla vicenda delle foibe. La sottolineatura nell’art. 1 della legge del “fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale” apre la strada ad un approccio storiografico impegnativo e non solo strumentale, che ha già fornito risultati importanti. Ma non esaurisce del tutto le tentazioni di usare il Giorno del Ricordo, di volta in volta, come propaganda anti-resistenziale o come ennesima dimostrazione del fatto che “alla fin fine sono tutti uguali”.
Che fare?
Per prima cosa, è necessario studiare: semplicemente, banalmente. Non dando per scontato che “si sa già”, solo perché, negli ultimi anni, si è partecipato a un certo numero di giornate della memoria; ma usando fonti di informazione varie e diverse e imparando a riconoscere, per ciascuna, cosa ci può dare e cosa non ci può dare: per esempio la differenza tra il ruolo del testimone e quello dello storico, entrambi importanti ma non assimilabili, oppure tra il fascino del cinema e il dato, più arido ma indispensabile, dell’informazione di base: chi, dove, come, quando, quanti? Per poter arrivare a porsi sensatamente dei perché.
Enzo Traverso invita a temere la “museificazione della storia” e ricorda che così “occultata e anestetizzata, neutralizzata sul piano sociale, la storia può tranquillamente essere imbalsamata e museificata”, dunque tenuta a distanza, “codificata e infine svuotata di contenuto”. Le espressioni di noia e d’impazienza nelle numerosi classi trascinate alle date canoniche in aula magna ad ascoltare qualcuno ci dicono qualcosa in questo senso. Eppure non sono le sole reazioni possibili.
Alberto Cavaglion, per altro verso, suggerisce di non fermarsi alle emozioni: “Stai attento a chi, trattando questi argomenti, cerca di sedurti con le emozioni. Siamo circondati dalla pubblicità che si fa beffe delle nostre emozioni, non sempre le migliori”. Tra commemorazioni obbligate e seduzione dei sentimenti, la tenaglia può produrre, alla fine, semplicemente un’indifferenza mascherata da buona educazione: sappiamo che dovremmo commuoverci, dunque commuoviamoci, sappiamo che dovremmo indignarci dunque indigniamoci. C’è un modo per sfuggire a questa trappola?
Si potrebbe tornare alla domanda precedente: mi riguarda, e come mi riguarda? Ha a che fare con la mia responsabilità e con la mia, e altrui, dignità in quanto essere umano? Anche, queste, non nascondiamocelo, possono rimanere più o meno delle proclamazioni.
Dignità
Una pedagogia della vita
Tenterei, allora, di individuare alcune strade:
- Provare a passare da una pedagogia della morte a una pedagogia della vita. La didattica dell’orrore funziona poco. La visione ripetuta di montagne di cadaveri induce rapidamente il desiderio di voltare la testa dall’altra parte. Le immagini servono: alcune, poche, lasciano il segno. Se usate vanno analizzate e contestualizzate, altrimenti possono solo produrre repulsione. Quando il commento è “non ci posso credere!” siamo abbastanza vicini ad aver perso la nostra partita. C’è un’altra cosa, però, che serve: ridare vita a queste persone. Se c’è un obiettivo che è stato consapevolmente perseguito dagli autori dello sterminio è quello che Hannah Arendt chiama “l’uccisione della personalità morale”. “Rendendo anonima persino la morte […], i Lager la spogliavano del suo significato di fine di una vita compiuta. In un certo senso, essi sottraevano all’individuo la sua morte, dimostrando che a partire da quel momento niente più gli apparteneva ed egli non apparteneva più a nessuno. La sua morte non faceva altro che suggellare il fatto che egli non era realmente mai esistito”.
Restituire un’identità a coloro che sono stati trasformati in numeri senza volto, restituire una storia ai tanti “sommersi” di cui ci dice Primo Levi dovrebbe essere un compito. Recentemente, un’unica foto di un bambino morto su una spiaggia ci ha scosso più che i numeri spaventosi delle migliaia di cadaveri annegati nel Mediterraneo.
Ancora Cavaglion: “In ogni ordine di scuola, non si può spiegare la Shoah se prima non si spiega la storia degli ebrei, della loro cultura, della loro religione. Gli ebrei sono esseri umani come tutti gli altri, la loro storia è fatta di luci e di ombre”. La stessa cosa vale per tutti gli altri deportati, anche se in molti casi ricostruirne storia e identità è ben più difficile che per gli ebrei. Pensiamo, solo per fare un esempio, ai deportati per motivi sessuali. L’antisemitismo è una chiave importante di lettura dello sterminio, e non è l’unica. Non c’è vita sacrificata, non c’è frammento di umanità perduto che non abbia diritto alla sua storia.
Una proposta ai nostri studenti può essere quella di scegliere una storia, ricostruire una biografia, “adottare” una persona vera, magari non una di quelle già molto conosciute, prenderla come compagna di strada nel percorso verso la conoscenza di questa pagina del Novecento. Non per sostituire la storia, ma per tenerla legata alla vita.
Non solo vittime
- Vedere persone e non solo vittime: le persone sono soggettività complesse. Accomunate dal fatto di essere tutte vittime di una stessa macchina infernale, ma in realtà molto diverse tra loro. Un’equazione moralistica del tipo vittime=innocenti=buoni non dà conto interamente della realtà. Non tutte le vittime erano necessariamente oppositori, resistenti, antifascisti. E solo alcuni sono stati colpiti per questo. Il modello ideologico del “perfetto uomo ariano” implica l’annientamento di tutti gli elementi che si classificano come estranei, dannosi o pericolosi rispetto all’obiettivo, e non solo di quelli esplicitamente stigmatizzati come razza degenere e nemica, ma anche degli “anelli deboli” all’interno dello stesso gruppo dominante, come mostrano le pratiche tedesche dell’eutanasia. A tutti costoro non si chiede di certificare il proprio consenso o dissenso rispetto al regime, e in effetti tra le vittime non mancano quelli che avevano aderito consapevolmente al fascismo, per esempio in Italia, o che avevano in qualche modo cercato di venire a patti. Per cui una lettura in bianco e nero, di “buoni e cattivi” non sempre aiuta.
Il male assoluto o la banalità del male?
- Il terzo punto investe un tema particolarmente delicato, perché è stato, ed è tuttora, al centro di un’accesa discussione, in particolare per quanto riguarda lo sterminio degli ebrei: è possibile identificare Auschwitz come “il male assoluto” e, pertanto, come un fatto metafisico, sovra-storico, irripetibile e inavvicinabile con i normali strumenti di comprensione della storicità? Collocando quindi questa vicenda e i suoi responsabili in una dimensione “altra” rispetto a quella della storia, e quindi, anche, assolutamente non paragonabile con altri eccidi e altri genocidi? Il rischio di arrivare in questo modo a sacralizzare l’Olocausto, inscrivendolo nel percorso della rivelazione profetica più che in quello della vita degli uomini, è stato da varie parti segnalato. E se è vero che si cerca in questo modo di salvaguardare l’unicità dell’evento e la potenza degli interrogativi che esso impone a qualsiasi essere umano, è anche vero che si rischia così di collocarlo in una sfera che sfugge alla responsabilità e immobilizza la memoria in un’apocalisse fuori dal tempo. Nello stesso tempo rischiando di catalogare come “mali minori” l’impressionante serie di massacri e di violenze che hanno costellato la storia del Novecento e che tuttora sono di fronte a noi.
Il male assoluto presuppone, d’altra parte, un protagonista altrettanto assoluto: il soggetto che esercita questo non può che essere segnato nella sua natura profonda, votato dall’origine all’odio e alla violenza, carnefice per convinzione e per vocazione. Il demonio, insomma. Nei confronti del quale non è possibile alcuna azione se non quella uguale e contraria: eliminarlo, distruggerlo. E’ da escludere che “uomini comuni”, come nel titolo della ricerca di Christopher Browning, possano trasformarsi in feroci macellai, capaci di sterminare migliaia di donne e bambini in un brevissimo arco di tempo. E’ inquietante, e per alcuni del tutto intollerabile, l’immagine dell’oscuro burocrate, del grigio tecnico dello sterminio, che con poca ideologia e poco odio si applica efficacemente al compito di organizzare in mezza Europa i carichi dei deportati destinati alle camere a gas. Quando, nel 1963, Hannah Arendt pubblica con il titolo La banalità del male i suoi resoconti sul processo contro Eichmann a Gerusalemme, ne nasce una vera sollevazione contro di lei, un rifiuto aspro anche da parte di alcuni dei suoi migliori amici ebrei. Il fatto è che a ciascuno di noi riesce difficile accettare l’idea che gli artefici dei peggiori delitti possano essere non dei “delinquenti nati” o elementi appartenenti ad una qualche setta esoterica, ma persone che, in altri contesti sociali e storici, potrebbero essere nostri vicini di banco, colleghi di ufficio. Persone “normali”. Eppure la storia, anche nelle sue manifestazioni più atroci, è comunque il frutto delle azioni degli uomini. Altri punti di vista, da quello religioso a quello psichiatrico, possono ricercare altre motivazioni. Noi, se di storia vogliamo parlare, dobbiamo dire che nella storia il male esiste, il demonio no; esiste la follia, non esiste la follia collettiva come spiegazione storica. E spiegare non significa in nessun modo giustificare, ma tentare di capire è essenziale, se non si vuole correre il rischio di cadere in pericolose semplificazioni. La domanda sul perché va posta.
Attenzione ai confronti
- Attenzione ai confronti: a fronte dei problemi sollevati dalla “assolutizzazione” dello sterminio, ce ne sono altrettanti legati alla banalizzazione: da sempre, nei secoli, ci sono state vicende analoghe. Mettiamo allora insieme un po’ di tutto, dal genocidio degli indigeni americani alla tratta degli schiavi, dalle crociate al terrorismo contemporaneo, per concludere che, sì, l’aggressività è un istinto ineliminabile negli esseri umani, siamo sempre stati un po’ bestie, non possiamo farci niente e quindi la conclusione pratica che ne viene è che è meglio che ciascuno cerchi di proteggere se stesso, di coltivare il proprio orto, di non impicciarsi di cose più grandi di lui e, se proprio è necessario, di venire a patti con chi comanda e non pretendere troppo di fare di testa propria.
Questa considerazione ci riporta di colpo nel mondo di oggi. Ci riporta alla questione del come questa storia ci riguarda e ci interroga su quello che siamo e quello che vogliamo essere. Riapre il tema della responsabilità, dei valori e delle scelte. Di quelle “virtù quotidiane”, che non sono necessariamente “virtù eroiche” e che ci permettono di confrontarci con l’altro senza zuccherosi ottimismi, ma anche cercando di evitare di trasformare ogni giorno di più il volto dell’altro in una maschera minacciosa. Le virtù di cui abbiamo bisogno oggi forse non sono quelle dei grandi oratori, ma quelle dei pescatori di Lampedusa, che comunque cercano di non lasciar morire le persone in mare. E anche per questo ci vuole molto coraggio.
Bibliografia
- Barazzetti, C. Leccardi, a cura di, Responsabilità e Memoria, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1997
- Jedlowski, Il sapere dell’esperienza, Il Saggiatore, Milano 1994
- Halbwachs, La memoria collettiva, Unicopli 2001
- Le Goff, Documento/monumento, in Storia e memoria, Einaudi, Torino 1982
- Wieviorka, L’era del testimone, Raffaello Cortina 1999
- Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino 1986
- Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, Bollati Boringhieri, Torino, 1991
- Bravo, D. Jalla, La vita offesa. Storia e memoria dei Lager nazisti nei racconti di duecento sopravvissuti, Franco Angeli 1987
- Jonas, Il concetto di Dio dopo Auschwitz, Il Melangolo, Genova 1990
- Jaspers, La questione della colpa: sulla responsabilità politica della Germania, Raffaello Cortina Editore, Milano 1996
- Bauman, Modernità e Olocausto, Il Mulino 2010
- Todorov, Di fronte all’estremo, Garzanti, Milano 2011
- La Terza, a cura di, L’immaginario della Shoah. Gli studenti veronesi e la percezione dello sterminio. Risultati di un’indagine, Cierre, Verona 2005
- Traverso, Fare i conti col passato. Storicizzazione del nazismo e memoria dei vinti, in Insegnare Auschwitz. Questioni etiche, storiografiche, educative della deportazione e dello sterminio, a cura di E. Traverso, IRRSAE Piemonte, Bollati Boringhieri 1995
- Cavaglion, Piccoli consigli al ventenne che in Italia studia la Shoah, in Ebrei senza saperlo, L’ancora, Napoli 2002
- Arendt, Le origini del totalitarismo, Comunità, Milano 1996
- Arendt, La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, Feltrinelli 2001
- Browning, Uomini comuni. Polizia tedesca e “soluzione finale” in Polonia, Einaudi, Torino 1995
Note:
[1] P. Jedlowski, Il sapere dell’esperienza, Il Saggiatore, Milano 1994, pag. 112
[2] M. Halbwachs, La memoria collettiva, Unicopli 2001
[3] Il corso, che si è tenuto a Verona fra ottobre 2015 e gennaio 2016, aveva per titolo proprio “Lezioni sulle deportazioni”.





















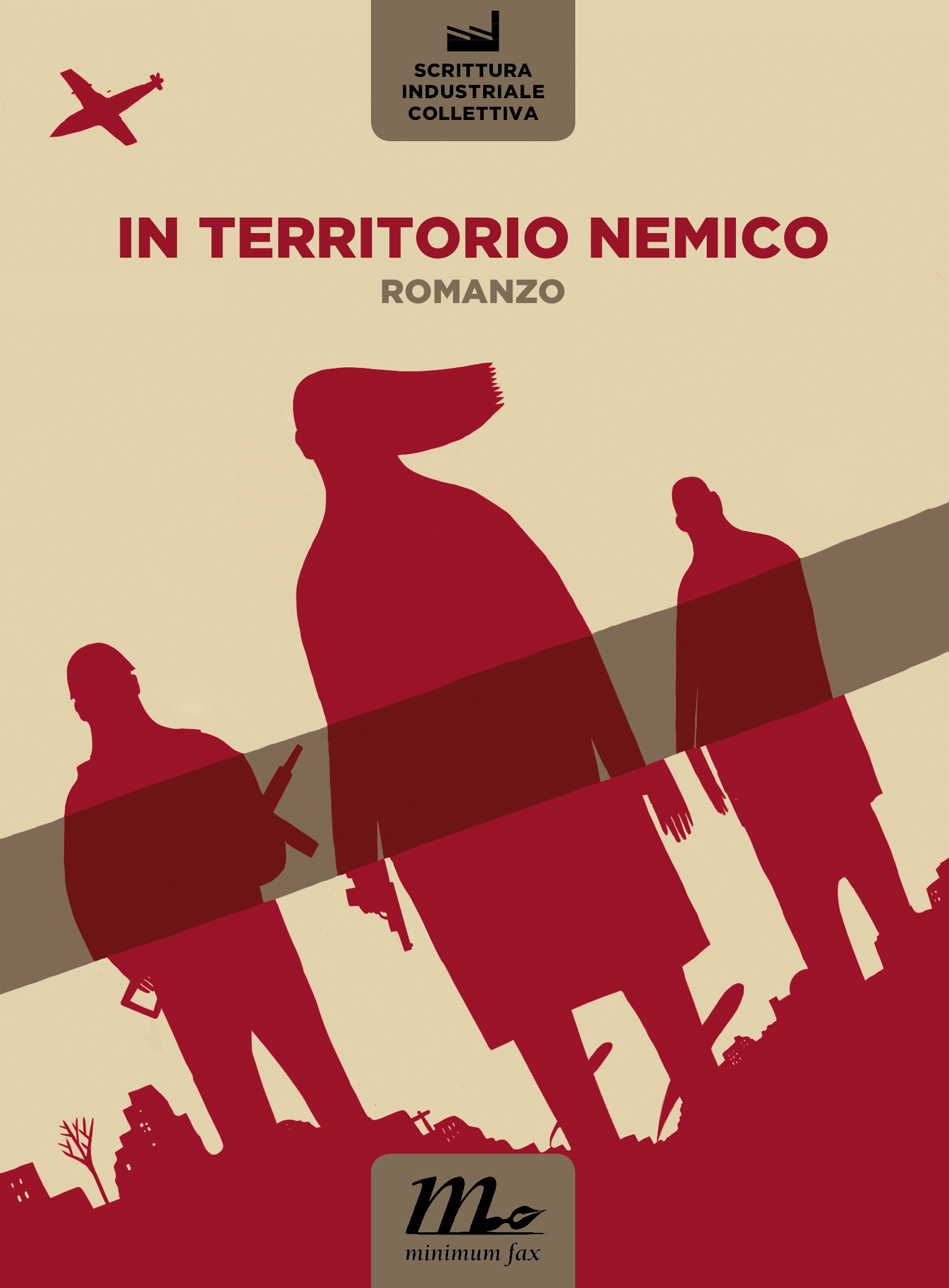

 Scarpe rotte eppur bisogna andar. Una storia della Resistenza in 30 oggetti, a cura di P. E. Boccalatte e M. Carrattieri
Scarpe rotte eppur bisogna andar. Una storia della Resistenza in 30 oggetti, a cura di P. E. Boccalatte e M. Carrattieri L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore
L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino
Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio
Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa
Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice
Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli
Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli L’arresto degli arlecchini
L’arresto degli arlecchini