
Per una storia dell’Europa contemporanea. Intervista ad Alberto De Bernardi

Scultura “L’Unità nella pace” voluta dalla Commissione europea e realizzata dall’artista francese Bernard Romain. L’opera si trova nel cuore del quartiere “europeo” di Bruxelles.
Di Bernard Romain – Opera propria, CC BY-SA 3.0, Collegamento
Abstract
Nel corso dell’anno scolastico 2019/20 lo sportello Europe Direct dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Istituto Storico Parri, ha curato un corso di formazione docenti dal titolo “A scuola d’Europa. Corso di educazione civica europea”.
Il corso, bruscamente interrotto a causa della chiusura delle scuole per l’epidemia di Covid-19 e che si concluderà a distanza nel corso del mese di maggio, si è inaugurato con una lectio di Alberto De Bernardi dal titolo “Per una storia dell’Europa contemporanea”.
Per la rubrica “Pensare la didattica” abbiamo chiesto al professore di trasformare la sua lezione in un’intervista. Come nasce l’idea di Europa che ha reso concretamente possibile il progetto dell’UE? Come si può inquadrare la sua storia nell’ambito dell’insegnamento nella scuola secondaria?
In coda abbiamo aggiunto una domanda che non avremmo potuto immaginare nel novembre scorso e che riguarda la tenuta dell’Europa nello scenario della pandemia in corso.
Agnese Portincasa
Si parla tanto e da molto tempo del fatto che sia necessario lavorare sull’educazione alla cittadinanza europea, ma difficilmente si ragiona su come farlo. Non ci sono dubbi sul fatto che gli approcci, anche disciplinari, possano essere molteplici; e tuttavia qui ci interessa entrare nel merito di quello specifico modo che può essere indicato da uno storico. Quale potrebbe essere la fase iniziale di una periodizzazione entro la quale un docente dovrebbe lavorare nella sua classe? Da dove di potrebbe partire?
Alberto De Bernardi
Può sembrare un’affermazione banale, ma alle origini dell’Europa unita ci sta l’europeismo: cioè un’idea e un progetto che prima di essere politico è stato un ideale quasi utopico. Un’utopia che ha avuto, però, una lunga e complessa gestazione perché ha affondato le sue radici nello stesso processo che ha dato vita alla democrazia e allo stato di diritto. Come hanno sottolineato Federico Chabod e Lucien Febvre in due famosi corsi universitari tenuti tra il 1943 e il 1945 a Milano e a Parigi, l’Europa non è una “espressione geografica”, ma un costruzione culturale, che affonda le sue radici nella convinzione che i popoli che abitano questa incerta propaggine dell’Eurasia abbiano una serie comune di tradizioni storiche, di valori culturali e di credenze religiose che li accomunano al di là delle loro appartenenze nazionali o etniche.
La prima questione da porci e quando questa idea sia apparsa all’orizzonte del dibattito culturale, e a questo interrogativo possiamo dare una risposta plausibile: agli inizi del Settecento. Nel 1713 l’Abbé de Saint-Pierre (1658-1743) – che per molti aspetti può essere considerato un antesignano del movimento illuminista – pubblica il suo Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe. Un’opera che esce all’indomani della stipula del Trattato di Utrecht che poneva fine alla Guerra di successione spagnola, guerra che aveva dissanguato l’Europa per un quindicennio.
Il progetto dell’Abbè de Saint-Pierre prevedeva la creazione di un’istituzione sovra-nazionale, una sorta di «union européenne», organizzata come un congresso arbitrale di rappresentanti dei singoli Stati stabilmente insediato che lavorasse a risolvere giuridicamente le controversie internazionali e ad assicurare regole condivise, garantendo pace, sicurezza e stabilità agli Stati membri. I sovrani e le repubbliche europee aderenti s’impegnavano a cedere una porzione della loro sovranità sottomettendosi a leggi comuni e sentenze destinate a sanzionare le violazioni. Un esercito costituito con il supporto di ogni nazione avrebbe assicurato la certezza dell’applicazione delle sanzioni e un intervento di ripristino dell’ordine originario in caso di rivolte interne.
Va detto che l’Europa unita prefigurata dal gesuita era più simile, potremmo dire oggi, alle Nazioni Unite che non all’effettiva costruzione europea cosi come si è realizzata nella seconda metà del XX secolo, e s’inseriva in un filone di pensiero che si era manifestato all’indomani della conclusione delle guerre di religione. Negli anni a ridosso della Pace di Westfalia (1648) alcuni intellettuali avevano ipotizzato la creazione di organismi universalistici deputati al mantenimento dell’ordine internazionale. Ma il progetto dell’abate gesuita andava oltre queste elaborazioni, perché il Projet era steso in forma di un vero e proprio trattato, fondato su tre punti di forza quasi profetici, che avrebbero avuto un peso anche in futuro:
- l’assunzione della sovra-nazionalità come antidoto alla guerra e la cui fondatezza risiedeva sul principio della cessione di sovranità degli stati a una legislazione comune;
- la scala territoriale proposta: l’universalismo si limitava alla sola Europa, intesa come un’unità storica, al di la delle sue divisioni politiche e statuali;
- il convincimento che solo entità giuridiche sovranazionali potessero garantire la pace.
E d’altronde già Thomas Hobbes (1588-1679) aveva indicato come lo stato moderno si fondasse sulla cessione di sovranità degli individui a un’entità superiore.
L’Europa era un continente che si stava affermando come grande e unica potenza mondiale; potenza che s’incarnava di volta in volta nella Spagna, nell’Olanda, nella Francia e infine nell’Inghilterra; ma che, soprattutto, si era riconosciuta nello jus publicum europaeum di Ugo Grozio (1583-1685) e di Jean Bodin (1529-1596), vale a dire in una forma originaria di diritto internazionale che sanciva lo spazio di legittimità della guerra interstatale. Nel nuovo Nomos – per dirla con Carl Schmitt (1888-1985) – dello stato moderno, che costituisce lo strumento politico e istituzionale dell’egemonia planetaria europea, il fulcro non è la guerra, ma l’equilibrio degli stati, cioè il loro reciproco riconoscimento come fondamento della stabilità continentale (perno delle relazioni internazionali fino alla Prima guerra mondiale).
Il primato europeo non è dunque assicurato solo dalla combinazione di potenza economica e potenza militare – come suggerisce lo storico Paul Kennedy – e non è solo strettamente connesso alle rivoluzioni scientifiche e filosofiche di quei secoli che hanno fatto del continente europeo la sede di una civiltà che si considera superiore, ma è anche fondato sullo sforzo di costruire un ordine internazionale la cui finalità era il mantenimento della pace e nel presupposto del riconoscimento di una condizione comune.
Si potrebbe dunque dire che nel pensiero del gesuita Saint-Pierre si possano leggere le origini di quell’idea di delega della sovranità per finalità di pace che sarà poi assunta nel secondo dopoguerra? Ma se così fosse si deve intendere che ci sia stato un lungo salto fra il Settecento e il Novecento?
Senz’altro no. Qualche decennio dopo il Projet dell’Abbe di Saint-Pierre altri elementi si sarebbero aggiunti e avrebbero avuto un peso decisivo nella definizione del profilo ideale dell’europeismo. Nel 1748 L’ esprit des lois di Montesquieu (1689-1755) fornisce la definizione dello stato di diritto basato sulla separazione dei poteri da cui deriva l’esaltazione della repubblica come alveo istituzionale più confacente perché quell’esprit potesse a pieno dispiegarsi. Ma nell’opera di Montesquieu c’è assai di più ai fini delle nostre riflessioni: emerge il grande tema dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e il problema cruciale dei limiti del potere politico. Si afferma l’idea che esista uno spazio individuale e civile autonomo indisponibile al potere politico, ma anche e soprattutto che la libertà trovasse il suo limite nella legge: la libertà è il diritto di fare ciò che le leggi permettono. Solo pochi anni dopo Voltaire (1694-1778) pubblica Essai sur les mœurs et l’esprit des nations (1756): il compendio del suo universalismo razionalista che già nel titolo richiama la riflessione di Montesquieu, ma che si proietta nell’ambito di una visione della storia umana risolta nello spirito della tolleranza come antidoto alla schiavitù e alla violenza. «Siamo tutti figli della fragilità – avrebbe scritto nel Traité sur la tolérance del 1763 – fallibili e inclini all’errore. Non resta, dunque, che perdonarci vicendevolmente le nostre follie. È questa la prima legge naturale: il principio a fondamento di tutti i diritti umani». Ed ecco un’altra locuzione essenziale: i diritti umani son un elemento costitutivo di quello che potremmo definire l’identità europea che si viene formando in quest’ultimo scorcio di età moderna. E non si può concludere questa rassegna di idee fondanti senza citare Adam Smith (1723-1790) che in An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776) mette in luce la centralità del mercato e della libertà d’impresa come centro propulsivo della forza economica dell’Europa, ma anche come espressione profonda della libertà individuale e della autonomia della società civile.
Alla fine del XVIII secolo erano dunque queste le idee “europee” in campo, Si potrebbe allora pensare di raccontare agli studenti l’Europa dalla diffusione di queste idee che, di fatto, cominciavano a definire il perimetro di un racconto, di una narrazione capace di fare l’Europa, assumendola come spazio sovranazionale, riconoscibile oltre le differenze e dei conflitti tra gli stati, delle diversità delle istituzioni politiche e delle divergenze culturali: uno spazio più grande e impegnativo della somma delle parti statuali che lo componevano.
Ma è davvero così? Si può cogliere una continuità fra il pensiero dell’Abbé de Saint-Pierre e i nomi dei grandi pensatori enumerati e che arrivano a definire e rafforzare – molto probabilmente senza alcuna intenzione – la sua intuizione?
Non proprio. Innanzitutto perché il nostro abate gesuita è stato un uomo sconfitto, non solo dalla storia – il XVIII fu un secolo di guerre spaventose: altre due guerre di successione, ma soprattutto la Guerra dei sette anni che contrappose Inghilterra e Francia per il dominio atlantico e che può a tutti gli effetti essere considerata la prima guerra mondiale – ma anche sul piano politico. Emarginato dalla corte ma soprattutto dagli intellettuali illuministi, da Voltaire a Rousseau che lo considerarono un visionario velleitario. E Proprio Rousseau si domanda:
«Possiamo sperare di sottomettere a un Tribunale superiore degli uomini come i principi, che osano vantarsi di mantenere il potere con la spada e che si rivolgono a Dio solo perché è in cielo? Un qualunque gentiluomo offeso si rifiuta di ricorrere al tribunale dei marescialli in Francia, e voi volete che un re ricorra alla Dieta europea? E ancora c’è questa differenza, che il primo quando viola la legge mette in gioco la propria vita, mentre il secondo mette in gioco la vita dei suoi sudditi, usando un diritto, quello di prendere le armi, riconosciuto da tutto il genere umano e di cui pretende di render conto solo a Dio […]. Non bisogna credere, come fa l’Abbé de Saint-Pierre, che solo con la buona volontà, che i principi ed i loro ministri non avranno mai, ci potrà essere un momento favorevole per realizzare questo sistema, poiché occorrerà che la somma degli interessi particolari non prevalga sull’interesse comune, e che ciascuno creda di vedere nel bene di tutti il più gran bene che possa sperare per sé».
È dunque un’utopia irenica, irrealizzabile, estranea alle variabili concrete che si muovono nello spazio politico reale. Ma se di utopia si tratta, non muore con il suo ideatore perché nel 1795, quando ormai erano giunte a compimento sia la Rivoluzione americana che quella francese Immanuel Kant (1724-1804) nel suo trattato Per una pace perpetua, riprende molte delle considerazioni dell’abate fondando la possibilità di un ordine europeo pacifico sulla forza del federalismo interstatale e su un fondamento giuridico nel quale si combinino un costituzionalismo repubblicano, all’interno dei singoli stati, un diritto internazionale basato, appunto, su un federalismo di liberi stati, e un diritto cosmopolitico che recepisca il diritto universale del libero movimento delle persone e dell’accoglienza. Siamo di fronte al programma formulato da un genio politico che non affidava la realizzazione della pace tra le nazioni alla bontà degli uomini, ma al primato della legge, unica forza capace di tradurre in convenzioni valide per tutti il comune destino dell’Europa.
Sulla parola destino è opportuno soffermarsi perché è un termine che richiama alcune retoriche delle attuali spinte sovraniste ed è molto importante provare a lavorarci. Come posso spiegare agli studenti che cos’è una comunità di destino? E in che senso le nazioni sono state a lungo identificate come le uniche detentrici capaci di contenere e narrare proprio quel destino in cui i singoli possono identificarsi?
È un nodo essenziale. Kant richiama la storia di un’Europa luogo in cui si riconosce una Civilisation eccezionale rispetto al resto del mondo. Invece nel corso dell’Ottocento accade altro e le nazioni diventano, appunto, il luogo entro cui si gioca la gran parte della politica continentale. La Civilisation che era nelle pagine di Per una pace perpetua presupponeva una “nazione mite”, in cui la ricerca d’identità e forza non mettessero in discussione l’accettazione di essere subordinate all’idea progressista dell’umanità intera da un lato e dall’altro di quell’equilibrio tra gli stati capace di recepire le spunte nazionalistiche degli stati periferici. Un esempio di questo equilibrio è lampante proprio parlando dell’Italia: l’idea di nazione come frutto di “plebiscito quotidiano” – come nella celebre definizione di Ernest Renan (1823-1892) – espresso dei suoi cittadini operanti in libere istituzioni politiche, nulla ha a che vedere con l’idea di nazione basata sul sangue e sulla terra e con una visione delle relazioni internazionali basate sul principio della potenza e dello scontro incessante per l’egemonia mondiale. Eppure è stata esattamente questa idea del nazionalismo a imporsi nello spazio pubblico europeo dopo la Guerra franco-prussiana e l’apertura dell’età del colonialismo. Il nazionalismo “mite” era riuscito a garantire la pace per un secolo: l’Ottocento della borghesia e del movimento operaio, dei Risorgimenti e del progresso aveva costruito un meccanismo ben oliato sul quale poggiare l’equilibrio continentale magistralmente descritto da Karl Polanyi (1886-1964) ne La grande trasformazione (1944): un intreccio virtuoso tra industrialismo e alta finanza, stato liberale capace di allargare, seppur lentamente, le proprie basi sociali, sistema monetario basato sulla base aurea e mercato autoregolato, ma con la presenza della “mano visibile” dello stato.
E allora si potrebbe dire che l’Europa delle nazioni capaci di un nazionalismo “mite” termini definitivamente con la Prima Guerra Mondiale. È così?
Il titolo di una recente pubblicazione di Emilio Gentile recita Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo (2014) e sintetizza la frattura rappresentata dalla Prima guerra mondiale. Muore un mondo, muore quella Civilisation europea che aveva affondato le sue radici nello spirito dell’89, cioè nel messaggio progressista della Rivoluzione Francese che potremmo dire aveva incarnato nella storia concreta gli ideali dell’illuminismo – oltre naturalmente le sue contraddizioni – la cui vitalità culturale, la cui forza egemonica e la cui durata secolare proprio quel meccanismo aveva garantito. Un mondo e una civiltà europea di cui parlarono da testimoni e con rimpianto sia Sigmund Freud nelle Considerazioni attuali sulla guerra e la morte (1915) sia John Maynard Keynes ne Le conseguenze economiche della pace (1919).
Come si esce da questa impasse? Come si passa dalla morte dell’idea fondante di un’Europa unita alla fondazione concreta dell’Europa unita?
Per paradosso il dominio del mondo che proprio con la guerra le nazioni imperiali europee avevano raggiunto metteva in luce come quella civiltà si considerasse pienamente legittimata a dominare gli altri continenti grazie alla sua superiorità. In particolare è stato Max Weber (1864-1920) che ai primi del Novecento si è posto il compito di spiegare – attraverso il confronto con il diverso corso delle grandi civiltà orientali – l’eccezionale sviluppo europeo, a suo avviso caratterizzato dal progresso del razionalismo e dello spirito di libertà. Si può dire che Weber sia stato l’unico grande scienziato sociale ad aver posto la nozione stessa di Europa nel cuore della “modernità”.
Nella sostanza ciò che senz’altro muta dopo la Prima guerra mondiale è la geografia: l’idea di Europa si afferma allargandosi verso est, abbandonando quella nozione «stretta» che Voltaire aveva teorizzato nel secolo dell’Illuminismo. È l’Europa delle piccole nazioni e dei pan-movimenti, ma anche la Mitteleuropa, con i suoi forti contrasti tra città e campagna, tra intellettuali e contadini, l’Europa crogiolo di religioni.
Questo passaggio verso una diversa geografia è cruciale per capire la storia del secolo scorso. «L’Europa del Novecento va guardata da Odessa» – ha scritto lo storico Dan Diner nel 1999 – ed è da lì che va ricostruita la storia della Shoah, la storia del fallimento delle democrazie apparentemente vincitrici dopo la Prima guerra mondiale. È da lì che occorre partire per comprendere il successo – oltre che le contraddizioni – della costruzione europea avvenuta nella seconda metà del secolo: quell’Europa orientale uscita dal collasso degli imperi ha imboccato strade politiche ambiguamente e mai completamente schierate fra il richiamo e il rifiuto della tradizione liberale ottocentesca.
Interessante questa suggestione attorno a una nuova geografia. È uno spunto didatticamente produttivo, anche se non so se un docente potrebbe mai impostare un simile ragionamento affidandosi alla narrazione manualistica. Tornando più sul piano dell’evenemenziale: come si passa dalla distruzione di un’idea di Europa alla sua riproposizione concreta?
Fra la Prima e la Seconda guerra mondiale erano stati messi in campo tentativi di costruire organizzazioni capaci di arginare le pulsioni distruttive che la rottura di civiltà aveva provocato. Si pensi, solo per fare uno fra gli esempi più noti, allo scambio di lettere – sotto l’egida della Società delle Nazioni – tra Sigmund Freud e Albert Einstein su Perché la guerra (1932).
A dire il vero si è soliti leggere la storia dei tentativi democratici tra le due guerre soprattutto come una storia di fallimenti – il che è indubbio –, e tuttavia una storiografia più attenta al lungo periodo ha rintracciato proprio nella Società delle Nazioni il luogo di elaborazione di una visione “regionale” della crescita economica europea, oltre che a uno spazio concreto di formazione delle classi dirigenti. È qui che si sperimentano per la prima volta organismi di regolazione finanziaria, tentativi di creazione di un’Europa sociale (si pensi all’Organizzazione Internazionale del Lavoro-OIT che elabora una collaborazione corporativa in funzione della stabilità) e di collaborazione per settori produttivi (anticipando, di fatto, la Comunità europea del carbone e dell’Acciaio-CECA).
Si pensi, ancora per restare nell’ambito della Società delle Nazioni, al progetto di Stati Uniti di Europa presentato da Aristide Briand (1862-1932) nel settembre 1929; alla collaborazione che si mantenne fra questi organismi e i vari paesi, Italia compresa, fino al 1934-35; all’influenza di figure come Albert Thomas (1878-1932) o Richard Nikolaus di Coudenhove-Kalergi (1894-1972).
Di fatto se è vero che la crisi economica del 1929 blocca il memorandum sugli Stati uniti d’Europa, è vero pure che in quegli stessi anni nasce il New Deal; si affermano le tendenze neo corporative ma anche le prime influenze del keynesismo; scoppia la ‘guerra civile europea’ ma la Società delle Nazioni è ancora viva.
Negli anni Trenta l’idea di Europa, ricorda Marcello Verga nel suo Storie d’Europa, assume su di sé tanto la “nozione di crisi” (il dominio dal panico e dalla paura, come nella definizione di Marc Bloch del 1935) quanto quella di “rifugio”, di “un’ulteriore speranza di salvezza” (si pensi a quanto sostenevano, tra gli altri, Benedetto Croce e Johan Huizinga), in un mondo che stava entrando nella tempesta bellica totalitaria.
Ne dobbiamo dedurre che, anche se debolmente, l’idea di Europa non si perde? Nemmeno nei momenti più bui?
Mai. Basterà questo esempio. Come ho anticipato all’inizio a questa idea di Europa/salvezza dettero una forma e un messaggio di speranza per il futuro due grandi storici che tra il 1943 e il 1944 – nel periodo più duro della Seconda guerra mondiale – tennero due cicli di lezioni destinati a lasciare un segno sia culturale che politico. In un continente distrutto e sconvolto dalla guerra Febvre e Chabod – il primo al Collège de France, il secondo all’Università di Milano – cercano di rintracciare i fili perduti e spezzati di una Civilisation ormai distrutta. Nella premessa al suo corso, Chabod mette in luce il suo fine ideale spiegando come fosse ancora possibile riconciliare l’idea di Europa con quella di nazione, l’unità della civiltà europea con la molteplicità dei toni nazionali. Perché l’Europa potesse trasformarsi «da pura nozione in aspirazione e volontà, da mero acquisto dell’intelletto in fattore sentimentale e volitivo, da “conoscenza” in “valore”».
È davvero incredibile se ci si pensa: in un’università che possiamo immaginare fatta di aule semivuote, in due città fiaccate dalla guerra e mentre molti europei pensano sia tutto perduto, due intellettuali tengono un corso, quasi contemporaneamente e senza sapere l’uno dell’altro, dedicato all’Europa, con la fiducia instancabile di vederla rinascere.
E tuttavia restava la questione più difficile: oltre le aule di università, come farla quest’Europa che non poggiava su alcuna realtà?
La risposta giungerà da un luogo impensabile e imprevedibile. A Ventotene quattro giovanissimi antifascisti erano chiusi nel carcere di un’isola sperduta: Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni e Ursula Hirschmann.
Con il loro manifesto calarono il disegno e la tradizione ormai secolare dell’Europa dentro il nuovo contesto ideale e politico dell’antifascismo liberaldemocratico e socialista, puntando su un nuovo federalismo tra gli Stati che superasse e tenesse a bada gli spiriti animali e sempre riemergenti del nazionalismo. Un disegno che era capace di cogliere la domanda d’inclusione sociale che proveniva dal mondo del lavoro che non solo aveva subito le distruzioni della guerra, ma che aveva dato un contributo notevole nel riscatto del vecchio continente impegnandosi nella lotta antifascista.
Potremmo dire che la risposta del Manifesto di Ventotene può essere sintetizzata come il raccordo fra l’idea degli stati uniti d’Europa, più il welfare, più la democrazia. Come a spiccare un salto e una discontinuità esplicita da quell’Europa liberale che il fascismo aveva travolto, per andare oltre il formalismo giuridico dello stato di diritto, verso uno stato democratico nuovo capace di fondare sui diritti sociali la nuova cittadinanza antagonistica a quella razziale e militare dei totalitarismi.
Chiusi dentro le mura di un carcere questi giovani respirano, sentono, il clima di ricostruzione del mondo mentre ancora si stava combattendo, su tutti i fronti, la guerra tra democrazia e totalitarismo. La loro vicenda esemplifica con chiarezza che la guerra “antifascista” iniziata nel 1943 era uno scontro tra concezioni del mondo: tra libertà e oppressione, tra warfare e welfare; per la costruzione di una nuova Europa che non fosse quella dei sudditi della Germania e dell’Italia totalitarie. È la risposta alla dominazione di tipo ‘coloniale’ e razzista della Germania nazista, la rivolta spirituale e culturale nell’Europa occupata: la cosiddetta “guerra civile” europea che sarà combattuta tra fazioni opposte di cittadini della stessa nazione con l’obiettivo di rifondare non solo il proprio paese, ma l’Europa tutta su principi comuni di libertà e di cittadinanza. Non va dimenticato, infatti, che dei 55 milioni di morti che si calcolano per la seconda guerra mondiale, 40 sono stati europei.
Siamo partiti con un’utopia e torniamo a un’utopia. Come definire diversamente l’idea di quattro confinati in un’isola del Mediterraneo che scrivono un manifesto di pace e solidarietà mentre l’odio della guerra più spaventosa della storia sta distruggendo tutto il mondo che loro avevano conosciuto?
Credo sia esattamente questo il punto. Nella temperie che aveva già steso la Carta atlantica, che aveva già rifondato a Bretton Woods l’ordine monetario internazionale riscoprendo un nuovo gold exchange, nella quale William Beveridge aveva già dato corpo al progetto universalistico dello stato sociale servendosi della lezione di Keynes, i nostri quattro antifascisti elaborano la loro grande utopia: tentare di mettere insieme nazioni e istanze federaliste sovranazionali per rifondare una comunità di stati europei che basasse la sua legittimità non sull’idea di eccezionalità e della superiorità scientifica e culturale utilizzata per secoli per sostenere il proprio dominio politico-militare extraeuropeo, ma su un insieme di strumenti istituzionali a base democratica capaci di garantire benessere per il più vasto numero dei suoi cittadini e modello di governo per i non europei. Come ha scritto Norberto Bobbio, alla base di questa ricetta:
[…] vi è un accordo, un compromesso tra una pluralità di storie nazionali diverse, al quale la politica nazionale sa di doversi sottomettere, rinunciando a una parte della propria sovranità per non ricadere nel tunnel dell’imperialismo razziale.
La vittoria di questa visione dell’Europa durante la Seconda guerra mondiale consente l’emergere di un’idea d’Europa che potremmo chiamare di tipo “funzionalista” e che è ben rappresentata da Altiero Spinelli o da Jean Monnet: l’Europa come processo che si realizza nel tempo attraverso una continua implementazione giuridica e istituzionale e non come idea da affermare, l’Europa che è tutta da costruire, perché è più della somma delle sue parti. Si pensi alla consapevolezza, negli scritti postbellici di Monnet, dello stretto legame tra prospettiva europea e soluzione del problema Germania o all’interesse di una concezione che, secondo quanto osservato da Ennio Di Nolfo, dava rilievo «con grande anticipo, al primato che le questioni dell’ordine internazionale avrebbero acquistato rispetto a quelle dell’ordine interno».
Dopo il crollo della Seconda guerra mondiale è solo abbandonando ogni desiderio di costruzione identitaria che i padri fondatori dell’Europa unita elaborano il linguaggio di un possibile terreno “democratico-istituzionale” di convivenza e di solidarietà, quello che era mancato fra le due guerre. Un terreno democratico costituzionale costruito per adattarsi e contemporaneamente essere accolto nei principi fondamentali dei testi costituzionali: si pensi alle costituzioni di Francia Germania e Italia del Dopoguerra che si connotano per la combinazione di diritti civili e diritti sociali.
Possiamo considerare quest’ultima affermazione come la conclusione di un percorso delineato a partire dall’opera dall’Abbé de Saint-Pierre?
Forse si può leggere come un percorso. Certo è evidente che, per la prima volta dopo la pace di Westfalia nel 1648, l’Europa guarda dentro se stessa e cerca una propria collocazione nel mondo – il mondo occidentale, quello che sempre più spesso sentiamo definire come Global West – a partire non dalla volontà di potenza militare – il testimone, come ha spiegato vent’anni fa Paul Kennedy, teorico del nesso tra potenza economica e potenza militare, è passato a metà Novecento agli Stati Uniti – ma di ricostruzione materiale e morale della propria comunità. E in un certo senso è proprio questa disgiunzione tra potenza industriale e potenza militare che spiega il grande successo della ricostruzione postbellica europea; sono i cittadini europei che conoscono una vera età dell’oro (anche in virtù del loro essere baluardo e vetrina rispetto alla sfida dei paesi comunisti oltre la cortina): l’economia gira in funzione della crescita di un PIL che non prevede spese militari per ciascun Paese, ma solo per la partecipazione della comunità europea alla più vasta comunità occidentale (NATO).
Si tratta di un aspetto che non dovrebbe essere sottovalutato: l’Europa non sarà più una grande potenza – ancora nel senso che questo termine ha per Paul Kennedy –, e gli storici degli anni Sessanta e settanta del Novecento si affanneranno a spiegare le cause del suo dwarfing, del suo diventare nana. Eppure è proprio scindendo le sue sorti dal dominio della propria potenza militare che l’Europa si garantisce una nuova forma di esistenza nel mondo postbellico. Collocandosi dentro il vasto mercato occidentale, ponendosi come modello di benessere economico e civile, l’Europa esiste. Un fatto che avrà conseguenze sia metaforiche che reali sui confini di questo continente.
Si apre uno scenario che mi piacerebbe potessimo analizzare; sarà allora l’occasione per un’altra conversazione. E tuttavia è impossibile, in queste settimane, non pensare alla debolezza, vera o presunta dell’Europa, intesa qui come Unione Europea soprattutto. Il Covid-19 ci ha di nuovo costretti a rintanarci nei nostri confini, non solo quelli dei nostri territori nazionali, persino quelli, ancora più ristretti, dei nostri angusti spazi domestici. Ora che il pericolo per la salute individuale sembra attenuarsi ne emerge uno per l’Europa che sembra non avere gli strumenti per garantire a tutti i suoi cittadini quel benessere e quell’idea di costruzione ottimistica del proprio destino di cui hai trattato.
Che sfida è questa? Si apre un altro scenario? Nelle scuole i ragazzi hanno fame di sentire qualcuno che parli loro del mondo che vivranno. La storia, gli storici possono offrire una prima possibile interpretazione per sfamare questa curiosità?
Non c’è dubbio che il progetto di un’Europa politica elaborato a Maastricht, sfociato nella libertà di circolazione dei cittadini europei negli Stati dell’Unione e nell’entrata in vigore della moneta unica, abbia subito una battuta d’arresto già con la bocciatura della costituzione in alcuni referendum nazionali nel 2005 e soprattutto con le conseguenze politiche della crisi dei debiti sovrani nel 2010-12. Alla fine del secondo decennio del XXI secolo l’Europa è più debole di quella che aveva retto il collasso del comunismo, la riunificazione tedesca e l’emergere del terrorismo internazionale.
Ma nei confronti dell’attacco pandemico è emersa, a mio parere, un’inaspettata vitalità dell’Europa, che ha saputo approntare una risposta economico-finanziaria più adeguata ed efficace di quella messa in atto contro la crisi economica del decennio scorso, e ha manifestato un grado di condivisione della strategia antipandemica più elevato del previsto, a partire dalla nuova centralità che il Parlamento Europeo è riuscito a ritagliarsi in questa situazione.
Certo l’approccio funzionalista è sempre prevalente e gli Stati Uniti d’Europa sono una meta ancora lontana, ma il virus ha evidenziato che l’integrazione sia l’unica strada e il “ritorno alla nazione” nemmeno un’opzione ideologica: solo un anacronismo e un’arma spuntata. Proprio di fronte a sfide globali come quelle sanitarie ogni ipotesi di “chiusura” rischia di essere persino ridicola. L’Europa, però, è ancora un’unione di stati e d’identità nazionali e questo pesa sulla costruzione di una visione comune e di un’azione governativa tempestiva, capace di entrare in sintonia con lo “spirito pubblico” continentale.
Per quanto ci riguarda tra gli errori da evitare c’è quello di pensare che “l’Italia ha sempre ragione” o che noi siamo più europeisti degli altri: si tratta di un comune sentire infondato. L’Italia ha condiviso sia il progetto funzionalista sia la centralità del Consiglio dell’Unione Europea nella governance dell’Unione, in rapporto alla Commissione e al Parlamento, e si è opposta, come altri Stati, all’unione fiscale – senza la quale l’ipotesi di mutualizzazione dei debiti o di bond comuni non è possibile – che costituisce il passaggio chiave per un’ulteriore cessione di sovranità senza la quale è difficile pensare a un’Europa solidale.
Inoltre spesso in Italia si confonde il principio di solidarietà europea con l’accettazione del proprio carattere nazionale e, soprattutto, del proprio debito pubblico. Debito che abbiamo creato noi, sulla base di scelte politiche nazionali nelle quali la presunta “austerity” degli stati nordici c’entra ben poco. Se nella lingua tedesca la parola schuld significa contemporaneamente debito e colpa, è del tutto evidente che dietro le politiche economiche esistano fratture identitarie profondissime che nessuno può sottovalutare e che non possono essere superate se non attraverso la condivisione di tali differenze e della loro legittimità.
Riferimenti BIBLIOGRAFICI
- S. Colarizi, Novecento d’Europa. L’illusione, l’odio, la speranza, l’incertezza, Laterza, Roma-Bari, 2015.
- F. Chabod, Storia dell’idea d’Europa, Laterza, Roma-Bari, 1961.
- L. Febvre, L’Europa. Storia di una civiltà, Donzelli, Roma, 1999.
- A. Spinelli, Il manifesto di Ventotene, Guida, Napoli, 1982.
- M. Bloch, La strana disfatta, Guida, Napoli, 1970.
- A. De Bernardi, Discorso sull’antifascismo, Andrea Rapini (a cura di), Mondadori, Milano, 2007.
- A. De Bernardi, Un paese in bilico, Laterza, Roma-Bari, 2014.
- M. Pasetti, Storia dei fascismi in Europa, Archetipolibri, Bologna, 2009.
- G. Albanese, Dittature mediterranee, Laterza, Roma-Bari, 2016.
- B. Olivi – R. Santaniello, Storia dell’integrazione europea, Il Mulino, Bologna, 2005.
- B. Croce, Storia d’Europa nel secolo decimonono, Adelphi, Milano, 1991.
- M. Verga, Storie d’Europa, Carocci, Roma, 2004.
- M. Mazower, Le ombre d’Europa, Garzanti, Milano, 2005.




















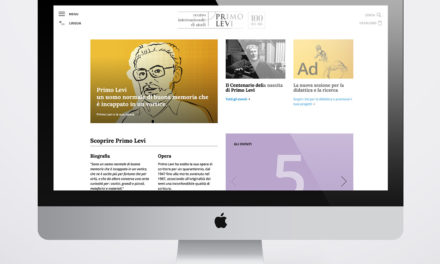


 Scarpe rotte eppur bisogna andar. Una storia della Resistenza in 30 oggetti, a cura di P. E. Boccalatte e M. Carrattieri
Scarpe rotte eppur bisogna andar. Una storia della Resistenza in 30 oggetti, a cura di P. E. Boccalatte e M. Carrattieri L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore
L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino
Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio
Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa
Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice
Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli
Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli L’arresto degli arlecchini
L’arresto degli arlecchini