
Ripensare la contemporaneità a partire dalle grandi crisi economiche
Abstract
A partire da un cronologia ragionata suggerita quale percorso di lettura didattica del Novecento, si propone un riattraversamento del secolo che si proietta sino all’inizio del XXI secolo. Attraverso la messa a fuoco delle loro principali dinamiche e implicazioni, anche sul terreno socio-politico, si coglie l’intreccio con i processi di ristrutturazione produttiva e con le transizioni fra assetti e modelli socio-economici, all’interno della storia del capitalismo contemporaneo, caratterizzata – oltre che da una straordinaria crescita – da un andamento pendolare, dal succedersi di avanzate e battute d’arresto, di espansioni e recessioni che in determinati contesti storici assumono la configurazione di drastiche fratture, da cui affiorano, però, rilevanti cambiamenti e trasformazioni.
Indice
- Tabella: Cronologia ragionata sulle crisi del XX e XXI secolo (1929-2014)
- Presente-passato-presente
- Crisi-ristrutturazioni-transizioni
- La «svolta capitalistica»: dalla grande depressione a Bretton Woods
- Dal duplice shock petrolifero alla finanziarizzazione dell’economia
- La prima grande crisi della globalizzazione neoliberista
- Bibliografia
Tabella: Cronologia ragionata sulle crisi del XX e XXI secolo (1929-2014)
| 24 ottobre 1929 | Crollo della borsa di Wall Street |
| Anni Trenta | Grande depressione. Massiccio intervento dello Stato e istituzionalizzazione del suo ruolo nei meccanismi di regolazione dell’economia |
| 1942 Piano Beveridge | (Social Insurance and Allied Services). Fu tra i presupposti per l’impianto e lo sviluppo del Welfare State in Inghilterra e nell’Europa postbellica |
| 1944 Conferenza di Bretton Woods | Messa a punto di un sistema di regole e procedure per garantire la stabilità dei cambi in presenza dell’intensificarsi delle transazioni commerciali; passaggio dalla sterlina al dollaro, quale moneta di riferimento, riconoscimento dell’egemonia del Usa, divenuti nel corso del secondo conflitto mondiale «l’arsenale della democrazia» |
| Anni Trenta e Quaranta | Decenni decisivi per la formazione della moderna società di massa |
| 1945-1973 «Età dell’oro» del capitalismo | Basata sul circuito virtuoso tra sviluppo economico all’insegna delle politiche keynesiane e l’edificazione ed estensione del Welfare State. |
| 15 agosto 1971 | Dichiarazione unilaterale d’inconvertibilità del dollaro con l’oro da parte del presidente repubblicano Richard Nixon |
| 1973 | Abolizione altrettanto unilaterale dei cambi fissiSmantellamento del sistema di Bretton Woods da parte degli USA, la potenza che più di ogni altra aveva contribuito a crearlo.Shock petrolifero, in seguito alla guerra dello Yom Kippur.
«Crisi fiscale dello Stato» |
| 1979-1980 Secondo shock petrolifero | In seguito al rovesciamento dello scià Reza Pahlavi e all’instaurazione di una repubblica islamica in Iran.Ascesa al potere di Margaret Thatcher in Inghilterra e di Ronald Reagan negli Usa.Rovesciamento dei rapporti di forza tra sinistra socialdemocratica e destra neoliberale.
Teorizzazione de ritorno dello Stato al ruolo di mero guardiano dell’ordine sociale |
| Anni Ottanta | Messa in discussione del Welfare State Ondata di de-nazionalizzazioni e avvio dell’integrazione dei mercati finanziariRiscrittura della geografia produttiva: decentramento e spezzettamento delle grandi fabbriche
Indebolimento della sovranità fiscale dello Stato. |
| 1989-1991 | Crollo del muro di Berlino, implosione del «socialismo reale» e delle economie pianificate, trionfo del capitalismo o dei capitalismi su scala planetaria |
| 1992 | Trattato di Maastricht. Trasformazione della Cee in Ue, prefigurazione della moneta unica (Euro) rafforzamento dei vincoli dell’Unione, il più significativo dei quali riguarda il rapporto fra deficit e Pil, consacrato nel Patto di stabilità, collegato al Trattato, 3% tuttora vigente |
| Anni Novanta | Globalizzazione trionfante. Dispiegarsi della rivoluzione tecnologico-informaticaDiffusione delle politiche neoliberiste all’insegna della flessibilità/precarietà.
Finanziarizzazione dell’economia internazionale e prevalenza del modello anglosassone di capitalismo, fondato sulla liberalizzazione e accumulazione finanziarie |
| 1999 | Abolizione del Glass-Steagall Act. Approvato nel 1933 separava l’attività delle banche commerciali da quelle delle banche di investimento. Ritorno al modello della banca universale |
| 2001-2002 | Abbattimento delle Twin Towers a New York, frenata della New economy, introduzione dell’euro. |
| 2007-2014 | Prima grande crisi della globalizzazione neoliberistaScoppio della bolla dei sub-prime, gigantesco e oneroso salvataggio delle grandi banche da parte degli Stati, manovre speculative ed esplosione dei debiti sovrani, infoltirsi della disoccupazione nell’eurozona e severe politiche di tagli alla spesa pubblica e sociale in nome della messa in ordine dei conti pubblici |
Non facciamoci illusioni. L‘uomo non si ricorda del passato: lo ricostruisce sempre. L’uomo isolato, quest’astrazione. L’uomo in gruppo, questa realtà. Non conserva il passato nella sua memoria, come i ghiacci del Nord conservano congelati i mammut millenari. Ma muove dal presente; e solo attraverso il presente, sempre, conosce, interpreta il passato.
(Lucien Fevbre)
Presente-passato-presente
Passaggi cruciali, sommovimenti tellurici, come quelli provocati da crisi economiche generali, inducono a riconsiderare il passato, specialmente quello prossimo, a osservarlo attraverso una lente nuova, a interrogarlo in relazione agli scenari che si delineano nel presente. Proprio dal dipanarsi della crisi esplosa tra il 2007 e il 2008, in seguito all’evaporare della bolla speculativa dei sub-prime – i «derivati» legati ai mutui immobiliari – viene la sollecitazione a volgere lo sguardo all’indietro, a comparare gli effetti della più grave recessione dal 1929 con quelli della virulenta depressione degli anni Trenta, tematizzando caratteristiche e dinamiche di due stagioni della storia del capitalismo certamente diverse, ma che hanno rivelato e accelerato, con le loro ripercussioni, tendenze di fondo della società e della politica. Questo raffronto, peraltro, rinvia necessariamente a quanto c’è stato in mezzo tra l’una e l’altra: il secondo conflitto mondiale in quanto «guerra costituente»; gli accordi di Bretton Woods del 1944, che hanno consacrato gli Stati Uniti, al posto della Gran Bretagna, quale perno finanziario delle relazioni internazionali; la straordinaria espansione tra il 1945 e il 1973, strettamente intrecciata all’edificazione del Welfare State e interrottasi intorno alla metà degli anni Settanta; la globalizzazione e la rivoluzione tecnologica, con l’accentuarsi delle interdipendenze, nel decennio successivo; la fine del bipolarismo sovietico-statunitense che aveva plasmato il quadro geopolitico tra il 1945 e il 1989. Si tratta di focalizzare, quindi, snodi indubbiamente complessi, ma fondamentali ai fini della comprensione della profondità del tempo presente, dell’incidenza del passato su di esso.
Con l’inasprirsi, soprattutto in Europa, della crisi dilagata dagli Stati Uniti dopo il fallimento, nel settembre 2008, della Lehman Brothers, quinta banca d’investimenti d’America, si è fatta strada la consapevolezza di vivere dentro un tornante dell’età della finanza e della comunicazione globali, un passaggio segnato dall’ulteriore redistribuzione delle risorse conseguente all’imperioso affermarsi di attori nel mercato mondiale che stanno spostando sempre più il baricentro dell’economia verso l’Asia-Pacifico. Non a caso la crisi è stata pesantemente avvertita nella cosiddetta euro-zona, mentre è apparso ben altro lo stato di salute dei paesi emergenti o BRICS, e pure degli Stati Uniti, il cui Pil ha registrato nel 2014 un incremento intorno al 5%.
È vero che si è ancora dinanzi a fenomeni in atto, il cui sbocco ed esito dipenderanno dal combinarsi delle forze e fattori in gioco. Tuttavia questa notazione vale per qualsiasi tematica del presente si voglia storicizzare. Occorre sì tenere conto del rischio, pressoché inevitabile, connesso all’insufficiente sedimentazione temporale dei processi in corso, ma non per questo precludersi l’opportunità di utilizzare gli strumenti dell’analisi storica, in attesa che spinte e tendenze prevalenti si consolidino definitivamente, che l’hegeliana «nottola di Minerva» spicchi il suo volo.
Se il presente viene inteso come una sorta di sismografo, una spia rivelatrice del passato, indagare e/o far studiare quest’ultimo alla luce delle questioni che esso solleva serve a individuare dell’uno come dell’altro le linee essenziali, a chiarire la dialettica mutamenti-continuità, a cogliere spessore e complessità del binomio novità-permanenze, cioè di fattori e aspetti reciprocamente condizionantisi.
Accanto al nesso presente-passato va assunta come riferimento prospettico, privilegiato punto d’osservazione la dimensione globale, giacché la mondializzazione della storia si è accelerata a partire dal periodo a cavallo tra Otto e Novecento, allorché, grazie all’estendersi della rete dei trasporti, dell’uso del telegrafo e del telefono, si andavano accorciando i tempi per coprire notevoli distanze o per entrare in contatto con chi viveva in un’altra città, in un altro paese o addirittura in un altro continente. Inoltre, è appena il caso di sottolinearlo, tutte le grandi crisi economiche dell’età contemporanea hanno avuto, ed hanno, natura e impatto di carattere mondiale.
Da quanto sin qui si è detto, si possono ricavare due indicazioni. Mettere sotto i riflettori quella che indubbiamente si è squadernata come una grande recessione, e le sue conseguenze socio-politiche, consente la possibilità, attingendo a risorse e strumenti della mediazione didattica, di costruire un percorso basato sul rapporto presente-passato in senso biunivoco o, per essere più chiari, sul rapporto circolare presente-passato-presente. La scelta di un angolo visuale di rilevanza strategica, quale è quello costituito dalle rotture d’ordine economico, permette altresì di proporre una periodizzazione del Ventesimo secolo che si proietta sino all’inizio del Ventunesimo e che ha nella «svolta capitalistica» degli anni Trenta una cesura di primaria importanza.
Crisi-ristrutturazioni-transizioni
Va puntualizzato che spesso si è abusato nell’utilizzo del termine crisi, sino a far perdere a tale categoria concettuale la sua pregnanza euristica, la sua ricchezza cognitiva. Non poche analisi e ricostruzioni hanno finito col trasmettere l’impressione di essere noi in un continuo stato di crisi ed è superfluo rimarcare quanto siano state fuorvianti queste forzature interpretative. Bisogna aggiungere, sulla scorta di quanto si è verificato in più di un’occasione nell’ambito dell’organizzazione e dei rapporti produttivi, che crisi è parola da coniugare con ristrutturazione, se si vuol intendere la portata e il significato di fasi contraddistinte da brusche cadute e al tempo stesso dall’affiorare di rilevanti cambiamenti socio-economici.
Pur dando luogo a situazioni e sequenze che sono approdate a esiti diversi, le crisi da cui è stato scosso il capitalismo paiono avere un tratto in comune, il loro incrociarsi con profonde trasformazioni sul terreno produttivo, sociale e politico, tanto sul piano interno quanto su quello delle relazioni internazionali, originando forti tensioni e conflitti, con guerre combattute o minacciate, con tentativi rivoluzionari riusciti o abortiti. In quest’ottica la storia del capitalismo, motore di una sbalorditiva crescita nell’età contemporanea, appare caratterizzata da un andamento pendolare, dal succedersi di avanzate e battute d’arresto, di espansioni e recessioni, che in taluni frangenti e contesti storici assumono la configurazione di vere e proprie crisi. Crisi che coincidono, come nel caso degli anni Trenta e Settanta, con transizioni da un assetto economico a un altro, da un modello di società a un altro. Crisi e transizioni che hanno interessato, sia pure in misura diversa, l’intero mondo capitalistico, a partire dal laboratorio statunitense della modernità.
Mentre la grande depressione degli anni Trenta decretava il declino del «banchiere d’investimento» (P. Sweezy) e spianava la strada al capitalismo manageriale, imperniato sulla triangolazione fra Big Government, Big Labour e Big Bank, quella degli anni Settanta vedeva il tramonto del fordismo, seguito dal dispiegarsi della globalizzazione neoliberista quale superamento del meccanismo di regolazione keynesiano ed incubazione delle turbolenze finanziarie che dal 2007-2008 hanno attanagliato gli Usa e poi soprattutto l’area dell’eurozona.
Com’è stato sottolineato da più parti, quella esplosa allora è stata la prima grande crisi “da” e “della” globalizzazione, con ricadute che hanno toccato oltre l’economia, la società nel suo complesso e la sfera politico-istituzionale, secondo una connessione quant’altre mai stringente. Una triplice crisi, al tempo stesso economica, politica e sociale, frutto della svolta epocale promossa negli anni Ottanta dalle forze sociali e dagli attori politici che hanno additato nel mercato l’unico e ottimale strumento di allocazione delle risorse.
Espressione della finanziarizzazione dell’economia (il valore dei soli derivati è giunto a superare di alcune volte quello dell’intero Pil mondiale), le sue radici sono da rintracciare tra il 1979 e il 1980, quando sulle due sponde dell’Atlantico sono ascesi al potere i leader della destra neoliberale Margaret Thatcher e Ronald Reagan, artefici in campo politico del rilancio del capitalismo dopo le traversie palesatesi con il collasso monetario del 1971 e con il duplice shock petrolifero del 1973 e del 1979.
Da allora soffierà con forza per un trentennio il vento del neoliberismo (il paradigma del «pensiero unico») e della liberalizzazione finanziaria, mentre finiva sotto tiro il welfare state e con esso i diritti sociali in tutte le loro declinazioni. In quel biennio – un autentico crinale – si sono poste le premesse del «turbo-capitalismo» (Edward Luttwak) e dell’economia-casinò. E ciò in stretto rapporto con la fine del fordismo, destrutturato dai processi di delocalizzazione produttiva, nonché con la micro-elettronica, cui si accompagnerà la rivoluzione digitale e il deperimento della forma-partito novecentesca basata sulle organizzazioni di massa.
Peraltro in Italia il 1980 è stato l’anno che ha visto la sconfitta operaia alla Fiat di Torino con la «marcia dei quarantamila» quadri e tecnici, che ha ribaltato i rapporti di forza tra gruppi imprenditoriali e sindacati, mentre si avviava la stagione del «riflusso» e di una modernizzazione assecondata sul terreno politico dalla forte personalità del segretario del Psi, Bettino Craxi e dalla costellazione di poteri gravitanti attorno a lui. Vacillava – ed era dato che riguardava su scala generale l’Europa occidentale – il compromesso democratico del capitalismo industriale con il movimento operaio e socialista, che aveva dischiuso le porte alle realizzazioni del welfare state e ai successi in campo economico.
Nel tentativo di rimuovere gli effetti della crisi energetica e strutturale di metà anni Settanta s’inaugurava un duraturo ciclo economico-politico, sempre più dominato dal capitalismo finanziario globalizzato e fondato sul ripudio o sul progressivo accantonamento degli strumenti d’ispirazione keynesiana. Si recepivano, invece, indicazioni e suggerimenti di economisti e pensatori d’orientamento monetarista e neoliberista, come von Hayek e Milton Friedman. Più in generale veniva rispolverato quell’insieme di convincimenti ideologici messo in ombra, per un cinquantennio, dalle dirompenti conseguenze del crollo borsistico di Wall Street nel 1929, che è unanimemente riconosciuto come evento periodizzante, sul piano simbolico e materiale, nella vicenda storica del capitalismo.
La «svolta capitalistica»: dalla grande depressione a Bretton Woods
A più riprese economisti, pensatori politici e storici si sono interrogati sul significato e le implicazioni della grande depressione degli anni Trenta. Collasso della produzione e degli scambi, repentina caduta dei redditi, diffondersi della povertà nelle zone rurali e impennata senza precedenti della disoccupazione nelle aree urbane: questa è stata la fenomenologia di una crisi prevalentemente ricondotta alla forbice apertasi, nel mercato mondiale, tra offerta e domanda, in particolare ascritta alle contraddizioni del capitalismo statunitense, da un lato in grado di moltiplicare la produzione, dall’altro incapace di garantirsi ampi sbocchi di mercato.
Se le vendite rateali e i crediti ai consumatori avevano contribuito, durante i «ruggenti anni Venti», al boom degli apparecchi radio e alla formidabile espansione delle industrie elettriche, chimiche e automobilistiche, l’aumento dei salari, elevatisi del 10%, non aveva tenuto il passo con quello dei profitti, lievitati dell’80%. Inoltre, anche se nel corso degli anni Venti c’era stata una ripresa economica a livello internazionale, per quanto non omogenea, ovunque – in Europa come nel Nord-America – i redditi erano calati nelle campagne. Il sopraggiungere della crisi mentre squassava l’economia statunitense, si abbatteva su quelle europee, che già complessivamente attraversavano una fase di stagnazione. Il suo prolungarsi rendeva evidente il fallimento degli sforzi messi in atto dopo il 1918, tesi a ripristinare lo status quo prebellico, nel quale il gold standard e la city di Londra erano il fulcro degli scambi internazionali.
Secondo la chiave di lettura suggerita da Charles Kindleberger, le origini della crisi, che ne spiegano la durata, sono rinvenibili nella Grande guerra, che aveva sconvolto la trama del commercio mondiale, cresciuto prima del 1914 quasi ininterrottamente per un trentennio insieme alla produzione industriale. Il devastante conflitto aveva mandato in frantumi la stabilità del gold standard, minando la supremazia britannica in campo monetario. Di lì a non molto, nel settembre 1931, la Gran Bretagna abbandonerà definitivamente la convertibilità della sterlina in oro e, con questa decisione, ammetterà la sua impotenza ad assicurare un assetto solido alle transazioni internazionali. A loro volta gli Stati Uniti, sebbene fossero di fatto il cuore dell’economia mondiale, si mostravano riluttanti a subentrare alla Gran Bretagna nel ruolo di garante e di prestatore di ultima istanza.
Nonostante il dilatarsi della quota americana nella produzione globale e la diminuzione di quella europea, le élites dell’altra sponda dell’Atlantico non si accollarono le responsabilità derivanti dal prepotente balzo degli Usa sulla vetta dell’economia mondiale. E ciò ha assecondato o, quanto meno, non ostacolato le possenti spinte alla segmentazione delle relazioni economiche internazionali, che si manifestarono sia attraverso la costituzione di spazi monetari chiusi e protetti (blocco della sterlina, del dollaro, del franco, dello yen), sia con il ricorso ad accordi di compensazione dei debiti (clearing), sia con l’innalzamento delle tariffe doganali e il riemergere di aggressivi nazionalismi economici.
Tuttavia, nelle more di una crisi d’inaudita gravità (all’incirca 30 milioni i senza-lavoro), governi e ceti dirigenti erano obbligati a dare priorità ad alcuni, irrinunciabili obiettivi: rimettere in moto la macchina produttiva, assorbire la disoccupazione, garantire la stabilità dei prezzi. Smentita in modo clamoroso la fiducia riposta negli ingranaggi del libero mercato, si cambiava pressoché radicalmente il modo di porsi nei confronti dell’attività economica, affidandosi allo Stato, il cui massiccio intervento risaltava quale tratto unificante dell’insieme di provvedimenti anti-crisi, sia pure dentro cornici politico-istituzionali sensibilmente diverse: dall’Italia fascista, che con la fondazione dell’Iri giungeva a controllare i maggiori istituti di credito e una porzione ragguardevole dell’industria, alla Germania nazista, che con i piani quadriennali diede impulso a una intensa politica di lavori pubblici e soprattutto all’allestimento di una poderosa macchina bellica; dall’Inghilterra liberale – culla del free trade – all’America rooseveltiana del New Deal, dove sono state elaborate le strategie che risulteranno alla lunga vincenti, influenzando profondamente l’età successiva.
All’interno di scelte dettate dall’impatto con una congiuntura estremamente negativa, maturava una svolta di lungo periodo, che sarebbe sfociata nella ridefinizione dei rapporti tra politica ed economia, tra Stato e mercato, con il modificarsi della funzione stessa delle istituzioni pubbliche. Oltre a quello tradizionale di «guardiano» del quadro giuridico-sociale, lo Stato assumeva nuovi compiti diventando l’asse centrale dell’accumulazione capitalistica. Si assisteva così all’affermazione del «capitalismo organizzato», in cui lo Stato si poneva come regolatore dei processi economico-sociali e la componente manageriale, pubblica e privata, era destinata a svolgere un ruolo di primo piano. Il passaggio da una forma all’altra del capitalismo s’incrociava, sul terreno produttivo, con il diffondersi dei metodi fordisti e tayloristici e avveniva in decenni decisivi – gli anni Trenta e Quaranta – per la formazione della moderna società di massa, decenni caratterizzati dal tendenziale prevalere del settore secondario su quello primario, dalla consistente crescita della popolazione urbana e da mutamenti significativi nei modelli di vita.
Rapidamente propagatasi, attraverso i prestiti e gli investimenti che legavano la finanza statunitense al sistema creditizio europeo, la grande depressione ebbe come effetto, tra gli altri, quello di erodere ulteriormente la credibilità delle istituzioni della democrazia parlamentare, in un frangente in cui vasti strati, specialmente della piccola e media borghesia, riponevano una crescente fiducia nelle virtù taumaturgiche di capi carismatici, gli unici ritenuti in grado di prendere dall’alto decisioni tempestive e risolutive. L’acuirsi dello scontro politico e sociale, soprattutto con l’ascesa del nazismo, portò all’offuscamento e poi all’eclissi della democrazia liberale e rappresentativa, all’avanzata dell’autoritarismo fascista e della «reazione militante» in gran parte d’Europa, alla fibrillazione dello scenario politico internazionale, premessa, quest’ultima, dello scoppio del secondo conflitto mondiale. La compenetrazione d’interno e esterno, più evidente negli anni Trenta («anni di ferro e di fuoco»), è la cifra precipua dell’intero periodo fra le due guerre, contraddistinto dal dipanarsi di una transizione che rese instabili e precari gli equilibri e le dinamiche del capitalismo. Come ebbe a notare Karl Polanyi, in una serie di lezioni tenute nel 1937 per conto delle Trade Unions inglesi, «la caratteristica più sensazionale della storia contemporanea [è] la frequenza con la quale, nel quadro degli eventi internazionali, si intrecciano guerre esterne e guerre civili».
In un contesto segnato da forti tensioni sociali e dall’approssimarsi di un nuovo conflitto generale, l’azione dello Stato nella regolazione dei meccanismi economici propiziò sì la parziale ripresa americana tra il 1934 e il 1938, ma non ottenne nella Francia del Fronte popolare risultati analoghi, anche perché condotta più timidamente. Ben altri risultati conseguì, invece, l’intervento pubblico nella Germania nazista, dove si realizzò una sorta di keynesismo militare finalizzato alla corsa al riarmo – «il gran premio della morte» – e all’attuazione dei piani di conquista con cui doveva iniziare l’era del Reich millenario.
Comunque, dalla crisi si uscirà completamente solo al prezzo di un’altra micidiale guerra mondiale, nel corso della quale gli Stati Uniti si trasformeranno nell’«arsenale» degli Alleati. E proprio durante il titanico confronto con la coalizione nazifascista il gigante americano, nella conferenza di Bretton Woods del luglio 1944, proporrà, imponendo il suo sistema di regole e procedure, le misure per allargare e rendere sicura, ad ostilità cessate, la trama delle transazioni internazionali: un rapporto di cambio fisso tra le monete e l’ancoraggio del dollaro all’oro come riserva legale delle banche centrali. Con la consacrazione della valuta statunitense a moneta-base, Bretton Woods sanciva il passaggio di consegne, sul versante finanziario, dalla Gran Bretagna agli Usa, una translatio imperii, che ratificava il ridimensionamento della potenza inglese e la leadership di quella americana.
Nell’estate del 1944 vennero operate, dunque, scelte d’importanza tale da indurre gli studiosi a vedere in esse uno dei fondamentali presupposti dei «Trenta gloriosi» (Fourastié) o dell’«età dell’oro» del capitalismo (Hobsbawm): 1945-1973. Scosso sin nei suoi pilastri dalla bufera degli anni Trenta, il capitalismo si risollevava pienamente soltanto nel dopoguerra grazie all’adozione generalizzata di programmi keynesiani e all’impianto e alla diffusione del Welfare State. Le politiche d’ispirazione keynesiana, incentrate sull’accoppiata d’intervento statale e mercato manovrato, combinandosi con l’estensione della produzione standardizzata di massa, consentivano un vigoroso rilancio dei settori privati dell’economia, sostenuti dalle spese e dagli investimenti pubblici. Addebitabile alla costruzione di un’economia mista basata sull’intreccio della «mano pubblica» e della «mano privata», il nuovo ciclo postbellico era scandito dai tassi eccezionali fatti registrare dagli indici della crescita e della produttività.
Regolamentazione delle borse, della concorrenza internazionale e del movimento dei capitali, stabilità dei mercati finanziari, assenza, o quasi, d’inflazione, politiche dirette a stimolare lo sviluppo e le opportunità di impiego sono da annoverarsi tra i fattori di una lunga fase di crescita esauritasi fra il 1971 e il 1973, che ha avuto le sue manifestazioni più eclatanti nei boom economici e nel prendere piede del consumismo di massa. Strettamente connessa a tutto ciò è stata l’edificazione dello Stato sociale, di un sistema fondato su previdenza, istruzione, sanità, che ha arrecato benefici ad ampi strati attraverso il flusso di pensioni, contributi, indennità di disoccupazione, permettendo, insieme con l’aumento del reddito e il miglioramento del tenore di vita, di alimentare una domanda crescente di beni di consumo durevoli: auto, mezzi di trasporto, elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, televisori). Si è innescato così, in quell’arco temporale, un circolo virtuoso tra la rivitalizzazione del capitalismo e le affermazioni dei partiti socialdemocratici, protesi ad attuare, nell’ambito dei vincoli del sistema capitalistico, incisive politiche redistributive, volte anche a tener sempre più lontano il richiamo del modello sovietico. Il configurarsi di questa correlazione palesava, in Occidente, la trasformazione dei partiti dei lavoratori da perturbatori della stabilità sociale in protagonisti di una politica consensuale.
Dal duplice shock petrolifero alla finanziarizzazione dell’economia
Preceduta, alla fine degli anni Sessanta, dal calo dei profitti e degli investimenti e dal rallentamento della produttività per addetto, la crisi cominciata nel 1973 si è protratta fino al 1982, fagocitando ciò che era d’intralcio ai processi di ristrutturazione. All’aprirsi degli anni Settanta erano in molti a ritenere che l’Occidente capitalistico fosse approdato a uno stadio di non effimero benessere, allorché si è andati incontro alla prima inaspettata battuta d’arresto dalla grande depressione. Un clima d’incertezza si era già profilato dal 1971, quando il 15 agosto il presidente repubblicano Richard Nixon aveva annunciato lo sganciamento del dollaro dalla base aurea, anche se quella statunitense rimaneva la principale valuta di riferimento. A questa cruciale decisione, che sgretolava il sistema di Bretton Woods, Washington era spinta da più di un motivo: l’assottigliarsi delle proprie riserve auree per l’estenuante conflitto in Vietnam, il deficit di bilancio su cui pesavano anche le spese per il progetto di Johnson della «grande società», la discesa del tasso di produttività (dal 4 al 3 e poi all’1%), una concorrenza fattasi sempre più temibile.
Ad aggravare la situazione intervenivano due shock petroliferi. Nel 1973, per ritorsione all’appoggio delle potenze occidentali a Israele nella guerra dello Yom Kippur, il cartello dell’Opec, nato nel 1960, faceva schizzare in alto il prezzo del greggio al barile, assestando così un duro colpo all’intera economia capitalistica, che sino allora ne aveva divorato quantità enormi a costi irrisori. Nel 1979, in seguito alla rivoluzione in Iran ben presto egemonizzata dagli ayatollah sciiti, si registrava un ulteriore, considerevole aumento. L’impennata del prezzo del petrolio penalizzava specialmente i paesi del Terzo mondo, che dipendevano dall’approvvigionamento di quella fonte energetica; colpiva di meno gli Stati Uniti, che però erano indotti a sfruttare anche i propri giacimenti inutilizzati; viceversa arrecava, alla lunga, benefici alla Gran Bretagna e ancor di più alla Norvegia, visto che entrambe scoprivano cospicue risorse nelle loro acque territoriali. Rilevanti risultavano le difficoltà per quei paesi, come l’Italia, che facevano leva sulle esportazioni, con un’industria legata alla chimica pesante, alla plastica, alla produzione e al consumo di auto.
In generale si può dire che non si è assistito a un tonfo catastrofico come nel ’29, ma al susseguirsi di congiunture negative che hanno provocato una rincorsa al rialzo fra prezzi e salari, determinando la pericolosa miscela di stagnazione e inflazione, un fenomeno inedito nella storia dell’economia, per designare il quale è stato coniato il neologismo di stagflazione. Infatti, se si provava a domare l’inflazione galoppante con la riduzione del costo del lavoro, si suscitava la resistenza dei sindacati e l’aumento della spesa assistenziale; se si percorreva la strada delle facilitazioni alle imprese e del sostegno alla spesa pubblica, si doveva prendere atto che, in un mercato aperto, l’incremento della domanda stimolava le importazioni e generava più inflazione che nuovi investimenti. Costretto a intervenire per dirimere vertenze sindacali (gli scioperi dilagavano ovunque), lo Stato dovette far fronte ad un aggravio della spesa pubblica: si entrava così in quella che è stata definita «la crisi fiscale dello Stato» (J. O’ Connor), mentre tornava ad aleggiare lo spettro della disoccupazione di massa e del deteriorarsi del tenore di vita.
Dal canto loro i paesi produttori di petrolio, piuttosto che convogliare verso lo sviluppo interno i capitali che affluivano nelle rispettive casse, utilizzavano la disponibilità di un’improvvisa, enorme liquidità nella ricerca di rendite speculative, nell’acquisto di titoli finanziari, ricollocati in Occidente là dove sembravano promettere rendimenti più elevati e sicuri. Due i maggiori effetti negativi: con una parte dei petroldollari si lucrava sui cambi tra le monete, con un’altra si offrivano ai paesi sottosviluppati prestiti a tassi bassi, destinati a lievitare in maniera ragguardevole. Si formava in questo modo un debito estero di proporzioni ciclopiche, i cui interessi ingoiavano gran parte del ricavato delle esportazioni delle nazioni che erano finite in questo nodo scorsoio. Un circolo vizioso non dissimile ha messo in ginocchio anche le economie dell’Est europeo e dell’Urss, che hanno cercato, senza riuscirvi, di sopperire, con prestiti e importazioni di interi impianti, alla propria incapacità di modernizzarsi.
Nel complesso si dischiudeva una nuova fase per i paesi industrializzati, che avrebbe inciso sulla stessa fisionomia del capitalismo, catapultando l’alta finanza alla guida dell’intera economia. Sul terreno strutturale, la crisi degli anni Settanta metteva in moto la transizione dal modello produttivo imperniato sulle industrie pesanti di base al post-fordismo e alla società dei servizi e del terziario. Si trattava di un passaggio decisivo, dentro il quale – come ha argomentato con efficacia Charles S. Maier – si consumava la «crisi della società industriale, e quindi di due sistemi: il capitalismo fordista del dopoguerra e il socialismo di Stato fordista». Una crisi sistemica, dunque, che, se ha contribuito a sfaldare il blocco sovietico avvitatosi in una sclerosi irreversibile, ha messo alla frusta gli Stati Uniti e l’Europa occidentale, spingendoli a puntare con determinazione sulle innovazioni tecnologiche, sull’informatica, il cui avvento ha reso possibile una diversa distribuzione globale delle attività economiche e l’integrazione delle piazze finanziarie.
Di qui, a partire dagli anni Ottanta del Novecento, la progressiva finanziarizzazione dell’economia, ossia l’aumento esponenziale dei ricavi attraverso le operazioni speculative nel circuito borsistico planetario o, in altri termini, «il denaro guadagnato solo per mezzo del denaro che va alla ricerca di altro denaro». Se intorno al 1980 gli attivi finanziari (depositi di denaro, azioni, obbligazioni) e il PIL mondiale si equivalevano, un trentennio più tardi i primi ammontavano ad alcune volte di più del secondo, con il 50-60% degli utili riservato ad ogni scadenza annuale ai compensi dei top manager.
Proprio per i cambiamenti e fenomeni che in essi hanno preso corpo, soprattutto la mutazione, di natura finanziaria, conosciuta dal capitalismo con l’inarrestabile marcia della globalizzazione, gli anni Ottanta si stagliano come uno spartiacque nella storia del capitalismo. È stato il decennio della diffusione del verbo neoliberista, della ricetta «meno Stato, più mercato». L’allentarsi del controllo statuale sul sistema capitalistico si è tradotto in un «gioioso suicidio pubblico» (Ulrick Beck), che ha concesso un esorbitante spazio di manovra alla finanza transnazionale, il cui potere è divenuto assolutamente sproporzionato rispetto agli altri fattori della produzione, specialmente nei confronti del lavoro.
Ad agevolare – e non poco – grandi banche e società finanziarie sono state le élite politiche attraverso leggi approvate dal Congresso degli Stati Uniti e dal Parlamento europeo, cui si sono aggiunte normative ispirate dalle organizzazioni internazionali (WTO, FMI, BM). A tal proposito si pensi all’abolizione del Glass-Steagall Act, che per oltre mezzo secolo, dal 1933, aveva tracciato un netto confine fra le banche di tipo tradizionale, predisposte alla raccolta dei depositi dei piccoli risparmiatori, e le banche d’affari, impegnate nel finanziamento di operazioni a medio e lungo termine. La sua sostituzione con il Gramm-Leach Bliley Act, promulgato il 12 novembre 1999 dal presidente Bill Clinton, permetteva agli istituti di credito ordinario di agire come le banche d’affari. Da quel momento i loro portafogli si sono riempiti di titoli legati a investimenti ad alto rischio.
Anche in Italia si era, di fatto, tornati al modello della banca universale grazie alla legge Carli-Amato del 1992, con cui ci si allontanava dalla riforma del 1936, quella che a sua volta aveva tagliato il cordone ombelicale tra «banche miste» e grande industria. Questi e altri provvedimenti, unitamente all’allargamento smisurato del suo campo d’azione, hanno consentito all’alta finanza di subordinare a sé la politica, indebolendo e delegittimando governi e Parlamenti, chiusi dentro il recinto degli spazi nazionali e, perciò, incapaci, di opporsi in maniera adeguata alle scorribande della speculazione internazionale, all’evasione fiscale, alle delocalizzazioni (il social dumping).
Oggi, come sembrano confermare le cronache della vita politica e economica degli ultimi anni, a prendere realmente le decisioni più importanti non sono gli istituti della democrazia rappresentativa, non i Parlamenti e neppure i governi, chiamati spesso in Grecia, Spagna, Portogallo, Italia a ratificare misure dettate dalla BCE, dai tecnocrati di Bruxelles e degli organismi internazionali, ma una nuova specie di ottimati, una neo-oligarchia, che tutela in primo luogo gli interessi dei giganti finanziari, svuotando così la democrazia dei suoi contenuti tendenzialmente egualitari e mortificando il ruolo delle istituzioni.
La prima grande crisi della globalizzazione neoliberista
Né sembra essere cambiato il quadro dopo lo scoppio della bolla dei sub-prime, che ha investito l’intero sistema finanziario ripercuotendosi poi duramente sull’economia reale, con la riduzione degli investimenti, la depressione dei consumi e l’estendersi della disoccupazione, attestatasi nel 2014 sull’11% in Europa e sul 12,7% in Italia.
Per scongiurare un tracollo simile a quello verificatosi negli anni Trenta, è toccato agli Stati intervenire in soccorso delle banche, il cui salvataggio è costato ai contribuenti ben 14.000 miliardi di dollari. Questa «socializzazione delle perdite» ha dilatato il debito pubblico di molti paesi, senza che banche e finanziarie fossero obbligate a ravvedersi, smettendo di speculare, cosa che invece hanno fatto di nuovo, approfittando delle due erogazioni di prestiti ricevuti dalla Bce, tra il 2011 e il 2012, per più di mille miliardi di euro al tasso dell’1%. Questa possente iniezione di denaro è stata impiegata per ricapitalizzarsi e comprare titoli di Stato, lucrando non poco sulla differenza e lasciando insoddisfatta la pressante domanda di liquidità proveniente dalle imprese.
L’iniziale, clamorosa manifestazione della crisi, con gli impiegati e i funzionari della Lehman Brothers intenti nel settembre 2008 a svuotare i propri uffici, ha segnalato il rovinoso incepparsi dei meccanismi attivati dalla finanziarizzazione dell’economia, che non sono stati in grado di contemperare due esigenze contraddittorie del sistema capitalistico: il contenimento dei salari, per diminuire il costo del lavoro, con l’innalzamento dei consumi. Non è servita a ciò la pressione sistematica a fare ricorso all’indebitamento. A lungo la concessione di crediti e di mutui a tutti è stata, negli Usa, il canale per aggirare lo scoglio dell’indebolimento della propensione al risparmio delle famiglie di tanti lavoratori e persino di membri del ceto medio, non più in condizioni di entrare in possesso della prima abitazione, dato il netto calo dei salari, in termini percentuali, registratosi tra il 1983 e il 2005. E tutto questo è andato avanti fino a quando non è franato il castello di carta poggiante sulla cultura del «debito facile» e sul fallace convincimento, proprio dell’ideologia liberista, delle virtù autoregolatrici del mercato.
Accesa dalla speculazione privata, la crisi finanziaria è stata invece presentata, se non contrabbandata, da circoli dirigenti e da gran parte degli organi d’informazione, come una crisi dei debiti sovrani, in particolare dei paesi europei, prima Grecia, Irlanda, Portogallo, poi Spagna, Italia. Per volere dell’asse tedesco-francese (Merkel-Sarkozy), gli aiuti della Ue alla Grecia non sono stati tempestivi, sprecando così l’opportunità di impedire il propagarsi del contagio all’intera eurozona. Finita sotto il ricatto della speculazione internazionale, la Grecia ha sì incassato dalla Ue prestiti al 5% ma ha dovuto pagare anche il 15% di interessi alle finanziarie che hanno acquistato i suoi titoli di Stato. Per provvedere a questi esborsi, è stata costretta a limare le pensioni, a mettere mano a licenziamenti e privatizzazioni.
In generale i prestiti accordati dalle istituzioni internazionali hanno avuto come contropartita l’imposizione di tagli draconiani alla spesa pubblica e ai servizi sociali da parte della cosiddetta «Troika» (BCE, FMI, Commissione Europea). Queste politiche di aggiustamento, dette «riforme strutturali» e basate su blocchi o decurtazioni di stipendi e pensioni, licenziamenti, anche nel pubblico impiego, erosione delle prestazioni sociali e dei diritti dei lavoratori, hanno contribuito a aggravare la spirale recessiva. La riduzione della spesa pubblica, additata come la via maestra per emergere dalle secche di una situazione problematica, ha invece incrudelito la crisi socio-economica, come ha attestato il vistoso infoltirsi delle file dei disoccupati.
In un Paese come l’Italia, in nome dell’insostenibilità finanziaria delle spese derivanti dai sistemi di protezione sociale, si è praticata una politica di deflazione salariale: compressione delle retribuzioni, della spesa sociale (il salario indiretto), delle pensioni (il salario differito). Tuttavia, l’uso delle forbici non ha sortito l’effetto sperato, anzi tra il 2012 e il 2014 ha spinto verso il basso il Pil, rendendo più critico il parametro del rapporto col debito pubblico.
Certo diverse sono state le manovre anti-crisi messe in campo e i fattori che hanno aiutato la ripresa statunitense, giapponese e sud-coreana, testimoniata dall’aumento della produzione manifatturiera, delle esportazioni e del numero degli occupati, sono mancati nelle politiche dell’eurozona; qui la Germania – assolutamente la prima economia – guidata dal cancelliere Cdu Angela Merkel ha dettato la linea del rigore finalizzata a risanare i conti pubblici. Si è trattato di una scelta di tipo deflattivo, probabilmente alla lunga controproducente per l’intera Ue, che ha portato alla contrazione degli investimenti, dei consumi e dell’occupazione. Dietro l’austerity è riaffiorata una vecchia versione del liberismo, l’ordo-liberalismus, fondata sul monito di non vivere al di sopra dei propri mezzi, così come il presidente Herbert Hoover nel 1929 invocava di smetterla con gli eccessi e le dissipazioni della Gilded Age, l’età immortalata da John Scott Fitzgerald nel romanzo Il Grande Gatsby.
La fiducia, se non la fede, nelle capacità rigeneratrici di un’inflessibile disciplina finanziaria è stata alla base della proposta del fiscal compact, e, prima ancora, dei vincoli del Trattato di Maastricht (1992), nonché della richiesta di introdurre il pareggio di bilancio in Costituzione, richiesta che in Italia è stata approvata nel 2012 dal centro-sinistra come dal centro-destra, con la modifica dell’art. 81 della Carta costituzionale.
Se si collocano la recente crisi e i suoi strascichi in uno scenario storico, appare evidente il nesso tra la tempesta finanziaria scatenatasi nel 2008 e il trentennio avviato negli anni Ottanta, allorché la destra neoliberista ha indicato con successo nelle liberalizzazioni e nella globalizzazione dei mercati le modalità per mettere da parte il meccanismo di regolazione keynesiano-fordista, accusato di non essere più in grado di assicurare la crescita dell’economia e dei profitti. Guidata da Maggie Thatcher (la «lady di ferro») e da Ronald Reagan («il grande comunicatore»), la riscossa neo-conservatrice mirava a scardinare l’assetto socio-politico delineatosi tra gli anni Trenta e Quaranta, muovendo dalla convinzione che i governi dovessero favorire l’arricchimento e la realizzazione individuali, attraverso la privatizzazione dei servizi pubblici e l’abbassamento delle aliquote fiscali più elevate per stimolare gli investimenti.
Più che impegnarsi nella creazione di ricchezza reale, gli strati alti della società hanno preferito, però, imboccare la via dei facili e lauti guadagni attraverso il gioco speculativo nel circuito finanziario-borsistico, mentre era in corso il pluridecennale drenaggio di risorse dal lavoro al profitto, dai lavoratori alle imprese, dalla produzione alla rendita finanziaria. Basti pensare che tra gli anni Ottanta e il 2007 la quota dei salari sul Pil nell’Europa a 15 è diminuita di dieci punti, passando dal 68% al 58%. Si è venuta così sensibilmente accentuando la polarizzazione della ricchezza, con la formazione di un’upper class, le cui fortune riposano sugli stratosferici ricavi dell’economia di carta, e con la ricomparsa sulla scena sociale dei «working poor», soprattutto in seguito all’estendersi delle occupazioni precarie e saltuarie e al moltiplicarsi delle tipologie di contratto a tempo determinato. Il proliferare degli impieghi atipici e flessibili – sono attualmente all’incirca 4 milioni i «precari» in Italia – ha seminato disagio, incertezza e malessere nel corpo sociale, saldandosi con la tendenza a ridimensionare, se non a smantellare il welfare state, diffusasi sul finire del ventesimo secolo e rafforzatasi agli albori del ventunesimo. Ne è risultato l’approfondirsi, in maniera stridente, delle disuguaglianze, che è stato individuato da più di un osservatore e studioso come uno dei principali motivi della crisi provocata dal capitalismo finanziario globalizzato.
Facendo leva sulle delocalizzazioni, mettendo in competizione zone sviluppate e zone emergenti sul fronte delle condizioni di lavoro, il «turbocapitalismo» è riuscito a dividere, se non a contrapporre, su scala internazionale, i lavoratori sia per quanto riguarda i salari, che per la determinazione dei prezzi delle merci, specialmente quelle più comuni. Di qui l’afflusso incessante verso i paesi maggiormente sviluppati, dove il serbatoio dell’immigrazione è tornato utile per calmierare le retribuzioni locali, di prodotti fabbricati per conto di corporations ed aziende che hanno decentrato o spostato le loro attività nei bacini mondiali della forza-lavoro a basso costo.
Appellandosi alla necessità di far fronte alle sfide della concorrenza a tutto campo nell’economia globalizzata, acuita dall’emergenza di una crisi, che è stata attribuita – a torto o a ragione – all’abnorme rigonfiarsi dei debiti pubblici, si sono presi di mira i costi delle prestazioni del Welfare State e con essi i diritti sociali, imprimendo un’accelerazione al processo in atto dagli anni Ottanta. Nel contesto di una travagliata congiuntura economica il modello di capitalismo legato allo Stato sociale sta cedendo definitivamente il passo, anche laddove aveva conosciuto la sua maggiore realizzazione, a quello che ha visto – all’insegna della flessibilità e della globalizzazione – l’affermazione dei grandi gestori finanziari, cervello e cuore di un capitalismo dominato da prospettive a breve termine e perciò inevitabilmente instabile. Un capitalismo al cui vertice si sono stabilmente collocate le élite finanziarie e tecnocratiche, responsabili, in larga misura, della vanificazione del ruolo dei Parlamenti, dello svuotamento della democrazia rappresentativa, il cui appannamento è segnalato dalla disaffezione verso la politica, dal generalizzarsi dell’astensionismo elettorale, dalle ricorrenti tentazioni plebiscitarie, dall’avanzata delle nuove destre populistiche, come hanno dimostrato le performances di Fidesz e Jobbik in Ungheria, della Lega Nord in Italia e del Front National in Francia, il cui primo successo risale alle consultazioni europee del 1984, quando esso ha raccolto l’11% dei suffragi incitando alla lotta contro gli immigrati con lo slogan d’abord les français.
L’intersecarsi della crisi economica con le dinamiche socio-politiche, segnata l’una e le altre dall’ulteriore deperimento del Welfare State, è avvenuto dentro la partita – non priva di rischi ed incognite e tuttora in svolgimento – della «transizione egemonica» che ha come attori principali da un lato i giganti dei nuovi competitori globali, in particolare Cina e India, dall’altro gli Stati Uniti, non intenzionati ad abdicare, ma anzi decisi a far pesare, anche in uno scenario multipolare, la loro supremazia in campo tecnologico e militare.
Bibliografia
VV., Rapporto sui diritti globali, Ediesse, Roma 2014
Alberto De Bernardi, Un paese in bilico. L’Italia degli ultimi trent’anni, Laterza, Roma-Bari 2014
K. Galbraith, Il grande crollo, Boringhieri, Torino 1972
Scipione Guarracino, Storia degli ultimi settant’anni. Dal XX al XXI secolo, Bruno Mondadori, Milano 2010
Luciano Gallino Il colpo di stato di banche e governi. L’attacco alla democrazia in Europa Einaudi, Torino 2013
Charles P. Kindleberger, La grande depressione nel mondo 1929-1939. Introduzione di Federico Caffè, Etas Libri, Milano 1982
Charles S. Maier, Due grandi crisi del XX secolo. Alcuni cenni su anni Trenta e Settanta in Luca Baldissara (a cura di), Le radici della crisi. L’Italia tra gli anni Sessanta e Settanta, Carocci, Roma 2001
Richard Overy, Crisi tra le due guerre mondiali. 1919-1939, il Mulino, Bologna 1998 [1994]
Karl Polanyi, La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della nostra epoca, Einaudi, Torino 1974 [1944]
Idem, Europa 1937. Guerre esterne e guerre civili, a cura di M. Cangiani, Donzelli, Roma 1995
Andrea Rapini, I «cinque giganti» e la genesi del Welfare State in Europa tra le due guerre, in “Storicamente. Laboratorio di storia”, Annale 2012, ArchetipoLibri 2013
Giorgio Ruffolo, Stefano Sylos Labini, Il film della crisi. La mutazione del capitalismo, Einaudi, Torino 2012
Francesco Soverina, La democrazia nell’età della globalizzazione e della crisi degli Stati nazionali, in «Meridione. Sud e Nord nel Mondo» n. 3, luglio-settembre 2011
Stiglitz, I ruggenti anni Novanta. Lo scandalo della finanza e il futuro dell’economia, Einaudi, Torino 2004
Idem, La globalizzazione che funziona, Einaudi, Torino 2006
Paul Sweezy, Il presente come storia, Einaudi, Torino 1962
Giuseppe Vacca, Vent’anni dopo. La sinistra tra mutamenti e revisioni, Einaudi, Torino 1997



















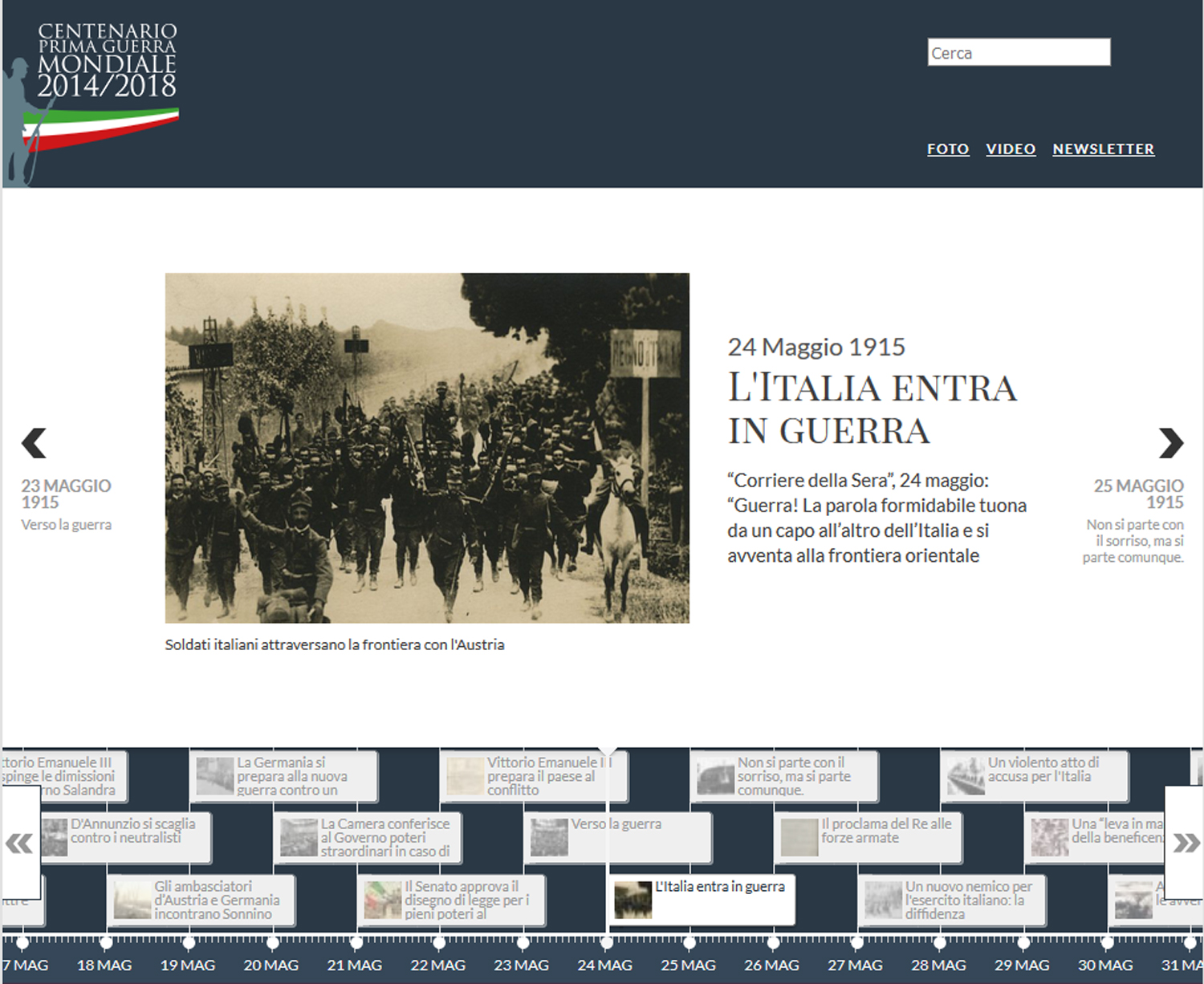
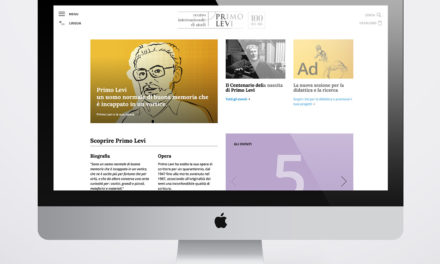


 Scarpe rotte eppur bisogna andar. Una storia della Resistenza in 30 oggetti, a cura di P. E. Boccalatte e M. Carrattieri
Scarpe rotte eppur bisogna andar. Una storia della Resistenza in 30 oggetti, a cura di P. E. Boccalatte e M. Carrattieri L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore
L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino
Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio
Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa
Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice
Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli
Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli L’arresto degli arlecchini
L’arresto degli arlecchini