
Guerre, nazionalismi, esodi: una prospettiva tra le due guerre mondiali
Posto di confine polacco sulla linea Oder-Neisse nel 1945.
Crediti: Autore ignoto — Andrzej Leszek Szcześniak (1980) Historia dla Klasy VIII, Varsovie : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, pp. 206 ISBN 83-02-01035-9, Pubblico dominio, Link
Abstract
Nel corso della Summer school 2024 dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri, tenutasi a Trieste dal 28 al 30 agosto, Štefan Čok ha intervistato Antonio Ferrara. Il loro dialogo ha permesso di inquadrare il fenomeno dell’esodo giuliano-dalmata nello scenario più complessivo degli spostamenti di popolazione avvenuti al termine del secondo conflitto mondiale e a evidenziare come questi stessi spostamenti siano in realtà strettamente connessi alle risoluzioni dei trattati di Parigi alla fine della Grande guerra.
_____________________
During the 2024 Summer School of the Istituto nazionale Ferruccio Parri, held in Trieste from 28 to 30 August, Štefan Čok interviewed Antonio Ferrara. Their dialogue made it possible to frame the phenomenon of the Giuliano-Dalmatian exodus in the more general scenario of the population displacements that occurred at the end of the Second World War and to highlight how these same displacements were in fact closely connected to the resolutions of the Paris Treaties at the end of the Great War.
Tanto alla fine della Prima quanto della Seconda guerra mondiale i trattati di pace ridefiniscono confini e determinano spostamenti di popolazione. Quali collegamenti e relazioni ci sono tra quello che avviene nel primo dopoguerra e quello che avviene nel secondo? E quali i legami con le vicende dei Balcani e della Frontiera adriatica?
C’è effettivamente un collegamento abbastanza stretto fra quello che avviene durante e subito dopo la Seconda guerra mondiale e quello che era avvenuto con la sistemazione territoriale del 1919 definita dai trattati di Parigi. Il punto di collegamento più evidente è che gli Stati che aderiscono all’Asse sono tutti determinati a rimettere in discussione l’assetto stabilito dagli accordi del 1919. Questo vale innanzitutto per Germania e Ungheria, che erano state molto penalizzate da quell’assetto che aveva attribuito loro confini molto più sfavorevoli di quelli rispettivamente del Reich tedesco e del Regno di Ungheria (all’interno dell’impero asburgico). Lo stesso vale per la Bulgaria, anch’essa costretta nel 1919 ad accettare confini ben più ristretti di quelli cui aveva aspirato fino dal XIX secolo e che riuscì a raggiungere proprio durante la Seconda guerra mondiale. Infine l’Italia, influenzata dal mito della vittoria mutilata, pur avendo ottenuto una sistemazione dei propri confini piuttosto favorevole, aspirava anch’essa a conseguirne una ancora più vantaggiosa. Quando nel 1941 Italia, Ungheria e Bulgaria partecipano all’invasione e poi alla spartizione della Jugoslavia, lo fanno per rimettere in discussione la sistemazione territoriale definita dai trattati del 1919 e, così facendo, espandere i propri territori. Per esempio, il Regno d’Italia consegue (anche se di fatto solo per poco più di un biennio) un confine orientale che ingloba anche buona parte della Dalmazia e realizza le aspirazioni dei più estremi fra i nazionalisti.
Va comunque ricordato che la rimessa in discussione della sistemazione territoriale definita a Parigi nel 1919 era iniziata ben prima dell’invasione della Jugoslavia. L’Ungheria, ad esempio, già nel 1938 aveva annesso una regione della Cecoslovacchia i cui abitanti erano in buona parte di lingua ungherese. Nel 1940 aveva fatto lo stesso con la Transilvania settentrionale, assegnatale da un arbitrato tenuto dalla Germania e dall’Italia. In effetti la linea guida della politica estera dell’Ungheria tra il 1938 e il 1941 è proprio l’appropriazione (o la riappropriazione) di territori al di là dei confini stabiliti nel 1919 ma in cui sono presenti popolazioni ungheresi.
Nel 1939 c’è poi l’evento scatenante il secondo conflitto mondiale, ovvero l’invasione e la spartizione della Polonia tra Germania e Unione Sovietica. In quell’occasione, la parte di Polonia annessa all’Unione Sovietica (già nell’ottobre 1939) formalmente divenne parte dell’Ucraina sovietica e della Bielorussia sovietica. Vilnius, attuale capitale della Lituania, era allora una città polacca (abitata in larga parte da ebrei) chiamata Wilno, che l’Unione Sovietica cede alla Lituania indipendente, salvo poi inglobare anche quest’ultima nel 1940. Ad ovest invece la Germania nazista annetté formalmente alcuni territori (tutti quelli che erano stati parte dello stato tedesco fino al 1918, ma anche altri) instaurando un “Governatorato generale” nel resto della Polonia occupata. Parimenti essa annetté l’Alsazia-Lorena e parti dell’attuale Slovenia, di nuovo ribaltando a proprio favore decisioni prese nel 1919, oltre ad occupare militarmente parti della Francia e della Jugoslavia.
Il periodo 1938-1941 è quindi il momento in cui le potenze insoddisfatte dalla sistemazione di Parigi del 1919 rimettono in discussione l’assetto territoriale sancito all’epoca; a farne le spese sono quei Paesi che dai trattati firmati a Parigi avevano ottenuto dei vantaggi – come Grecia, Jugoslavia, Polonia e Cecoslovacchia. Con l’annessione di porzioni di questi Stati arrivano anche azioni per ‘disfare’ le misure che quegli stessi stati avevano adottato nel primo dopoguerra per integrare le aree acquisite nei propri territori, con il risultato più o meno esplicito di creare disagi e svantaggi per alcuni abitanti. Nella Dalmazia annessa, per esempio, l’Italia licenziò e di fatto espulse i funzionari pubblici di lingua croata.
Questa politica di fatto è un’estensione di quella che era già stata attuata nel 1918-1919 in Istria e a Trieste. Ad esempio a Trieste c’era una comunità tedescofona, che nel 1918-19 in buona parte emigra verso l’Austria. In generale le minoranze o comunque le popolazioni diverse – per nazionalità o per lingua parlata (che non è la stessa cosa) – da quella italiana vengono trattate peggio di qualsiasi altra minoranza nell’Europa fra le due guerre. C’è quindi un deflusso, un’emigrazione, anche se non si può parlare di una politica di emigrazione forzata vera e propria, tanto più che l’idea dello Stato fascista era esattamente opposta, ovvero l’assimilazione forzata, volta a costringere gli “alloglotti” a diventare italiani e a parlare italiano (in questo c’è un interessante parallelismo con quanto sta facendo oggigiorno il regime russo nell’Ucraina occupata, dove i libri in ucraino vengono mandati al macero e le scuole sono costrette ad adottare i programmi stabiliti da Mosca, al fine di uniformare a forza – linguisticamente ma anche ideologicamente – gli abitanti dei territori annessi a quelli del paese che ha compiuto l’annessione). Una percentuale significativa della popolazione della frontiera adriatica di lingua slava lascia quindi l’Italia fascista tra le due guerre. Si parla di decine di migliaia di persone (infatti gli storici parlano di un esodo prima dell’esodo, anche se è un fenomeno meno concentrato).
Benché quindi l’Italia fascista sia il Paese che tratta peggio le minoranze fra le due guerre, dopo lo scoppio del secondo conflitto mondiale essa è anche quella che fa meno sforzi per espellerle dalle terre annesse. Gli ungheresi, invece, si accanirono contro coloro che avevano avuto vantaggi dalle riforme agrarie attuate in Cecoslovacchia, Romania e Jugoslavia dopo la prima guerra mondiale – le quali avevano spesso danneggiato i proprietari terrieri ungheresi a vantaggio dei contadini slovacchi, romeni e serbi; inoltre si scagliarono contro i funzionari pubblici romeni e cecoslovacchi e in generale contro coloro che, dopo il 1919, si erano stabiliti nelle regioni che l’Ungheria riuscì ad annettersi nel 1938-41. Tutti costoro furono espulsi – e non si trattò di un caso isolato, come mostra l’atteggiamento in linea di principio ancora più estremo della Lituania indipendente. Quest’ultima, prima di essere annessa all’Unione sovietica, equiparò giuridicamente tutti i polacchi arrivati a Wilno dopo il 1920 ai rifugiati giunti in città nel 1939, di fatto privandoli della cittadinanza e creando così le premesse per la loro espulsione. Quest’ultima fu effettivamente messa in atto (sotto forma di uno ‘scambio di popolazioni’) nel 1944, da parte della Lituania sovietica. Questa particolare vicenda dimostra una continuità di politiche nazionaliste anche prima, durante e dopo i regimi. Cambiano cioè i regimi e i governi, ma alcune politiche nazionaliste sono portate avanti a prescindere, anche perché purtroppo godono di una certa popolarità – basti pensare, ad esempio, che espellere insegnanti e funzionari pubblici da una città o da una regione significava, in genere, aprire altrettante posizioni che potevano essere attribuite agli abitanti di quella città o regione (e/o ai sostenitori del partito o del regime al potere in quel momento).
Tra gli Stati dell’Asse, quindi, l’Italia fascista è il Paese che opera meno rimozioni forzate di popolazione. Come scritto sopra, la ragione principale risiede nella convinzione di riuscire alla fine ad assimilare forzosamente queste popolazioni, perché la cultura italiana è considerata superiore a quella slovena e croata. In parte però v’è anche una pura e semplice incapacità di farlo. Espellere molte persone è logisticamente complicato, tant’è che anche la Germania nazista si scontra con diverse difficoltà, pur avendo un approccio totalmente differente rispetto ai fascisti. In teoria almeno, essa intendeva germanizzare il suolo, non le persone; in linea di principio il polacco rimaneva polacco (a meno che non fosse ‘razzialmente idoneo’ a diventare tedesco), quindi andava cacciato e non assimilato. Ciononostante, nei fatti la percentuale di individui effettivamente rimossi dai territori annessi alla Germania non superò mai il 10% del totale della popolazione.
Chiaramente tutti questi progetti di “massimalismo nazionalista” delle potenze dell’Asse stimolarono il “massimalismo nazionalista” dei paesi occupati. Quindi già nel 1941, per esempio, i nazionalisti sloveni rivendicano Trieste, Klagenfurt e la Carinzia, aspirando a realizzare la cosiddetta ‘Slovenia unita’. Ancora prima di allora, il governo polacco in esilio a Londra aveva rivendicato quello che è oggi il confine occidentale della Polonia, situato lungo in corso dei fiumi Oder e Neiße – molto più a ovest di quanto sia mai stato in tutta la storia della Polonia, tranne che nel Medioevo, quando comunque non c’era uno Stato polacco. Per farlo esso aveva argomentato come, per garantire la sicurezza della Polonia contro una nuova aggressione tedesca, fosse innanzitutto necessario rimuovere tutti i potenziali “nemici interni”, allontanando a forza dal suolo polacco chiunque parlasse tedesco per poi garantire una specie di zona cuscinetto tra i due stati, anche questa senza tedeschi, posta sull’unico confine difendibile, che si trova appunto sul fiume Oder.
E’ chiaro come in questa prospettiva, il vero punto di rottura è la questione dei Sudeti nel 1938. Nel momento in cui, con l’accordo di Monaco, si stabilisce che il territorio abitato da una minoranza germanofona deve entrare a far parte del Reich tedesco, ciò significa rimettere in discussione l’integrità territoriale di tutti gli stati nei quali risiedono ‘minoranze nazionali’ – di cui, da questo punto in poi, tutti gli stati dell’Europa centrale ed orientale desiderano sbarazzarsi.
Questa prima panoramica ci mostra come alcuni fenomeni siano veramente collegati in una prospettiva di lungo periodo e quindi ciò che accade alla fine della Seconda guerra mondiale ha radici che affondano molto in profondità nel periodo precedente. Parlando dei fenomeni di migrazioni forzate, quali sono quelli che meglio si possono comparare con quello istriano?
Per fare una comparazione bisogna prima definire che cos’è l’esodo istriano. Si tratta di un fenomeno in cui una popolazione abbandona un territorio che cambia da un lato il regime statuale (passa dall’Italia alla Jugoslavia) e dall’altra il regime economico-sociale (dal capitalismo al socialismo),
Non è comunque il primo luogo in cui questo avviene, perché casi analoghi si verificano nei territori annessi all’Unione sovietica in seguito al Patto Molotov-Ribbentrop: Paesi baltici, Ucraina occidentale, Bielorussia occidentale e Moldavia. Ed è proprio con questi casi che si può tentare una comparazione, che si presenta tuttavia molto difficile.
Questi paesi, proprio come l’Istria, vengono integrati in una Federazione multinazionale. Ciò significa innanzitutto che l’ampliamento dei confini sovietici non è un ampliamento dei confini russi. In secondo luogo, che l’accettazione del regime sovietico non implica cancellare le istanze nazionali bensì portarle avanti. Un esempio molto significativo è la Lettonia, che era stata sovietica nel 1919 per un breve periodo e aveva perseguitato con forza la popolazione di lingua tedesca, in parte per ragioni di carattere nazionalista, in parte anche perché la popolazione tedesca aveva le migliori posizioni economiche e sociali, come gli italiani in Istria. Nel 1939 la Lettonia torna a fare parte prima formalmente della sfera di influenza sovietica, poi viene addirittura annessa nel 1940. A questo punto alla popolazione in lingua tedesca viene offerta la possibilità di tornare nel Reich, stavolta non con l’ampliamento del confine tedesco bensì migrando. Non può certamente essere definito uno spostamento forzato e tuttavia esso non è nemmeno libero, perché ovviamente queste persone di lingua tedesca in normali condizioni non avrebbero mai deciso di lasciare la propria casa e il proprio lavoro per stabilirsi nella Polonia occupata, Tuttavia, essi lo fanno nel momento in cui l’alternativa è vivere in Unione Sovietica (e aspettarsi, ragionevolmente, di venire perseguitati se non deportati in Siberia, come in effetti accadde a molti abitanti dei paesi baltici nel 1940-1).
Questa situazione è solo parzialmente paragonabile a quella degli Italiani in Istria. Nel caso italiano non c’è un accordo di scambio di popolazioni come quello tra Unione Sovietica e Germania nazista, che permetteva alle popolazioni di lingua tedesca che abitano in questi territori annessi all’Unione Sovietica di tornare in Germania. Peraltro, costoro al ritorno in Germania finiscono nei campi profughi, dove ha luogo una selezione a seguito della quale quelli ritenuti ‘razzialmente idonei’ vengono mandati a colonizzare territori annessi. In questo modo, essi di fatto contribuiscono a rendere profughi altre persone – alcuni di loro testimonieranno di aver preso possesso di case i cui legittimi proprietari erano stati espropriati e deportati poche ore prima.
Un altro caso interessante riguarda poi i territori dell’attuale Ucraina occidentale, che fino al 1939 erano parte della Repubblica polacca. Quando c’è l’annessione all’Unione sovietica, ci sono repressioni piuttosto ingenti da subito, come dimostra l’evento più celebre, ovvero la strage di Katyn. I familiari degli ufficiali polacchi vengono deportati in Kazakhstan poche settimane dopo perché ritenuti parenti dei nemici del popolo, quindi persone non troppo affidabili che è meglio non aver vicino al confine. Vengono deportati anche i rifugiati ebrei giunti dalla Polonia occupata dai nazisti, che riparano nella Polonia occupata dai sovietici per sfuggire alle persecuzioni antisemite; tuttavia, quelli tra loro che rifiutarono la cittadinanza sovietica, perché speravano di tornare presto alle loro case, vennero considerati ‘elementi inaffidabili’ e per questo motivo deportati nel giugno 1940. Paradossalmente, in tal modo essi scamparono alle successive persecuzioni naziste e, in gran parte, sopravvissero alla guerra e alla Shoah. Gli ebrei rimasti in quei territori furono infatti quasi tutti sterminati – alcuni da ausiliari di polizia reclutati in loco che, però, a un certo punto nel 1943 disertarono, si unirono alle formazioni di partigiani nazionalisti ucraini e misero in atto una vera e propria pulizia etnica della popolazione polacca.
Questo quadro è utile a capire che spostamenti di popolazione e violenze durante e dopo la Seconda guerra mondiale non furono affatto una prerogativa della frontiera adriatica ma avvengono in tutta Europa. I livelli di violenza furono, altrove, ben superiori: la pulizia etnica appena citata causò nella sola Volinia decine di migliaia di vittime, contro qualche centinaio delle foibe del settembre-ottobre 1943.
Tra caso polacco-ucraino e caso italiano vi sono certo importanti differenze. Nel primo caso la violenza ebbe motivazioni prettamente nazionaliste, mentre in Istria i perpetratori delle uccisioni e dei successivi infoibamenti facevano parte di un movimento partigiano comunista e colpirono soprattutto esponenti locali del nazionalismo italiano e del fascismo (intesi però in senso molto lato). Tali violenze non miravano espressamente alla pulizia etnica, anche se almeno alcuni tra i loro esecutori probabilmente avevano motivazioni nazionaliste.
Più che nella violenza quindi le similitudini più importanti si riscontrano nel fatto che, tanto in Ucraina occidentale quanto in Istria, il combinato disposto tra l’instaurazione di un regime socialista “alieno” (formalmente l’Istria venne annesse alle repubbliche slovena e croata della federazione jugoslava) e il ricordo delle violenze avvenute nel 1943 contribuirono ad incentivare le popolazioni minoritarie all’emigrazione una volta che i confini si furono stabilizzati (nel 1945 in un caso, al più tardi nel 1947 nell’altro). Nel caso istriano, oltretutto, abbandonare la Jugoslavia significava anche emigrare dal “campo socialista” e raggiungere il “mondo libero”, il che funzionò da incentivo supplementare inducendo ad emigrare (e magari a dichiararsi italiani per farlo) anche molte persone di lingua slovena e croata scontente del nuovo regime.
























 L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore
L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino
Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio
Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa
Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa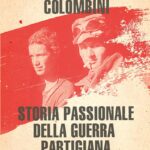 Storia passionale della guerra partigiana di Chiara Colombini
Storia passionale della guerra partigiana di Chiara Colombini Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice
Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli
Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli L’arresto degli arlecchini
L’arresto degli arlecchini