
Cassandra a Mogadiscio
La copertina del volume.
Igiaba Scego
Cassandra a Mogadiscio
Giunti/Bompiani, 2023 (pp. 368)
La produzione di Igiaba Scego, scrittrice afrodiscendente di lingua italiana, nota per i romanzi e i saggi di tema post-coloniale, si arricchisce di un decisivo capitolo autobiografico, un libro che si candida a incarnare con forza la nozione di autofiction. Credo si possa definire così un’opera in cui le vicende sono reali, coincidenti in questo caso con la storia di una famiglia, e sono narrate con tecniche di scrittura romanzesca. La narratività stessa diventa uno strumento di costruzione e ridefinizione della propria instabile identità – intesa come un flusso inestricabile di storie, emozioni e legami – e, ancora di più, cura di sé e degli altri attraverso la memoria.
Cassandra a Mogadiscio[1] è la storia di una famiglia “poliedrica e diasporica” che ha attraversato il secondo Novecento e in cui la Somalia e l’Italia, i due paesi che più segnano la vita dell’autrice, sono i punti focali: un racconto che si fa paradigmatico per le vicende coloniali, le guerre, le dittature, le migrazioni. Scego è cresciuta in una famiglia somala che ha perso tutto a causa della dittatura di Siad Barre, fuggendo in Italia nel 1970. Negli anni Trenta il nonno era stato interprete di Rodolfo Graziani in Etiopia; il padre, aabo, è stato un funzionario e politico nei governi somali dal 1960; la madre, hooyo, ha vissuto in Somalia negli anni della guerra civile tra fine anni Ottanta e primi Novanta. Sono moltissimi i racconti di vita familiare, che includono l’adolescenza dell’autrice a Roma durante la quale ha imparato ad amare la lingua in cui ha deciso di diventare scrittrice:
siamo una famiglia, wahan nahay qoys, e come tutte le famiglie somale della dispora siamo dispersi in cinque continenti. Spezzati dalla guerra che ci ha colpito, dagli infortuni, da un’antica dittatura, dalla morte e dall’amore. E ogni separazione ci distrugge. Ci disperde. Ci annienta.[2]
Si tratta di una serie di condizioni che comportano una conoscenza diretta e concreta del colonialismo e dei suoi effetti di lungo periodo e che costituisce lo sfondo da cui nasce la produzione di Scego.
Il libro è infatti una composizione di momenti intensi di storia privata che intreccia la sfera intima e la “grande Storia”, i centri e le periferie del mondo, le città e le lingue. Richiamandosi a una vasta costellazione di riferimenti, nella quale brillano James Baldwin e bell hooks, l’autrice esplicita in forma vitale e urgente il magma emotivo e psicologico da cui sorge la sua personale prospettiva di critica post-coloniale e femminista intersezionale. Altrove l’autrice ha scritto programmaticamente in prospettiva didattica[3]: in questo caso, dal punto di vista di quello che la letteratura offre alla didattica, in un momento culturale in cui il tema del colonialismo è al centro della riflessione storiografica, della memoria pubblica e dei dibattiti a essa collegati, Cassandra a Mogadiscio si presta con efficacia a essere letto nel triennio della scuola secondaria superiore. Nella narrazione precipitano e si annodano temi e riflessioni di enorme urgenza e attualità, che la scrittura può restituire in modo vivo, plastico e naturale, senza l’irrigidimento retorico spesso comportato dalla canonizzazione scolastica e la rubricazione a elemento di educazione civica.
Inoltre, molte tra le pagine più intense sono quelle in cui Scego parla apertamente della difficoltà di crescere in Italia, tra gli anni Ottanta e Novanta, come giovane donna di origine somala e come profuga, dando voce a una condizione sempre più diffusa per molti nuovi cittadini e cittadine che si trovano a fare i conti con la criticità della loro cittadinanza italiana incompleta, perché ostacolata dalle condizioni socio-economiche, da un impianto legislativo e culturale venato di arcaismi e dalle pulsioni politiche nativiste, populiste e identitarie (quando non apertamente razziste). Una prospettiva di rappresentazione e/o di identificazione italiana nera e musulmana ha grande valore per il pluralismo democratico dell’Italia contemporanea, soprattutto di fronte al clima di provinciale neo-nazionalismo calato dall’alto sulla cultura istituzionale.
La voce della scrittrice è qui più nitida che mai. Il libro ha la forma di una lettera, talvolta di una chiamata telefonica o di una call internazionale, che si rivolge a Soraya, la più giovane nipote che ha vissuto nel Regno Unito e ora in Canada, e che diventa la destinataria della trasmissione dei ricordi di famiglia da parte della sua orgogliosa e accudente zia (edo). Il ritmo è travolgente e talvolta senza filtro, trabocca di amore, dolore, vergogna, rabbia e prende dichiaratamente il colore di una trasmissione orale femminile e il timbro epico dalle evocazioni ancestrali, segnato anche dalla presenza di formule intercalari della lingua somala e dell’idioletto familiare, in un dialogo ininterrotto con persone reali e fantasmi.
Questa «lettera schizofrenica, piena di sospiri e di salti temporali»[4] intesse diversi fili di una presa di coscienza che vuole essere anche una terapia, più mitografia collettiva che confessione solitaria, sempre in bilico sul crinale tra l’urgenza del racconto di sé e la presa di parola dal valore politico.
I quattordici capitoli (a cui si aggiungono un intermezzo e una postfazione) sono scanditi da episodi e ricordi delle figure familiari, tra tutte la madre e il padre, in un caleidoscopio di ritratti di fratelli, sorelle, zie, zii, cugini e cugine che ricompongono uno scenario complesso da prospettive differenti: il tratto che attraversa le diverse traiettorie di migrazione, profuganza, perdita e ricerca continua di riscatto e felicità e guida la scrittura è il Jirro, la malattia, intesa come l’effetto delle ferite e del dolore, del trauma che si incarna e avvelena i corpi e disintegra le vite. Scrive Scego:
Jirro in somalo significa malattia, letteralmente è così, ogni vocabolario ti riporterà questa spiegazione, persino Google Translate. Ma Jirro è per noi una parola più vasta. Parla delle nostre ferite, del nostro dolore, del nostro stress postraumatico, postguerra. Jirro è il nostro cuore spezzato. La nostra vita in equilibrio precario tra l’inferno e il presente. Siamo esserei diasporici sospesi nel vento, sradicati da una dittatura ventennale, da una delle più devastanti guerre avvenute sul pianeta Terra e da un grosso traffico di armi che ha seppellito le nostre ossa, e quelle dei nostri antenati, sotto un cumulo di kalashnikov che dalla Transnistria sono sbarcati direttamente al porto di Mogadiscio. Per annientarci.[5]
Nelle Troiane di Euripide, Cassandra è la sacerdotessa che vede la catastrofe senza poter essere creduta, che evoca così fin dal titolo la condizione di impotenza e incredulità di fronte alla violenza della realtà. La pluralità di traumi a più dimensioni prende l’aspetto dei mali che hanno colpito i membri del nucleo familiare e quello delle proprie fragilità, esibite con disarmante onestà: dai disturbi alimentari a quella della vista, il racconto è intessuto di una delicata attenzione al corpo, in particolare quello proprio e femminile, e alla violenza che questo subisce nella condizione di subalternità, tanto nelle società africane quanto in quelle europee con le loro diverse modalità di essere patriarcali.
Eppure non mancano mai vitalità e determinazione. In ognuno dei ritratti evocati dalla memoria si ritrovano i segni di una lotta per la propria autoaffermazione che si manifesta nel bisogno di creatività e nei tanti gesti in cui lo «sgomento» si accompagna con «la stessa gioia di stare al mondo».[6] La stessa che Scego riconosce nelle foto della madre da giovane e nelle immagini digitali della nipote, in un passo centrale del libro che – commentando la foto di copertina – si dimostra una vera e propria dichiarazione di fede nella verità di cui è capace lo spazio letterario.
Nel flusso narrativo di una scrittura volutamente senza ringhiera si staglia l‘Intermezzo decoloniale,[7] in cui la visita con alcuni nipoti/cugini al Museo delle Civiltà dell’Eur a Roma diventa manifesto programmatico e cuore politico-culturale del libro. Il materiale di un museo di propaganda fascista, il cui scopo era comunicare la superiorità bianca e la celebrazione del progetto imperialista e razzista, diventa
il suo esatto opposto: una piattaforma decoloniale contemporanea. Un luogo, un’idea una speranza per interrompere la marcia degli stivali, le invasioni coatte, il sangue, il colonialismo che c’è stato e che in Italia non si è mai veramente discusso. Per arrestare il male creando un ponte tra le due sponde, Europa e Africa. Non nascondendo il passato, ma mostrandolo, con le lenti dell’intelligenza e del cuore. Per convertire ciò che un tempo era dolore, un museo e manufatti che erano tossici, in uno strumento per superarlo. Per provare a portare la luce dove tropo a lungo c’è stato soltanto il buio. Il Jirro.[8]
La pelle di un leopardo o un quadro di gusto orientalista a soggetto femminile, gli oggetti quotidiani di un bottino custodito negli archivi dei colonizzatori, mostrano con gli occhi dell’afrodiscendenza il «potere di sottomissione e umiliazione»[9] subìto da una parte del mondo. In ogni oggetto rubato e trasformato in manufatto etnologico (e ideologico) c’è una memoria di ingiustizia intergenerazionale che va decodificata, trasmessa e redenta dal suo tragico passato come monito per un presente e un futuro differente.
Come i dipinti di gusto “orientalista” a soggetto femminile:
Anche lì una donna. Ma questra volta è come uno schiaffo in pieno viso. È accovacciata, nuda, indifesa, capelli al vento, ricci ribelli esposti. Nessun gioiello, nessun vestito bianco. Nessuna muriad d’oro luccicante. Nessun foulard indiano. Gli occhi sembrano quelli di un’antilope spaventata, con un tenue residuo di bagliore che ne fa intuire una personalità forte annichilita dal tempo, dalle circostanze, dagli invasori. Guardandola ricordo i racconti di hooyo sulle kurkurei del quartiere Shangani, donne maritate che arrotondavano i magri guadagni della famiglia con prestazioni sessuali a pagamento per quegli stranieri inviati dalla Nazioni Unite a impartire lezioni di democrazia. Ho visto tante foto, quadri, bozzetti di donne che durante il colonialismo e anche dopo hanno dovuto mostrare il corpo, più o meno forzatamente all’invasore bianco. Dico sempre che lavorare su questo settore della storia, sul coloniale, significa lavorare su materiale pornografico, il più delle volte disturbante. Nella mia testa il corpo di quella donna si sovrappone all’umiliazione di mille altre donne che ho intravisto negli archivi e nelle foto antiche trovate durante le mie immersioni nei mercatini.[10]
O come un pettine di legno, oggetto tradizionale e artigianale, legati ai ricordi di infanzia, oggi sostituito da anonimi oggetti di plastica:
il Jirro è questo, Soraya. Un pettine che non sappiamo più usare, costruire, inventare. Una parte di noi, delle conoscenze degli antenati, che non abbiamo salvato dalla furia che ci ha travolti. […] In quel pettine c’è un insegnamento da trasmettere agli artigiani di oggi, che oggetti di quel tipo non li fabbricano più perché con la guerra si è persa la memoria di come si facevano le cose. Guardare quel pettine potrebbe spingere qualcuno a ripristinare la comunicazione tra passato e presente che la guerra ha interrotto.[11]
Lo sguardo ferito di Scego parla al lettore di ciò che è stato silenziato e naturalizzato nell’orizzonte culturale dal racconto dominante della “bianchezza” occidentale, che per lungo tempo si è creduta la forma universale dello spirito. Potente nel realismo e nel tratto pedagogico («provengo da una cultura in cui in fondo sei sempre una figura genitoriale in potenza»),[12] Cassandra a Mogadiscio chiede di non ignorare il bisogno di riparazione e di giustizia che si leva nel nostro tempo post-coloniale.
Note:
[1] I. Scego, Cassandra a Mogadiscio, Giunti/Bompiani, 2023 [https://www.bompiani.it/catalogo/cassandra-a-mogadiscio-9788830109230].
[2] Scego, 2023, p. 10.
[3] G. Gabrielli, Igiaba Scego. Un’intervista a partire da Figli dello stesso cielo, in «Novecento.org», 18, 2022 [https://www.novecento.org/uso-pubblico-della-storia/igiaba-scego-unintervista-a-partire-da-figli-dello-stesso-cielo-7475/]; E. Manera, Una favola sull’ingiustizia /Igiaba Scego. Prestami le ali, in «Doppiozero», 9 agosto 2017 [https://www.doppiozero.com/igiaba-scego-prestami-le-ali]
[4] Scego, 2023, p. 193.
[5] Scego, 2023, p. 17.
[6] Scego, 2023, p. 217.
[7] Scego, 2023, pp. 219 sgg.
[8] Scego, 2023, pp. 222-23.
[9] Scego, 2023, pp. 223.
[10] Scego, 2023, pp. 227-8.
[11] Scego, 2023, p. 229.
[12] Scego, 2023, p. 364.






















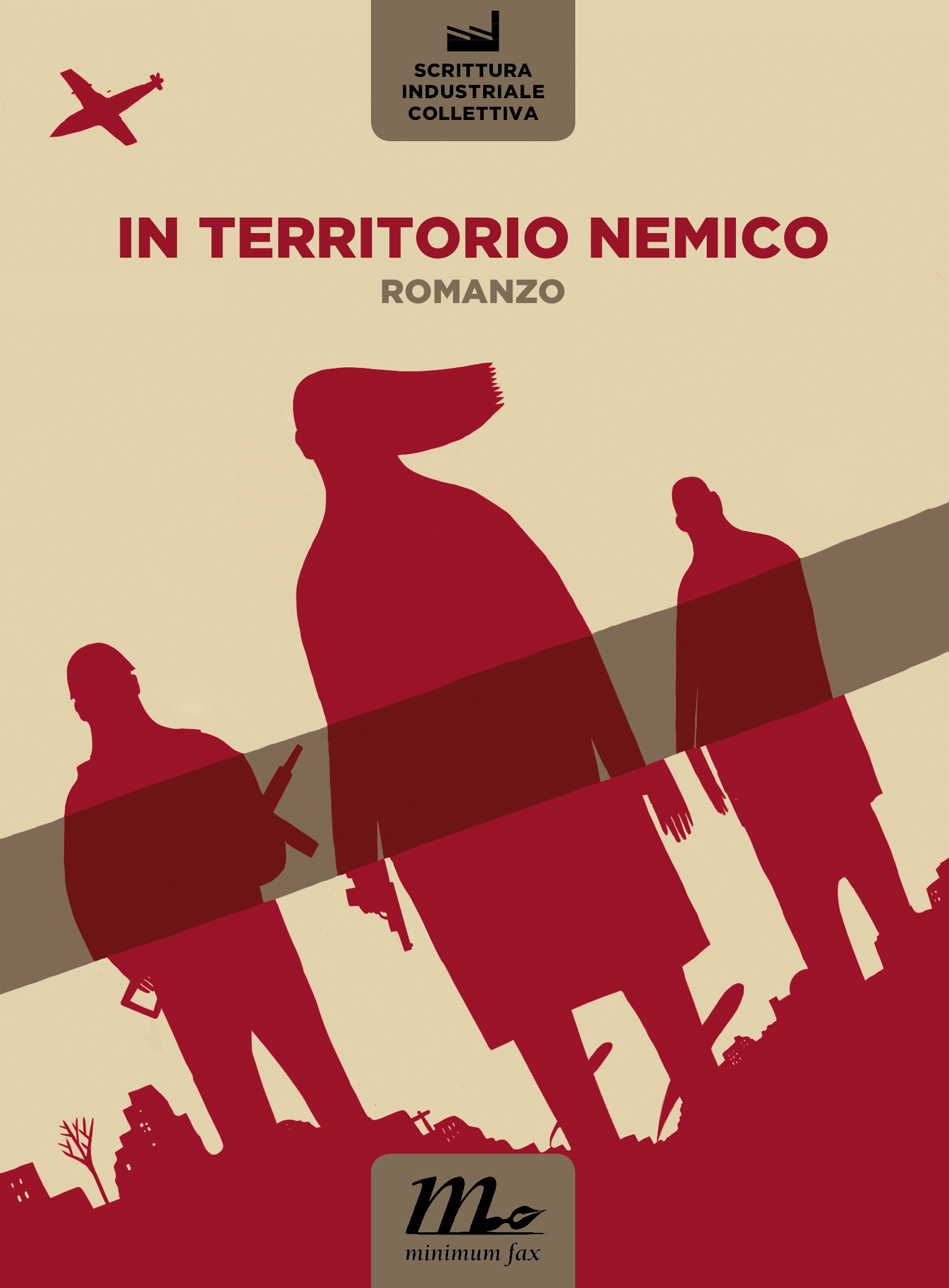

 L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore
L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino
Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio
Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa
Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa Storia passionale della guerra partigiana di Chiara Colombini
Storia passionale della guerra partigiana di Chiara Colombini Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice
Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli
Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli L’arresto degli arlecchini
L’arresto degli arlecchini