
L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore
Copertina del volume dal sito dell’editore Laterza
Fabio Fiore
L’affaire Matteotti. Storia di un delitto
Edizioni Laterza, Bari-Roma 2024, pp.139
La scienza della parola
resta ormai la più attendibile.
(Leonardo Sciascia)
L’affaire Matteotti. Storia di un delitto di Fabio Fiore risponde a tre intenti: fare divulgazione storica tenendo insieme analisi e racconto, fare i conti con un passato ossessivamente rievocato ma allo stesso tempo rimosso, farsi carico di una «responsabilità prospettiva oltreché retrospettiva» (parole di Sergio Luzzatto citate nella Premessa del volume). Questi tre intenti rendono il libro particolarmente utile per l’autoformazione degli insegnanti di storia, i quali si confrontano quotidianamente con un bisogno fortissimo – da parte degli studenti – di storie ben raccontate, con la necessità di illuminare il passato per rendere più chiaro e visibile il presente. I nuclei del racconto sono sei e corrispondono ai capitoli: la meccanica del delitto, gli esecutori, i mandanti, i moventi, gli esiti e infine la figura di Giacomo Matteotti. Il montaggio di questi elementi è la forza della storia, unitamente a una scrittura sensibile e duttile che, accendendosi dietro ogni fatto e personaggio, illumina il buio e crea ombre, nuances. Insomma, il lettore è indotto/sedotto a pensare, ragionare, collegare, commuoversi. In certi passi anche ridere, ovviamente il riso avvelenato che nasce dall’esposizione del grottesco, della cialtroneria violenta.
Lo gnommero gaddiano – perché di questo anche si tratta, come sostiene l’autore, vista la complessità della vicenda – ha una precisa meccanica, che si sviluppa nel giro di poche ore, tra l’attesa di Matteotti all’interno di una Lancia Lambda modello Limousine con targa bene in vista, la fulminea cattura e uccisione del deputato e infine l’occultamento maldestro del cadavere e della vettura. A stretto giro segue la valanga degli arresti che si abbatte sugli esecutori diretti e i loro complici.
Liquidati nelle prime pagine i fatti, si passa alle persone. I cinque esecutori del rapimento e dell’omicidio, tutti all’incirca trentenni, sono già presentati brevemente nel primo capitolo: hanno in comune il fatto di aver partecipato alla prima guerra mondiale in corpi speciali, gli Arditi dei reparti d’assalto; di avere precedenti penali e di essere stati amnistiati nel 1919; di intrattenere legami strettissimi con i vertici del fascismo; di appartene alla Čeka. Ma soprattutto li accomuna l’idea che l’esercizio della violenza sia un loro diritto. Bastano queste poche informazioni per ricostruire la scena del crimine e i suoi criminali. Ci sono anche delle comparse non previste, dei testimoni – due bambini, una coppia di custodi, un carabiniere – e del resto è pieno giorno quando avviene il fatto. Oltre a questo, il primo capitolo è però soprattutto dominato dalla scansione del tempo, dalla cronistoria di quel martedì 10 giugno 1924 e dei giorni successivi; ci dà insomma le coordinate temporali.
Nel capitolo successivo il tempo cambia, acquista profondità: non è il tempo che mette in ordine i fatti, è il tempo che li spiega. E allora per trattare degli Esecutori non si descrivono solo i singoli che compongono il gruppo di fuoco – assimilati «a personaggi di una commedia all’italiana, a una armata Brancaleone; o se si preferisce, a una banda di bravi di manzoniana memoria» (p.19) – ma si descrive soprattutto il loro tempo, quello della violenza fascista nata dalla violenza praticata durante la Grande guerra (non la violenza industriale della trincea, come si è detto, ma quella all’arma bianca degli Arditi) e poi confluita (con le opportune distinzioni) nella violenza dello squadrismo e infine della Čeka, soprannominata la “banda del Viminale” per lo stretto legame con il palazzo romano in cui aveva sede il governo. Una violenza per certi versi scomposta e non “chirurgica, intelligente, cavalleresca”(p.30), come la vorrebbe il duce, ma che si avvale certamente degli aiuti del partito, del governo e delle forze dell’ordine.
I mandanti si muovono nel campo vischioso del potere, mentre i moventi appartengono al regno delle ipotesi. «Per sopravvivere alla selva di moventi proposti da chi si è occupato del delitto, ci siamo lasciati guidare da un noto racconto di Borges, La morte e la bussola, raccolto in Finzioni», si legge a p.57. L’autore non intende scegliere la più attendibile («da non storici, la cosa ci compete fino a un certo punto», p.58) ma lascia al lettore il compito di analizzarle tutte e di optare, borgesianamente, per la più interessante. Del resto è «proprio l’indecidibilità delle ipotesi a fare del delitto Matteotti un affaire» (p. 58). Quello che però aiuta a muoversi nella selva della ipotesi, e delle rispettive “varianti”, è la mappa che l’autore fornisce, quando raggruppa i principali moventi in base a tre discorsi: quello pronunciato da Matteotti alla Camera il 30 maggio; quello che avrebbe dovuto pronunciare l’11 giugno e il discorso di Mussolini a Montecitorio del 7 giugno. La verità è cercata tra le pieghe di queste parole. Si tratta della verità letteraria di cui è il massimo fautore in Italia Leonardo Sciascia. Non solo lo Sciascia de L’affaire Moro – di cui esplicitamente si riprende il titolo – ma anche quello de La scomparsa di Majorana: l’investigazione letteraria vaglia documenti, li interpreta, formula ipotesi, mette in luce nessi, ma alla fine è la “scienza della parola” – per riprendere l’espressione di Sciascia citata in esergo – che compie il prodigio, è lo speciale ordine e senso narrativo che illumina i fatti. Nel testo non ci sono informazioni storiche inedite, è dichiarato subito, nelle prime pagine. Ma c’è la volontà civile di offrire una verità, che è fatta appunto di parole vere. Le parole vere sono quelle che rendono accessibile ciò che è autenticamente umano ed è per questo che il ritratto di Matteotti contenuto nell’ultimo capitolo, come si vedrà a breve, rappresenta il cuore del libro.
Prima di introdurre la figura di Matteotti, Fiore fa uscire di scena tutti gli altri. È nel capitolo Esiti, qui inteso più nel significato di sbocchi, di uscite più che di risultati, che i vari personaggi cercano il modo di togliersi dall’impiccio. Sotto la voce esiti sono rubricati eventi molto diversi tra loro: il pasticcio del ritrovamento del cadavere, il discorso del duce del 3 gennaio 1925, i processi, la rete di relazioni tra Mussolini e gli altri protagonisti dell’affaire (un’intricata trama di ricollocamenti in nuovi ruoli, minacce, richieste di denaro, avventure coloniali), il mistero della documentazione segreta smarrita mentre Mussolini tenta di raggiungere il confine svizzero, persino l’aiuto economico dato alla vedova Matteotti e, ovviamente, esito degli esiti, la morte di tutti. L’uscita da uno gnommero non può essere un’azione coerente e articolata, ma una sinistra congruenza – perfettamente ricostruita nel volume – che è data dallo sfondo, dal clima.
Morti tutti, dunque, appare Matteotti. Dopo la carrellata di caimani del Piave e scagnozzi vari, la figura del deputato giovane, bello e signorile, «in grado di leggere un bilancio come noi leggiamo un romanzo» (lo definisce così Carlo Silvestri citato a p.110), con l’attitudine – rarissima tra i politici italiani di ieri e di oggi – a documentarsi seriamente, a frequentare dati e statistiche, a non risolvere tutto in rotonda retorica e teatrale gestualità, ecco la figura del deputato socialista ammazzato dai fascisti ha qualcosa di irreale, si muove fuori dal tempo. Ricorda – per affinità narrativa, beninteso, e non politica o storica – Aldo Moro: non quello con cui fa i conti Sciascia nel suo instant book, ma quello interpretato dal grande Roberto Herlitzka, recentemente scomparso.
Nel film di Bellocchio, Buongiorno, notte, che racconta appunto il sequestro del presidente della DC, c’è una sorta di doppio finale: Moro, prima dell’esecuzione, mentre i brigatisti dormono, apre la porta della sua prigione e, come in sogno, vaga libero e leggerissimo per le strade di una Roma deserta. La straordinaria fisicità di Herlitzka esprime il senso di quella liberazione che è distinzione e lontananza assoluta dalla capitale del potere. L’altro finale è quello “storico”: Moro bendato in procinto di morire.
Ebbene, il Matteotti tratteggiato nell’ultimo capitolo del libro è l’apparizione di un fantasma, è perturbante nella sua estraneità al contesto non solo del regime ma anche del suo stesso partito. Dati alla mano, nel fascicolo che esce anonimo nel 1923, Un anno di dominazione fascista, Matteotti aveva denunciato «il carattere padronale e classista della politica economica del governo» (p.112); l’abuso della decretazione d’urgenza; la distruzione di cooperative, enti consorziali e sindacati. Aveva enumerato minuziosamente le violenze fasciste dal novembre del 1922 al novembre del 1923 con date, nomi e cognomi, tipo di violenza. Ma era anche stato polemico – dalle pagine del settimanale socialista polesano La lotta – verso gli attacchi generici e populisti contro «lo Stato dissanguatore» (p.115), verso il mito dello sciopero generale. Il suo pacifismo è quello di «un combattente contro la guerra», come lo definisce Gobetti (p.119). Insomma, la visione politica di Matteotti è sfaccettata e complessa e non possiamo certo riassumerla qui. Vale però la pena riprendere una definizione che di Matteotti dà l’autore, quando afferma che egli incarna alla perfezione la figura del “parresiasta”: non è un martire, ma un filosofo antico, un uomo in lotta che ha «il coraggio di dire la verità in faccia al potente di turno, rischiando la vita» (p.122).
Ecco allora la verità narrativa che emerge da L’affaire Matteotti, la conclusione dell’investigazione: lo scioglimento del garbuglio è affidato al “dato umano”, psicologico e ambientale, – a quello che Sciascia chiama “il metodo Maigret”. Non si tratta di capire cosa è successo a Matteotti, bensì chi è Matteotti. Ed è pensando al suo specifico stile politico, che era poi anche il suo specifico modo di vivere (e di amare), che si può comprendere ma non spiegare cosa sia realmente successo
sul lungotevere, quel pomeriggio afoso di una precoce estate romana, in cui un uomo innocente – giovane, bello, signorile -, uscendo di casa, sta per andare incontro a una fine atroce, per mano di sicari fascisti (p.133).
L’affaire Matteotti è un saggio divulgativo che – così si dice di solito di un testo che può appassionare il lettore comune, curioso, capace di farsi domande ma privo di una cultura specialistica – “si legge come un romanzo”. Alla base di questa espressione c’è però un pregiudizio di fondo, che ha esplorato bene lo storico Carlo Greppi nel suo ultimo libro storie che non fanno la Storia:
Per questo va tanto in voga, credo, l’espressione “si legge come un romanzo”. Perché c’è ben poca cognizione, nel senso comune, del fatto che gli strumenti della narratologia siano a disposizione di chiunque scriva (anche) di storia; per quanto uno possa utilizzarli consapevolmente esiste però una distanza siderale tra l’invenzione e la ricostruzione di fatti autentici ed eventi appunto attestati, e verificabili.[1]
Pur rimanendo strettamente nell’ambito della non fiction, il volume di Fabio Fiore consente di riflettere sul nesso vitale tra scrittura di invenzione e ricostruzione storica e soprattutto di superare certe categorie interpretative datate e manualistiche: il montaggio tipico della letteratura investigativa, il posizionamento dell’autore che scopre i propri strumenti di indagine e le proprie letture, l’illuminazione dall’interno dei personaggi non tradiscono il patto di onestà con il lettore bensì lo rinforzano. I fatti sono tutti verificati e reali, ma è la scienza della parola che li rende – agli occhi di chi legge – veri.
Note:
[1] Carlo Greppi, storie che non fanno la Storia, Editori Laterza, Brai-Roma, 2024, p.61






















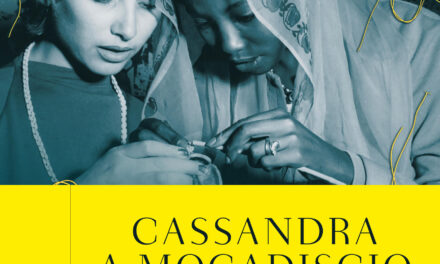
 L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore
L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino
Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio
Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa
Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa Storia passionale della guerra partigiana di Chiara Colombini
Storia passionale della guerra partigiana di Chiara Colombini Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice
Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli
Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli L’arresto degli arlecchini
L’arresto degli arlecchini