
Scarpe rotte eppur bisogna andar. Una storia della Resistenza in 30 oggetti, a cura di P. E. Boccalatte e M. Carrattieri
La copertina del volume.
Immagine tratta dal sito dell’editore.
P. E. Boccalatte e M. Carrattieri
Scarpe rotte eppur bisogna andar. Una storia della Resistenza in 30 oggetti
Biblion, Milano 2024, pp. 172
Trenta oggetti bastano per raccontare la storia della Resistenza senza semplificare e mettendone in evidenza la complessità. Lo dimostrano Paola E. Boccalatte e Mirco Carrattieri che hanno curato il volume Scarpe rotte eppur bisogna andar. Una storia della Resistenza in 30 oggetti. Hanno chiamato a raccolta 30 studiosi – tra storiche e storici – che si sono messi alla prova per restituire un quadro generale della guerra partigiana con aperture significative sul piano conoscitivo e interpretativo. Il volume, dunque, consta di 30 microsaggi di ricerca su oggetti, con foto in apertura, e due saggi introduttivi.
Questo link conduce alla scheda della casa editrice Biblion Edizioni dove è possibile leggere l’indice del libro, pubblicato nel 2024, e prendere visione degli oggetti e di chi li ha studiati. Riporto, a mo’ di esempio, quelli che cita Paolo Pezzino nella prefazione: la pagnotta di Ignazio Vian conservata al Museo della Liberazione di via Tasso a Roma (presente anche nella banca dati “Ultime lettere di condannati a morte e di deportati della Resistenza italiana” dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri, link) o il mappamondo appartenuto ai fratelli Cervi e ancora nella casa o il murale di una donna in bicicletta a Bologna.
Non c’è spazio per riportarli tutti. Si tratta di oggetti musealizzati – scelti per valorizzare i musei storici presenti nel territorio – perlopiù autentici, in pochi casi documentali, solo uno appartenente all’arredo urbano, provenienti da tutta Italia, precedenti, riutilizzati o fatti durante la guerra partigiana, integri o distrutti.
Un aspetto fondamentale che restituisce la lettura integrale del libro, oggetto per oggetto, è quella della guerra partigiana al plurale, combattuta da donne e uomini, con le armi e senza le armi, in libertà e in prigionia, deportati razziali e politici, vittime di stragi, italiani all’estero o stranieri in Italia, in montagna e in città, in battaglia e nelle zone libere. Una storia di resistenze.
Oggetto e museo
Interrogarsi sulle caratteristiche dell’oggetto musealizzato è il compito che si è data Paola E. Boccalatte, studiosa di museografia che ha collaborato alla progettazione di importanti percorsi espositivi come il Museo Diffuso della Resistenza di Torino e Casa Cervi di Gattatico. Nel suo saggio introduttivo – dal titolo L’occhio non vede cose ma figure di cose che significano altre cose – Boccalatte pone una serie di domande interessanti sugli oggetti musealizzati del ventesimo e del ventunesimo secolo, presenti in musei pubblici o privati, in istituti storici o in collezioni private relativi alla Resistenza, non tutti adeguatamente valorizzati: da dove provengono, dove si trovano, chi e come li conserva, quale effettivo spazio viene loro riconosciuto nei percorsi espositivi.
L’eterogeneità delle istituzioni deputate a conservare gli oggetti determina che non tutte siano in grado di inventariarli, catalogarli, tracciare le modalità di acquisizione, restaurarli e allestirli in modo adeguato. Anche la loro provenienza è varia. In alcuni casi sono stati donati insieme alle carte, in altri sono stati messi insieme da campagne di raccolta pubbliche, frutto di una relazione tra l’istituzione che vuole conservare e chi possiede gli oggetti. Boccalatte analizza campagne recenti di acquisizione di oggetti da parte di istituzioni museali che li trasformano in dispositivi di comunicazione e strumenti di partecipazione collettiva: chi possiede un oggetto comprende che fa parte di un’esperienza che può essere condivisa e che, contestualizzata da storiche e storici, può restituire meglio il senso di un’esperienza collettiva. Nel caso di oggetti contemporanei è importante il valore che la comunità attribuisce agli oggetti più che il valore patrimoniale.
Boccalatte sottolinea che in percorsi espositivi più recenti si trovano meno oggetti perché la multimedialità ha tolto spazio all’esposizione anche se in realtà non sono mai scomparsi del tutto, anzi si ravvisa un rinnovato interesse anche grazie alla Public History che insiste sul loro valore rappresentativo, di attivatore di interessi e di apertura culturale.
Le questioni poste in questo saggio si mettono a fuoco meglio quando si passa alla lettura dei microsaggi sui 30 oggetti, ognuno con un titolo eloquente. Questi chiariscono da dove provengono gli oggetti, quando sono stati versati all’istituzione che li conserva, in quale percorso espositivo sono collocati, in che condizioni sono. Cercare le risposte a queste domande è un suggerimento di metodo: si può fare analizzando i microsaggi contenuti nel volume ma anche ogni volta che ci troviamo di fronte a oggetti in percorsi espositivi.
Oggetti e storia della Resistenza
Mirco Carrattieri, storico della Resistenza e dell’età contemporanea, nel suo saggio dal titolo Materiali resistenti. Fare storia della Resistenza con e per oggetti, chiarisce come storiche e storici oggi stiano guardando con sempre maggiore attenzione all’apporto che la cultura materiale può dare alla ricerca.
Negli ultimi vent’anni sono stati pubblicati molti volumi sulla storia degli oggetti dall’età moderna a quella contemporanea e sono state definite alcune caratteristiche che li fanno entrare nel cantiere della storia, inclusi quelli sull’archeologia del contemporaneo, che mira a analizzare le tracce del paesaggio sull’ambiente.
Neil Gregor nella sua Storia del mondo in 100 oggetti (Adelphi, Milano 2012) ha messo a punto la formula “la storia di x in n oggetti” per costruire una biografia degli oggetti: molti studi e anche questo libro la riprendono. Questa implica che gli oggetti vengano trattati da tre prospettive: come fonte, come oggetto di analisi o come espediente narrativo.
Perché l’oggetto sia parlante, quindi, oltre alla contestualizzazione e quindi alla ricerca, deve esserci uno spazio per la narrazione con un surplus di immaginazione che confina, più che con il vero, con il verosimile.
Di ogni oggetto è importante definire a che cosa è servito, qual è la sua storia sociale (chi lo ha prodotto, chi lo ha distribuito o venduto, chi lo usava solitamente, la storia dei consumi) e anche il suo valore simbolico. A questo proposito Carrattieri, ma anche Boccalatte, fanno riferimento all’oggetto “semioforo”, quello che diventa il mediatore tra lo spettatore e il mondo invisibile a cui rimanda, secondo la definizione di K. Pomian.
Anche nel caso della Resistenza comincia a esserci una letteratura specifica sul tema che consente di precisare le categorie degli oggetti che riguardano la guerra partigiana: armi, logistica (gli automezzi e bicicletta), comunicazioni (telefoni da campo e radiotrasmittenti, binocoli ), guerra asimmetrica e clandestina (radio a galena, cifrari, documenti falsi, strumenti di sabotaggio), guerra ideologica (volantini, giornali, macchina da scrivere, ciclostile), insegne, divise, vestiario (giubbe, pellicciotti, copricapi: bustine, berretti, cappelli da alpini; scarponi); vita quotidiana (casolari, stalle, capanne, tende; cucine da campo, gavette, posate, borracce, cibo); tempo libero (lettere, diari, disegni).
Carrattieri spiega che ogni oggetto può essere considerato come sineddoche della Resistenza, quindi raccontarne una parte. Solo due esempi: la sedia del poligono di tiro del Martinetto di Torino rappresenta la repressione, la giubba di Carlo Suzzi la fortuna e il caso e per tutti si può trovare la corrispondenza. Precisa, inoltre che la lettura integrale consente di tracciare un bilancio della guerra partigiana: gli oggetti rivelano un contesto di scarsità e di precarietà, in diversi contesti, sociali, politici, una guerra di massa caratterizzata dalla coppia interpretativa spontaneità/organizzazione, fatta di persone di tutte le età con in testa una chiara idea di futuro.
Scarpe rotte eppur bisogna andar. Una storia della Resistenza in 30 oggetti nel contesto didattico
Il libro si colloca nella fascia utile per la formazione degli insegnanti perché offre contenuti storiografici aggiornati e apre alla didattica degli oggetti. I due saggi introduttivi non presentano riferimenti espliciti alla didattica ma sicuramente consentono al docente di acquisire una prospettiva se non nuova, almeno diversa, per progettare le sue lezioni di storia.
La didattica degli oggetti sembra essere al centro di un rinnovato interesse nelle pubblicazioni per la scuola. Nel manuale di didattica della storia Il primo libro di didattica della storia a cura di Andrea Micciché, Igor Pizzirusso, Marcello Ravveduto (Einaudi, Torino 2025), in un lungo paragrafo dedicato, si possono leggere le caratteristiche generali dell’uso degli oggetti come risorse didattiche. Antonio Brusa, che realizzava laboratori didattici già in passato, ha recentemente tradotto il libro di Joan Santacana Mestre e Nayra Llonch Molina, Fare storia con gli oggetti. Metodi e percorsi didattici per bambini e adolescenti (Roma, Carocci, 2022) in cui, oltre a una trattazione esaustiva del tema, si trova un percorso completo di schede didattiche dall’età antica a quella contemporanea. Su “Novecento.org” si possono leggere: l’articolo di Marianna Bucchioni – studiosa di archeologia del contemporaneo – Archeologia di Beppe Fenoglio. Uno scrittore partigiano raccontato attraverso i suoi oggetti, n. 17, giugno 2022 (link) e il resoconto di un’interessante esperienza didattica di Giulia Dodi, Vittorina Maestroni, Francesca Negri e Anna Scapocchin, Raccontare le rivoluzioni del Novecento attraverso gli oggetti. Un percorso didattico tra storia e educazione civica, n.22, dicembre 2024 (link) e Infine nel manuale di storia per la secondaria di secondo grado Trame del tempo (Laterza, Bari-Roma 2025, edizione rossa) di Caterina Ciccopiedi, Valentina Colombi e Carlo Greppi, ci sono due laboratori didattici per volume a cura di chi scrive.
Lavorare sugli oggetti in classe funziona sia se si utilizzano oggetti musealizzati sia se si lavora sulle riproduzioni fotografiche o digitali, sia se ci si procurano delle copie di oggetti o anche se si fanno portare oggetti a allievi e allieve. Ogni oggetto è frutto di un’evoluzione tecnica e ci dà informazioni sul suo tempo. Ci parla a patto di saperlo interrogare.
In questo senso i due saggi introduttivi del libro Scarpe rotte sono un buon punto di partenza: Boccalatte mette a fuoco il senso dell’oggetto musealizzato e riflette su cosa significa fare una raccolta partecipativa di oggetti; Carrattieri riporta la triplice prospettiva da cui è fondamentale partire: l’oggetto è un fonte, l’oggetto può essere analizzato, l’oggetto rappresenta un espediente narrativo. Proprio su questo punto è bene fare una riflessione: come si racconta un oggetto? Il libro fornisce due diversi approcci. Da quello più saggistico che parte dall’oggetto ma poi sviluppa un episodio della Resistenza, a quello che in prima persona, l’oggetto è narratore di sé stesso, ricostruisce la sua biografia e, quindi, illumina un aspetto della Resistenza. Per il primo, gli esempi sono quello della macchina da scrivere del museo della Fine della Guerra di Dongo (CO) e quello del cucchiaio di un prigioniero di guerra britannico, conservato al campo 65 di Altamura (BA); per il secondo quello del cappello di Adolfo Bartolucci, collocato nel museo di Sant’Anna di Stazzema.
Naturalmente il libro si presta sia a far lavorare le classi sui microsaggi relativi ai vari oggetti sia a prendere spunto per realizzare schede su oggetti relativi ad altri temi.
A questo link si trova un percorso didattico realizzato a partire da Scarpe rotte eppur bisogna andar, con un vademecum per fare l’analisi dell’oggetto e una proposta di attività con scheda.
Un’ultima proposta didattica è quella di realizzare, utilizzando un applicativo tipo Padlet, una mostra digitale sugli oggetti presenti nel libro. Si propone di seguire l’esempio della mostra virtuale Combattere. Verso la liberazione (link), realizzata sul percorso espositivo allestito al Polo del ‘900 di Torino per l’ottantesimo della Resistenza, da dicembre 2024 a gennaio 2025.
Questo è il link alla mostra virtuale – visitabile fin da ora ed è in corso di pubblicazione un kit che consente di lavorare sugli oggetti presenti in tale percorso (il kit si scarica dal sito del Polo del ‘900, inserendo kit e il titolo). Si precisa che questo kit segue quello del 2024 dal titolo Disobbedire. Gli Internati militari italiani, già scaricabile a questo link. Anche in questo è presente una mostra virtuale che consente varie attività sugli oggetti.
In occasione dell’ottantesimo della Resistenza e in prossimità al 25 aprile si consiglia di leggere questo libro perché propone un approccio attivo, storicamente accertato e narrativo.






















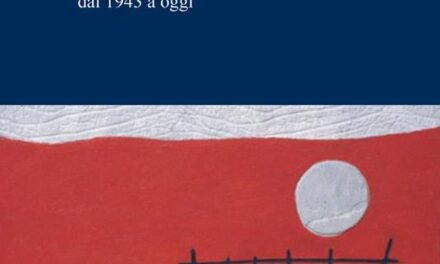

 Scarpe rotte eppur bisogna andar. Una storia della Resistenza in 30 oggetti, a cura di P. E. Boccalatte e M. Carrattieri
Scarpe rotte eppur bisogna andar. Una storia della Resistenza in 30 oggetti, a cura di P. E. Boccalatte e M. Carrattieri L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore
L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino
Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio
Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa
Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice
Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli
Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli L’arresto degli arlecchini
L’arresto degli arlecchini