
Cinema, Letteratura, Memoria: Orhan Pamuk e Il Museo dell’innocenza
Un fotogramma di Istanbul e il Museo dell’innocenza di Pamuk.
Screenshot scattato dall’autore.
Abstract
Da ostinato flaneur,[*] Orhan Pamuk ha sempre cercato e colto nella sua amata città tutto quello che si nasconde e si protegge nell’ombra: ha camminato incessantemente alla ricerca inesausta di tracce – indici – di quella Istanbul che è sua e a cui sente di appartenere. Abbiamo in particolare una trilogia, capace di farsi teoria e prassi della narrazione: le parole (un romanzo), le immagini (un film-documento), la memoria (un Museo), che ci raccontano Istanbul nella sua essenza intima, in un transitare continuo dalla dimensione dell’io a quella del noi. È una esperienza ma è anche un esperimento. Partire da sé, da un ricordo personale, per proiettarlo in un vasto orizzonte collettivo. Un romanzo, un film e un museo – dallo stesso titolo, Il Museo dell’innocenza – diventano strumenti della memoria vissuta come emozione condivisa e non solo come semplice archivio.
___________________
As a stubborn flaneur, Orhan Pamuk has always sought out and grasped in his beloved city all that is hidden and protected in the shadows: he has walked ceaselessly in search of traces – indexes – of the Istanbul that is his and to which he feels he belongs. We have in particular a trilogy, capable of becoming both theory and praxis of narration: words (a novel), images (a film-document), memory (a museum), which tell us about Istanbul in its intimate essence, in a continuous transition from the dimension of the self to that of the we. It is an experience but also an experiment. Starting from the self, from a personal memory, to project it into a vast collective horizon. A novel, a film and a museum – with the same title, The Museum of Innocence – become instruments of memory experienced as a shared emotion and not just as a simple archive.
L’immagine, la parola, il film
«– Non diventerò pittore – dissi. Diventerò scrittore, io».
Con questa dichiarazione di intenti Orhan Pamuk, premio Nobel per la Letteratura nel 2006, chiude Istanbul[1], il libro che più di ogni altro lo racconta in modo diretto nel viscerale rapporto con la propria città.[2]
Dopo aver seguito il flusso di pensieri, malinconie, riflessioni su letteratura, arte, vita il lettore può abbandonarsi a un sincero compiacimento. Bella scelta decidere di diventare scrittore. Bella scelta se il risultato è quello che adesso si ha tra le mani e sotto gli occhi.
Istanbul, che Franco Cardini[3] ha definito con decisa sintesi seduttrice, conquistatrice, sovrana, si fa viva tra le pagine del libro, complici in questo le foto di Ara Güler, il fotografo da tutti considerato «l’occhio di Istanbul», nelle quali Pamuk trova l’ideale completamento visivo alle sue parole. Il racconto della città può quindi dipanarsi utilizzando la duplice possibilità narrativa offerta dalla parola e dall’immagine.
Verrebbe da chiedersi se, da aspirante pittore quale è stato in gioventù, lo scrittore turco sarebbe riuscito a dare sostanza all’intero corpus di emozioni e di sensazioni con cui ha vissuto e vive Istanbul, e a farne racconto in grado di catturare e di emozionare.
Non è semplice curiosità, ma questione teorica che aprirebbe un ventaglio di ipotesi su cui discutere. Al centro ci sarebbero le potenzialità poetiche di pittura, immagine, parola. E chissà se la tavolozza di colori che avrebbe scelto sarebbe stata idonea a riproporre quel chiaroscuro, quel continuo sfumare di luce in buio che tanto lo affascina e che, ai suoi occhi, connota l’anima della città.
Lo ha detto tante di quelle volte che davvero Istanbul la si immagina così, impressa in un bianco e nero dai contrasti a volte sfumati e a volte decisi, sempre però carichi di un’aura misteriosa. Come la Istanbul ripresa da Alexandre Promio nella primavera del 1897 – a distanza di neppure due anni dalle prime proiezioni cinematografiche dei fratelli Lumière – con le vedute in movimento di Panorama de la Corne d’or e di Panorama des rives du Bosphore. O come la Vienna del Terzo uomo di Carol Reed con Orson Welles. Oppure come le strade e i quartieri di tanti B-movie e polizieschi d’epoca. Sovrapponibili in maniera assoluta alle strade e ai quartieri di Istanbul ripresi nel film-documento Istanbul e il Museo dell’innocenza di Pamuk.
Il Museo dell’innocenza
Frutto di una coproduzione internazionale[4] e diretto dal regista britannico Grant Gee, questo film-documento è stato presentato alla 72a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2-12 settembre 2015) nella Sezione Giornate degli Autori. Tratto dal romanzo Il museo dell’innocenza,[5] ne è un prolungamento, un’opera in sé autonoma che sceglie un punto di vista molteplice per riformulare i diversi snodi narrativi su cui è strutturato il libro. Se qui la voce narrante principale è quella di Ayla, un personaggio secondario nel libro, ad essa si unisce, nel corso del film, una pluralità di voci e di punti di vista, a cominciare da quello dello stesso Pamuk, che più volte appare in una intervista televisiva, per arrivare a quello di alcuni abitanti di Istanbul a cui si chiede di descrivere il proprio rapporto con la città. Quello che accomuna tutte queste prospettive è un vivere raccontato nei tratti dell’esperienza quotidiana a cui si aggiunge, ogni volta che nel film-documento si ricorre alla voce narrante di Ayla o alla intervista televisiva di Pamuk, un recupero memoriale di esperienze e di emozioni che si sono vissute nel corso del tempo nella città.
Si tratta di una inevitabile scelta di poetica perché, nel suo contenuto più ampio, il film-documento di Grant Gee ha voluto proporsi come un viaggio dentro il rapporto tra lo scrittore premio Nobel e i luoghi della città che più hanno incrociato la sua vita: i quartieri di Beyoğlu, Nişantaşı, Teşvikiye, Beşiktaş; la bellezza del Bosforo «che scorreva fuori dal finestrino»[6] durante le passeggiate della famiglia Pamuk a bordo della Chevrolet del ’56; il cinema Saray, luogo della formazione dell’immaginario cinematografico che completa quello artistico e narrativo dello scrittore; e poi piazza Taksim, sempre e comunque punto d’origine di ogni testimonianza delle maree storiche che si sono abbattute sulla città, dal colpo di Stato del 27 maggio 1960 all’ultimatum militare del 12 marzo 1971, dal nuovo colpo di Stato del 12 settembre 1980[7] al fallito golpe del 15 luglio 2016 e alla reazione che ne è seguita,[8] a ogni altro tipo di manifestazione collettiva, sia essa politica o culturale o artistica.[9]
Luoghi e segni del passato
Sono ancora i luoghi che conservano i segni di un passato le cui tracce sembrano sbriciolarsi come i vecchi palazzi in legno della Istanbul ottomana. Allora riandare con la memoria alla intensa e particolare storia d’amore tra Kemal e Füsun, che è il tema narrativo principale del romanzo, significa per questo film-documentario dare corpo a un progetto capace di recuperare una vicenda che da personale riesce a diventare, nel corso della narrazione, collettiva.
In questo senso il film-documento di Gee si pone come tentativo di recuperare l’ampia scelta poetica che caratterizza buona parte dell’opera dello scrittore turco e non solo il romanzo Il museo dell’innocenza: transitare continuamente dalla dimensione dell’io a quella del noi. Partire da sé, da un ricordo personale, per proiettarlo in un vasto orizzonte collettivo di cui Istanbul è un teatro condiviso racconta una esperienza, ma si pone anche come un esperimento.
Alle anime notturne e solitarie che nell’opera del regista britannico percorrono i luoghi della città si dà il compito di raccontarla attraverso le proprie emozioni o attraverso i propri ricordi. Un taxista confessa la sua predilezione per la tranquillità della città notturna rispetto a quella diurna. Uno straccivendolo racconta il suo disagio di viverla alla luce del giorno, perché è esperienza quotidiana per lui incrociare chi lo guarda con supponenza dall’alto in basso. Preferisce allora la notte ed è in quell’atmosfera ovattata che ha modo di conoscere tutti quelli che deve conoscere, per sentirsi finalmente uno tra gli altri. La grande attrice cinematografica Turkan Şoray ritorna, a bordo di un taxi, in tutte le strade e le piazze dove sono stati girati i film in cui ha recitato, e i suoi ricordi ora testimoniano quella città e quel tempo; testimoniano un cinema che è rimasto legato, nei ricordi di chi è stato ragazzino o adolescente negli anni Sessanta del secolo scorso, alle selezionate immagini in bianco e nero di baci rubati così simili a quelli montati da Giuseppe Tornatore nella sequenza finale di Nuovo Cinema Paradiso.
Nel suo film-documento Grant Gee utilizza queste immagini come memoria innocente[10] e malinconica capace di riproporre, allo spettatore, la sensazione che il lettore del romanzo prova in molte pagine: l’importanza che lo spazio cinematografico (nella duplice accezione di sala cinematografica e di film) ha avuto per la formazione di un immaginario collettivo del quale fa parte anche la propria formazione individuale. Tutte queste persone, in Pamuk e il Museo dell’innocenza, percorrono le stesse strade in cui si avventura anche lo scrittore, di notte, seguito a pochi passi di distanza dalla sua guardia del corpo. Da ostinato flaneur ha sempre cercato e colto nella sua amata città tutto quello che si nasconde e si protegge nell’ombra, in quel chiaroscuro delle incipienti sere d’inverno, per esempio, «quando la notte scende ad ammantare di poesia i quartieri periferici deserti e i pallidi lampioni».[11] Lo ha fatto sempre così, camminando incessantemente alla ricerca inesausta di quelle tracce – indici – ancora persistenti in una Istanbul che inevitabilmente cambia. Quando capita di imbattervisi è come ritrovare memoria di sé perché, dice Pamuk all’intervistatore, «tutto si trasforma in un segno che rimanda al nostro passato».
Il vagare solitario dello scrittore è simile a quello di Kemal che, nel romanzo Il Museo dell’innocenza, va alla continua ricerca della sua Füsun, credendo ogni volta di incontrarla in qualunque altra immagine di donna, a un angolo di strada, sul marciapiede opposto, davanti alla vetrina di un negozio… E ancora, è simile all’infaticabile camminatore Mevlut Karataş, il protagonista del romanzo La stranezza che ho nella testa che, pur sperimentando mille lavori nella sua vita, «non smise mai di vendere boza, sera dopo sera, per le strade di Istanbul. E non smise mai di abbandonarsi a bizzarre fantasie».[12]
Sono tutti personaggi epigoni – nei quali Pamuk stesso si identifica – di Jean-Jacques Rousseau che non era capace di meditare se non camminando, ogni volta che si fermava non riusciva più a pensare, perché la testa gli funzionava soltanto con i piedi in movimento.[13]
La città. Il museo
E, infine, sono le stesse strade a cui va incontro l’occhio della steadycam che, grazie ai fluidi movimenti di cui è capace, permette riprese in soggettiva che di fatto accompagnano lo sguardo dello spettatore dentro la città. La particolarità di questo film-documento, la sua scelta estetica più importante, è aver collocato tale prospettiva soggettiva in un percorso da un dentro a un fuori nel quale ci si muove sempre in uno spazio connotato dalla medesima tonalità del chiaroscuro. È la stessa tonalità che avvolge pure le stanze del Museo dell’innocenza che, per felice intuizione di Pamuk, ha preso vita in una via del quartiere di Çukurcuma, proprio nella stessa casa in cui ha abitato la Füsun del romanzo e dove per anni Kemal si è recato a vivere il suo amore in maniera mediata dalla riflessione su ciò che era stato e su ciò che poteva tornare a essere quando finalmente Füsun avrebbe lasciato Feridun, l’uomo che nel frattempo ha sposato e con il quale crede o spera di condividere l’ambizioso progetto di una carriera nel cinema.
Il ricordo e il desiderio d’amore di Kemal sono alimentati, lungo i nove anni in cui ha continuato a frequentare la casa di Füsun, da un reiterato quanto innocente piccolo furto. Da queste sue visite Kemal porta via con sé ogni volta qualcosa: mozziconi di sigarette fumate da lei; piccoli soprammobili; oggetti d’uso quotidiano. Tutte cose che la giovane donna ha toccato, sfiorato, guardato e su cui ha lasciato impresso qualcosa di suo che continua a vivere altrove: il caldo delle labbra, il soffio di un respiro, l’impronta delle dita. Oggetti che stimolano un’esperienza amorosa indiretta, traslata nel tempo e nello spazio grazie alla rievocazione di un bagaglio di sensazioni tattili, emotive, erotiche un tempo esperite in maniera diretta.
Tutti quegli oggetti che hanno attraversato i giorni, la vita, i desideri di Kemal sono poi ritornati nella casa diventata, nel romanzo di Orhan Pamuk, il museo creato da Kemal con lo scopo di ricordare il suo amore per Füsun. Oggi – e nella concretezza della realtà – quegli oggetti sono nel Museo dell’innocenza, quello vero, quello che Pamuk ha riportato dalle pagine del suo libro in una strada di Çukurcuma, oggi visitabile.
Lo spazio geometrico tra esperienza individuale e collettiva
Ogni volta che ha parlato del suo progetto di creare un Museo, Pamuk ha sempre sottolineato la sua predilezione per i piccoli musei portatori di un significato particolare che va oltre l’importanza e il significato dei capolavori invece conservati nei grandi musei. Cita spesso, a tal proposito, il Museo Bagatti Valsecchi di Milano e, nel film-documento che interessa più da vicino il suo progetto del Museo dell’innocenza, quello di Edith Piaf a Parigi, perché non è solo il luogo che raccoglie la memoria del passaggio in questa vita della celebre cantautrice, ma è anche testimonianza della vita parigina degli anni Cinquanta.[14]
Quello che è molto interessante rispetto a questa concezione di museo riguarda il rapporto tra narrare una storia e costruire un edificio. In qualche modo Pamuk cerca di dare ragione – letteraria ma non teorica – del suo desiderio di dare vita a un museo che non fosse vissuto come una semplice, altra attrazione culturale di Istanbul ma che creasse un rapporto senza soluzione di continuità tra romanzo e Museo:
Volevo scrivere un romanzo che avesse la stessa forma degli oggetti in un museo. Così che, percorrendo le stanze del museo, si potessero osservare gli articoli esposti e ricordare il romanzo. E volevo che i lettori avessero la possibilità di vedere gli stessi oggetti che i personaggi utilizzavano nel romanzo.. C’è chi ha letto il romanzo e sa che esiste un museo che contiene tutti gli oggetti raccontati nel libro. E c’è chi visita il museo e scopre che esiste un romanzo che parla degli oggetti esposti. Qualcuno penserà che si tratti di un paradosso alla Borges, ma la metà dei visitatori non ha letto il romanzo.[15]
Più che un paradosso alla Borges, sembra in realtà una ipotesi azzardata. Eppure, il filosofo francese Paul Ricoeur, che nella sua opera ha indagato con impegno pervicace il rapporto tra tempo e racconto fino ad arrivare all’affascinante ipotesi di una «rifigurazione dell’esperienza temporale» capace di rendere attuabile l’esperienza di un «tempo raccontato»[16] ha scritto pagine interessanti anche sulla possibilità di un legame tra narratività e atto architettonico.[17] Proprio a queste pagine bisogna far riferimento se si vuole cogliere appieno l’originalità del progetto di Pamuk.
In La memoria, la storia, l’oblio Ricoeur affronta, tra le altre, questioni che riguardano la memoria personale e quella collettiva, e aspetti inerenti a quella che lui definisce «fase documentaria», di cui la cosiddetta memoria archiviata dovrebbe essere una importante derivazione.[18] All’interno del capitolo dedicato a quest’ultimo aspetto, affronta il tema dello spazio abitato e del tempo storico. Come si vede sono argomenti che, declinati in prospettiva di poetica narrativa, sostanziano l’opera di Pamuk e, per processo di partenogenesi, il film-documento che Grant Gee ha fatto derivare dal romanzo.
Nel rapporto esistente tra spazio vissuto dal soggetto e spazio pubblico si intercala, sostiene Ricoeur, lo spazio geometrico.[19] Questo porta il filosofo a dover ricorrere a un altro paio di tesi. La prima sostiene che «l’atto di abitare si situa ai confini dello spazio vissuto e dello spazio geometrico»;[20] la seconda, che naturalmente è connessa con la prima, afferma che «l’atto di abitare può essere preso in considerazione soltanto a partire dall’atto di costruire».[21] La cosa si fa ulteriormente interessante quando propone il concetto «tempo della storia» come un terzo spazio nella correlazione tra abitare e costruire. Detto in maniera più immediata, tra il luogo costruito e il luogo abitato c’è il tempo della Storia: le date del calendario, dice Ricoeur;[22] le date della vita, potrebbe dire il lettore del romanzo di Pamuk, o il visitatore del Museo, o lo spettatore del film di Grant Gee. Sembra di essere avvolti in una spirale narrativa.
Nell’atto del costruire Ricoeur rintraccia un’operazione simile a quella del raccontare – costruire un intreccio – che crea un rapporto ancora più intimo tra narratività e architettura. Una città (il luogo costruito) racconta storie e lo fa perché mette a confronto epoche differenti, che offrono allo sguardo una storia (il tempo raccontato) sedimentata dai gusti e dalle forme culturali. Dice: «la città si dà a vedere e a leggere, a un tempo».[23] Come un film, come un romanzo, verrebbe da dire. Opera architettonicamente multiforme, multipla e complessa, una città per il filosofo «suscita passioni più complesse che non la casa, nella misura in cui offre uno spazio di spostamento, di avvicinamento e di allontanamento».[24]
Il Museo pensato, progettato, costruito da Pamuk in quella che una volta era la casa di Füsun a Çukurcuma dimostra però anche altro.
Una spirale narrativa
Il percorso tra vita, libro, museo e film si struttura come una specie di spirale nella quale vengono attratti desideri, immagini, storie individuali, la città. Perfino le funzioni narrative sembrano avere statuto incerto. Giunti alla fine del romanzo il lettore crede di aver finalmente colto a chi appartenga la voce narrante che lo ha accompagnato durante tutta la lettura. E non gli importa più se a volte ha confuso Kemal con Pamuk, o se finalmente ha capito che Kemal racconta la sua storia d’amore a Pamuk che, scrivendo, ridà corpo e sostanza concreta a quella storia, restituendola letteralmente al mondo in forma di romanzo.
Durante la visione del film-documento lo spettatore si lascia catturare da un’altra voce narrante, quella di Ayla, l’amica di Füsun che ha raccontato a Pamuk della stessa Füsun, così che lo scrittore potesse conoscerla meglio. E il visitatore, sia che abbia o non abbia letto il romanzo o visto il film, nel Museo è a sua volta fisicamente attratto in questa spirale. Per lui il romanzo, Füsun, Kemal, le foto di Ara Güler, gli oggetti che hanno fatto la vita della città e dei due innamorati nel corso di quegli anni, sono fruibili solo salendo con lentezza e attenzione le scale, e poi scendendo ripercorrendo di nuovo e a ritroso i piani, le stanze, le cose che riempiono questa casa diventata Museo.
Accade che in questa spirale – dice lo scrittore al suo intervistatore nel film, citando addirittura Aristotele – il Tempo riesca a farsi Luogo e permettere così, al visitatore del Museo dell’innocenza, di percorrere entrambe queste dimensioni. Ma tutto ciò potrebbe sembrare solamente la tipica esperienza dell’andare per musei. Non qui, però, dove si sperimenta un fuori che scivola in un dentro, quasi senza soluzione di continuità. E viceversa. In un continuo percorso di andata e ritorno. Entrare nel Museo non è abbandonare la città e le sue storie ma è riviverne, attraverso la memoria e i ricordi personali, il carattere e la specificità che ne hanno fatto, nel tempo, la Storia. I molti oggetti di vita quotidiana che nel corso degli anni lo scrittore ha raccolto con la passione di un collezionista, raccontano anche i giorni e la vita di Istanbul a partire almeno dagli anni Cinquanta, e dei suoi abitanti (Pamuk tra questi) che nel corso dei decenni l’hanno vista e vissuta così come il Museo adesso la propone allo sguardo del visitatore.
Uscire dal Museo per ritornare nella città significa adesso percorrerla con una più completa conoscenza che è capace di condensare in un unicum ricordi personali e ricordi collettivi. Riviverli in una esperienza carica di ulteriore emozione. Perché il Museo dell’innocenza non conserva le fonti di un sapere specialistico o le testimonianze di un passato che ormai possiamo definire semplicemente Storia, ma è il prolungamento, attraverso il tempo, di una quotidianità in cui è facile riconoscersi. L’esperienza tangibile di un allora ancora presente, poiché nelle sue stanze si ritrovano le tracce di un tempo della città che è, ovviamente, anche il tempo di chi in questa città ha vissuto. La memoria pensata e vissuta come emozione, appunto, e non solo come archivio.
Una fotografia in bianco e nero
Il luogo teorico capace di dare sostanza a questa particolare forma di reviviscenza è nella sintesi che Jean-Jacques Wunenburger opera rispetto agli studi di Jacques Delay e di Henry Bergson, giungendo alla conclusione che la memoria sociale (o memoria-ricordo) implica necessariamente il riconoscimento del passato sotto forma di ricordo. Cioè a dire, con parole che Wunenburger riprende da Delay, è inseparabile da una sintesi mentale consistente in un confronto del ricordo attuale con l’io attuale e insieme con l’io del passato. Una pratica, ricorda Wunenburger, evidente nelle opere di carattere autobiografico e che implica «una selezione globale dei dati, l’assunzione di contesti, di quadri sociali del tempo» e dunque, cosa che nella proposta interpretativa che qui si sta cercando di costruire interessa in maniera più specifica, «l’attribuzione di valori affettivi e di un senso riflessivo».[25]
Tra memoria collettiva e ricordo personale si struttura di fatto una interdipendenza da cui è impossibile prescindere. E lo strumento principe di cui la memoria si serve, in questa duplice accezione individuale e collettiva che è elemento fondante della poetica di Pamuk, è il Museo, contenitore capace di inglobare nelle medesime esperienze che contiene chi ha l’occasione o il desiderio di imbattervisi come lettore del romanzo, come spettatore del film e, ovviamente, come visitatore del museo.
In questo il Museo dell’innocenza rivela almeno una triplice funzionalità: raccoglie gli oggetti che nel romanzo hanno scandito con la loro presenza un itinerario d’amore particolarissimo e dunque del tutto individuale; accumula le tracce del suo attraversare il proprio tempo (si intende il tempo individuale della vita e il tempo della città, che è inevitabilmente tempo di un’intera comunità); e, infine, individua il percorso della Memoria, che è di tutti e di ognuno. Significa probabilmente fare i conti con quella relazione tra identità e ricordi che ci impone, ogni volta che cerchiamo di definire noi stessi, di porci due quesiti e non più uno soltanto. Al quesito tradizionale «Chi sono io?» se ne aggiunge di necessità un altro: «Chi siamo noi?».[26] La duplice risposta che ha comunque un carattere unificante tra il sentire dell’“io” e quello del “noi” è, ancora e di nuovo, nel bianco e nero delle foto di Ara Güler, l’uomo con la macchina fotografica, così come Dziga Vertov era stato l’uomo con la macchina da presa, ostinatamente impegnato a guardare, cogliere, scovare volti, angoli, gesti, momenti e fissarli una volta per sempre in una immagine, in migliaia di immagini nelle quali Pamuk ritrova la Istanbul che è stata e, insieme a quella città, ritrova la memoria visiva della sua infanzia: «era una fotografia in bianco e nero, un mondo semibuio e grigio».[27]
Distensio animi
Se il disegno e la pittura hanno rappresentato i primi tentativi di cogliere e fissare scorci della città e le emozioni che questi richiamavano, la fotografia ha rappresentato per Pamuk la prima esperienza di sguardo posato sul passato. Quello che in particolare lo ha catturato, nei suoi infantili passaggi da una stanza all’altra di una casa che non esita a definire una casa-museo buia,[28] è stato incontrare la fotografia, e percepirla già da subito in una sorta di suo statuto ontologico: «Ogni sguardo alle fotografie mi insegnava l’importanza della vita che si viveva, e soprattutto alcuni momenti sottratti alla vita stessa, protetti contro il tempo e fissati in una cornice».[29]
Sembra quasi l’interpretazione e nello stesso tempo la piena adesione a quella intuizione che ha permesso a Roland Barthes di scrivere che il referente fotografico non è la cosa facoltativamente reale a cui rimanda un’immagine o un segno, bensì «la cosa necessariamente reale che è stata posta dinanzi all’obbiettivo».[30] Ecco forse spiegate con netto anticipo le ragioni della scelta futura dello scrittore. Aver sperimentato negli anni della sua formazione artistica che la pittura è capace di simulare la realtà anche senza averla vista non poteva – non può – bastare a Pamuk che nelle persone, nei panorami, nelle strade, negli angoli della città colti dal proprio sguardo vive sempre un’emozione che lo cattura sorprendendolo e di cui poi, nel corso del tempo, va alla continua ricerca. Per questo, prima di fronte alle fotografie del mondo della sua infanzia privata (quelle, incorniciate, della casa-museo buia) e poi di fronte alle fotografie che colgono la memoria collettiva e perciò condivisa della città (le foto di Güler), lo scrittore probabilmente sperimenta, facendola sua, la netta conclusione teorica di Barthes: nella fotografia vi è una doppia posizione congiunta di realtà e di passato. Un fatto, un luogo, un volto colti nel tempo. E questo porta alla dimensione propria del narrare di Pamuk: fare i conti con tutto ciò che si vive come legato in maniera indissolubile non solo ai luoghi e alle emozioni, ma anche ai momenti. Entrano quindi in gioco, di nuovo, lo spazio e il tempo, colti entrambi nella loro concretezza, perché entrambi sperimentati e vissuti. La questione fondamentale che si è sempre posta all’autore è stata come riuscire a raccontarli. Questione che ha trovato la propria strada proprio quando, messi da parte disegno e pittura come opzioni artistiche principali, si è dedicato alla scrittura.[31]
Il passaggio non intacca in nulla gli elementi di poetica, ma tocca questioni importanti dal punto di vista estetico. L’immagine vista e riprodotta con gesto tecnico e tutto soggettivo, capace di fissare in un tratto di pennarello o in un connubio di colori e prospettive una emozione, diventa a un certo punto racconto di parole. Le immagini che riaffiorano alla memoria sono le stesse, quelle dell’infanzia e quelle della città di allora, ma si cerca adesso di dare corpo al corso stesso degli eventi e del tempo. È allora possibile che la scrittura, più della pittura e del disegno, sia capace di giustificare l’agostiniana proposta teorica della distensio animi con la quale forse si trova risposta al problematico interrogativo: cos’è il tempo e come coglierne il passaggio?
Una questione di realismo
Si profila dunque una particolare opzione teorica per cui le esperienze della memoria e del ricordo, che tendono a recuperare proprio quanto sperimentato e quanto vissuto a livello individuale e a livello collettivo, hanno bisogno di poggiare su una particolare idea di realismo per riuscire a farsi racconto. E le ipotesi teoriche per poter definire questa particolare idea di realismo devono fare i conti, almeno inizialmente, con l’esperienza della soggettività. Ancora una volta ci viene incontro sant’Agostino che, nelle Confessioni, chiarisce bene il rapporto esistente tra ricordo, immagine del passato e parola affermando:
Nel narrare fatti veri del passato, non si estrae già dalla memoria la realtà dei fatti, che sono passati, ma le parole generate dalle loro immagini, quasi orma da essi impresse nel nostro animo mediante i sensi al loro passaggio.[32]
La questione diventa qui fondamentale perché è la parola a diventare fulcro centrale della narrazione. Succede che sono le immagini stesse a generare le parole capaci di farsi racconto del bagaglio di esperienza sensoriale, pronta a riproporsi come emozione. Che poi è ciò che lo scrittore riesce a estrarre dalla memoria e a rendere esperienza di conoscenza e occasione di condivisione con i suoi lettori.
Riveste addirittura i caratteri della fascinazione quanto accade in una sequenza del film-documento di Gee. La steadycam si avvicina lenta e fluida a una finestra per cogliere un’immagine che proviene dall’interno di una casa. Un’immagine che in questo caso l’occhio dello spettatore sperimenta come indiretta, perché non è più l’immagine vissuta attraversando la città, ma è un’immagine televisiva che gli viene incontro invitandolo ad avvicinarsi. Pamuk racconta qualcosa all’intervistatore che gli pone questioni che riguardano il suo rapporto di scrittore con la città, anzi, per la precisione, di scrittore della città. L’immagine, ora ferma, conserva il suo statuto di immagine in soggettiva. Lo spettatore, che fino a un secondo prima percorreva una strada buia di Istanbul, ora guarda un’immagine di secondo livello. Nel suo colloquio con l’intervistatore Pamuk fa riferimento all’esperienza del camminatore, condizionato dal pensiero di Rousseau e di fatto, magari del tutto inconsciamente, ripropone la teoria agostiniana che spiega il tempo come distensio animi, facendola diventare normale esperienza quotidiana a cui, però, si assegna un’ipotesi conoscitiva del Tempo: «quando camminiamo per la città ci imbattiamo nei segni del nostro passato e ci sembra di attraversare il passato, il presente e il futuro».[33]
La città diventa quindi luogo in cui è possibile esperire il tempo letteralmente, attraversandolo nelle sue tre dimensioni agostiniane: il passato come memoria persistente, il presente come esperienza, il futuro come tensione irrisolta verso la conoscenza impossibile di ciò che sarà. Tutto questo significa, dunque, vivere l’essenza della città, quella a cui Pamuk ha dato concretezza nella sua trilogia su Istanbul.[34] Il Tempo si coglie proprio attraverso l’esperienza di un luogo.
Il realismo è quindi inteso come possibilità di recuperare non l’effettiva esperienza del passato ma, come suggerisce Gilles Deleuze, «il vecchio presente che il passato “è stato”». In sostanza si tratta di quell’immagine attualizzata o in via di attualizzazione che si può definire «immagine-ricordo».[35] Si entra così in una particolarissima dimensione soggettiva. Un’immagine richiama un luogo, un volto, una situazione del passato che diventa particolare esperienza soggettiva.
Duplice orizzonte
Questa duplicità di orizzonte, declinata in termini di individuale e collettivo, è inevitabile se si pensa alla duplice ossessione inseguita dalla storia della Turchia moderna: preservare la propria millenaria identità e, nello stesso tempo, abbracciarne un’altra capace di percorrere le strade della modernità. Semplificando si potrebbe dire che questo duplice orizzonte rappresenta la proiezione di un passato che una storiografia ormai datata a volte ha considerato come appartenente a due mondi lontani e inconciliabili, che sempre si sono inseguiti, a volte toccati, spesso sfuggiti, quando non dichiaratamente combattuti. In tutti quei modi che le maree della Storia, di volta in volta hanno portato a riva. In passato Oriente e Occidente sono stati i termini più di tutti gli altri utilizzati per riferirsi, privilegiandone i caratteri di diversità e di opposizione, a luoghi, modi di vivere, cultura di questo universo che è al centro della narrazione che Pamuk ha fatto di Istanbul.
È stata però una semplificazione a cui una nuova storiografia tende oggi a porre rimedio.[36] La semplificazione non sempre ha dato modo di cogliere il carattere di una città che, nell’aver attraversato il suo passato millenario per arrivare fin qui, ha sempre dovuto cambiare qualcosa di sé, ma senza mai rinunciare a nulla della sua essenza. Conservando ogni traccia – memoria – di ciò che è stata: Bisanzio, Costantinopoli, Nuova Roma, La mela rossa, di nuovo e sempre Costantinopoli, Istanbul.[37]
Quanto queste maree della Storia che si sono abbattute su Istanbul abbiano inciso, nel modo d’essere e di percepirsi di un singolo individuo e di un’intera collettività è, come fin qui visto, il nucleo narrativo dell’intera opera di Pamuk. Il che può sollecitare una interessante questione su quanto egli sia uno scrittore di romanzi storici e quale sia la sua vera cifra di romanziere “storico”.[38] La questione è affascinante al di là di ogni opzione di teoria interpretativa scelta. E lo è perché nel sentimento della Storia che circola nelle sue pagine c’è una quota di afflato sentimentale che un po’ disorienta: perché non è facile inseguire e raggiungere la perfetta simbiosi tra un individuo con la sua storia personale e una città con la sua Storia.
Se si guarda con gli occhi del cuore, oltre che con la prospettiva della interpretazione prettamente storica dei fatti (la quale, peraltro e giustamente, ha sempre difficoltà a essere oggettiva), si comprende di essere di fronte a una eredità senza eguali. E che l’esperienza umana di questa eredità è in quel sentimento che la lingua turca esprime con la parola hüzün. Un po’ tristezza, un po’ malinconia e un po’ entrambe. Uno stato d’animo interiorizzato con orgoglio e condiviso da tutta la comunità, come Pamuk indica ogni volta che ne ha l’occasione, in dibattiti, interviste, libri e ora anche nel film-documento di Gee. Anzi, a voler essere precisi, nel film egli va ancora oltre, entrando in una dimensione di profonda intimità. Anche questa di ognuno e di tutti:
Ho scritto che è questa la sensazione più forte che la città emana. Ma c’è anche un aspetto filosofico dell’hüzün, la malinconia turca. Hüzün è anche una sorta di introversione, un’esortazione a guardarsi bene dal voler diventare ricchi o di successo. La filosofia dell’hüzün ci vieta di ambire al successo, ci proibisce di sposare le donne di cui siamo innamorati. Non possiamo permetterci di fare queste cose. Non possiamo volerci realizzare. Dobbiamo ritirarci in noi stessi e trovare un modo per non essere speciali o originali. Dobbiamo essere come tutti gli altri. Questa è la filosofia dell’hüzün.[39]
Considerazione importante perché svela l’esperienza sulla quale Pamuk costruisce la sua intera opera, narrativa e saggistica, di cui il film-documento di Grant Gee è uno scrigno di emozioni, capace come è di riproporre in immagini la sintesi operata dallo scrittore già in una delle prime pagine di Istanbul: «Questo mio legame con Istanbul significa che il destino di una città può diventare il carattere di una persona».[40]
Note:
* Flâneur è un termine francese, reso celebre dal poeta Charles Baudelaire, che indica l’uomo che vaga oziosamente per le vie cittadine, senza fretta, sperimentando e provando emozioni nell’osservare il paesaggio
[1] O. Pamuk, Istanbul. I ricordi e la città, trad. it. di Şemsa Gezgin, Einaudi, Torino 2006 (2003), p. 361.
[2] L’Accademia di Svezia ha così motivato l’assegnazione del Premio Nobel a Orhan Pamuk: «who in the quest for the melancholic soul of his native city has discovered new symbols for the clash and interlacing of cultures» («che nella ricerca dell’anima malinconica della sua città natale ha scoperto nuovi simboli per lo scontro e l’intreccio delle culture»).
[3] F. Cardini, Istanbul. Seduttrice, conquistatrice, sovrana, il Mulino, Bologna 2014.
[4] Hot Property Films in coproduzione con Illuminations Films, Venom, In Between Art Film e Vivo film-In associazione con Finite Films, BFI e Bord Scannánnahéireann/The Irish Film Board e ARTE France-La Lucarne. Nelle sale italiane il film è stato proiettato nei giorni 7-8 giungo 2016. Attualmente è disponibile in versione DVD e Blu-ray e sulla piattaforma Prime Video previo abbonamento a Nexo+. Per tutte le citazioni del film utilizzate in questo lavoro, si fa riferimento alla versione disponibile su Prime Video.
[5] O. Pamuk, Il museo dell’innocenza, trad. it. di Barbara La Rosa Salim, Einaudi, Torino 2009 (2008). Per le citazioni riportate in questo saggio, cfr. l’edizione del 2015.
[6] Pamuk, 2009, p. 95.
[7] Si rimanda alla lettura di E. J. Zürcher, Porta d’Oriente. Storia della Turchia dal Settecento a oggi, trad. it. di Stefania Micheli e Andrea Piccoli, Donzelli editore, Roma 2016 (1993), in particolare i capitoli XIV. La seconda Repubblica turca, 1960-80 (pp. 295-341) e XV. Lo Stato di Kenan Evrer e l’economia di Turgut Özal, pp. 341-382.
[8] Si veda il n. 10 del 2016 della rivista di Geopolitica «Limes», La Turchia secondo Erdoğan. Golpe fallito e controgolpe riuscito.
[9] Cfr.L’intervista con Edip Başer a cura di Yasemin Taşkin, ‘In piazza Taksim Atatürk è risorto. Parola di generale’, in I figli del Sultano. L’onda di piazza Taksim spacca la Turchia. Fine del modello Erdoğan?, in “Limes”, n. 6, 2016 pp. 267 – 278.
[10] Da notare che il titolo originale del film-documento di Grant Gee è proprio Innocence of Memories.
[11] Pamuk, 2006, p. 36.
[12] O. Pamuk, La stranezza che ho nella testa, trad. it di Barbara La Rosa Salim, Einaudi, Torino 2017 (2013), p. 7.
[13] J..J. Rousseau, Le confessioni, trad. it. di Valentina Valente, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 2000 (1781-1788), p. 486. È lo stesso Pamuk a citare a tal proposito Rousseau nella intervista televisiva che viene riproposta nel film-documento di Grant Gee, Istanbul e il Museo dell’innocenza di Pamuk, al minuto 0:40:35.
[14] Per il primo aspetto è utile la visione di Il museo e la città. Orhan Pamuk ne parla con Salvatore Settis: https://www.youtube.com/watch?v=AvO6ZlTWV_o&list=WL&index=40&t=1023s. Per il riferimento al museo dedicato a Edith Piaf, Pamuk ne parla nel film-documento di Grant Gee, cit., al minuto 0:11:53.
[15] Gee, minuti 0:09:57 – 0:11:16.
[16] Rimangono ancora di fondamentale importanza i tre volumi che Paul Ricoeur ha dedicato all’argomento e che sono stati pubblicati in Italia da Jaca Book nella traduzione di Giuseppe Grampa: Tempo e racconto, 1994 (1983); La configurazione nel racconto di finzione, 1994 (1984); Il tempo raccontato, 2007 (1985).
[17] P. Ricoeur, La memoria, la storia, l’oblio, trad. it. di Daniella Iannotta, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2003 (2000).
[18] Cfr. Ricoeur, 2003, il capitolo intitolato proprio Fase documentaria: la memoria archiviata (pp. 205-257).
[19] Ricoeur, 2003, p. 210.
[20] Ricoeur, 2003, p. 210.
[21] Ricoeur, 2003, p. 210.
[22] Ricoeur, 2003, p. 210.
[23] Ricoeur, 2003, p. 211.
[24] Ricoeur, 2003, p. 211.
[25] J. J. Wunenburger, Filosofia delle immagini, trad. it di Sergio Arecco, Einaudi, Torino 1999 (1997), p. 45.
[26] A. Assman, Ricordare. Forme e mutamenti della memoria culturale, trad. it. di Simona Paparelli, Bologna, il Mulino, 2002 (1999), soprattutto il Capitolo terzo: Il conflitto dei ricordi nei drammi storici di Shakespeare, pp. 67 e ss.
[27] Pamuk, 2006, p. 35.
[28] È una preveggenza che ha un suo fascino, se si pensa a quello che poi ha significato Il museo dell’innocenza nella sua duplice opzione di romanzo e di film-documento.
[29] Pamuk, 2009, p. 14.
[30] R. Barthes, La camera chiara. Note sulla fotografia, trad. it. di Renzo Guidieri, Einaudi, Torino 2003 (1980), pp. 77-78.
[31] Riveste, a questo proposito, un interesse particolare la lettura del recentissimo Ricordi di montagne lontane, trad. it. di Margherita Botto, Einaudi, Torino 2023, un’opera in cui testo e immaginesi completano vicendevolmente e che quindi rappresenta per Pamuk una specie di ritorno alle origini, con in più, ovviamente, l’esperienza della scrittura: «Fra i sette e i ventidue anni ho creduto che sarei stato un pittore. A ventidue anni il pittore in me è morto e ho cominciato a scrivere romanzi. Nel 2008 sono entrato in un negozio per uscirne con due sacchetti pieni di matite e pennelli, poi ho cominciato a disegnare su piccoli taccuini, fra il piacere e il timore. Sì, il pittore in me non era morto».
[32] Sant’Agostino, Le confessioni, traduzione dal Latino di Carlo Carena, cito dall’edizione eBook della Edizioni Crescere, Vedano Olona (Va) 2016.
[33] Orhan Pamuk nella intervista riprodotta nel film-documento Istanbul e il Museo dell’innocenza di Pamuk, al minuto 0:40:17.
[34] Poiché Istanbul. I ricordi e la città è un itinerario autobiografico non romanzesco del suo rapporto con la città, ai veri romanzi che hanno Istanbul come sfondo e teatro delle vicende narrate, Il museo dell’innocenza e La stranezza che ho nella testa, bisogna aggiungere il precedente Il libro nero del 1994, pubblicato per la prima volta in Italia nel 2007 da Einaudi nella traduzione di Şemsa Gezgin. In Turchia i tre romanzi sono ora ripubblicati in volume unico, con il titolo Üç İstanbul Romani dalla casa editrice Yapı Kredi Yayınları di Istanbul.
[35] G. Deleuze, L’immagine-tempo. Cinema 2, trad. it. di Liliana Rampello, Ubulibri, Milano 1989 (1985), p. 67.
[36] In particolare è utile la lettura del recentissimo libro di M. D. Baer, Gli ottomani. Khan, cesari e califfi, trad. it. di Valerio Pietrangelo, Einaudi, Torino 2023 (2021), in cui, tra l’altro, per spiegare come possa essere messa in discussione la tradizionale opinione di un Oriente e un Occidente diversi e irriducibili tra loro anche storicamente e culturalmente, ricorre proprio a un romanzo di O. Pamuk, Il castello bianco, trad. it. di Giampiero Bellingeri, Einaudi, Torino 2006 (1079), e del libro di A. Mikhail, L’ombra di Dio. Selīm il sultano, il suo Impero ottomano e la creazione del mondo moderno, Einaudi, Torino 2021 (2020).
[37] Una prima bibliografia di riferimento, in grado di dirimere finalmente l’ingenuità interpretativa alla base di una netta separazione Occidente/Oriente riguardo non solo alla città di Istanbul, ma alla esperienza storica della Turchia, può comprendere, oltre ai già citati, E. J. Zürcher, Porta d’Oriente. Storia della Turchia dal Settecento a oggi e Marc David Baer, Gli ottomani. Khan, cesari e califfi, C. King, Mezzanotte a Istanbul. Dal crollo dell’impero alla nascita della Turchia moderna, trad. it. di Luigi Giacone, Einaudi, Torino 2015 (2014); il recentissimo Due letture fondamentali sono costituite da Fabio Grassi, Atatürk. Il fondatore della Turchia moderna, Salerno Editrice, Roma 2020 (2008) e K. Kreiser, Atatürk. Il padre della Turchia moderna, trad. it. di Lucia Bandini, Prefazione di Carlo Pallard, Città di Castello (PG) 2022 (2014).
[38] A tal proposito è dirimente l’ultimo romanzo di Pamuk, Le notti della peste, trad. it di Barbara La Rosa Salim, Einaudi, Torino 2022 (2021).
[39] Vedi il film-documento Istanbul e il Museo dell’innocenza di Pamuk.
[40] Pamuk, 2006, p. 6.




















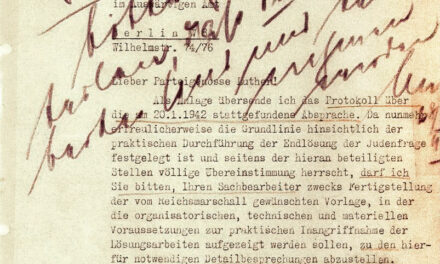



 L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore
L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino
Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio
Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa
Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa Storia passionale della guerra partigiana di Chiara Colombini
Storia passionale della guerra partigiana di Chiara Colombini Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice
Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli
Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli L’arresto degli arlecchini
L’arresto degli arlecchini