
Leggere la storia: gli albi illustrati per conoscere la Resistenza
Crediti: Foto scattata dalle autrici
Abstract
Il seguente articolo nasce dall’esperienza degli Istituti storici piemontesi nelle scuole di ogni ordine e grado e dal corso di formazione ed aggiornamento docenti Albi illustrati e storia del Novecento[1] che si è svolto tra novembre e febbraio in coordinamento tra ISTORETO, ISRN e ISRAT. A partire dal canovaccio del corso e dagli spunti emersi durante il suo svolgimento, questo testo intende proporre alcune attività operative a partire dagli albi illustrati, in particolare per l’insegnamento e l’apprendimento delle tematiche legate alla Resistenza e alla Libertazione.[2]
______________________
The following article stems from the experience of Piedmont’s historical institutes in schools of all levels and from the teacher training and refresher course Albi illustrati e storia del Novecento (Illustrated books and the history of the twentieth century) which took place between November and February in coordination between ISTORETO, ISRN and ISRAT. Starting from the outline of the course and the ideas that emerged during it, this text intends to propose some operational activities starting from illustrated books, in particular for teaching and learning about the themes linked to the Resistance and Liberation.
I libri illustrati, le narrazioni visive e verbali che contengono, le parole e le immagini che li costruiscono sono ponti, strumenti efficacissimi per promuovere l’incontro del bambino con la meraviglia, il pensiero e la ricerca di senso, attraverso una pratica viva e quotidiana della lettura e della scrittura. Una palestra insuperabile di crescita per l’intelligenza, la sensibilità, la creatività, la capacità di osservare, ascoltare, creare nessi, interpretare la realtà. Perché la capacità di leggere parole ed immagini è alla base della costruzione di quelle competenze elevate che sole portano alla formazione del pensiero critico: il miglior compagno di vita, studi ed avventure che la scuola possa offrire a un bambino.[3]
Introduzione
Le riflessioni sui bisogni formativi, che nel corso degli anni abbiamo raccolto da docenti di scuole di ogni ordine e grado, si intrecciano di frequente ai temi fondanti di una democrazia, quali la parità di genere, la cittadinanza, i diritti, la salvaguardia dell’ambiente, la memoria storica.
Per dare una possibile risposta alla complessità di una comunità educante che si interroga e ci interroga, ci siamo affidate agli albi illustrati, uno strumento didattico potentissimo che, per le sue caratteristiche, permette di coinvolgere e stimolare bambini e bambine, studenti e studentesse in modo proattivo e, al contempo, di cogliere le potenzialità di uno sviluppo narrativo multilivello, a seconda delle specificità della classe in cui si opera.
Data la peculiarità degli Istituti storici della Resistenza, il punto di partenza è stata una domanda: gli albi illustrati sono spendibili all’interno di un percorso di didattica della storia?
La risposta è stata ovviamente sì. L’albo illustrato infatti:
- è inclusivo, perché consente di lavorare su più livelli, coinvolgendo tutti gli studenti, anche quelli con bisogni educativi speciali;
- permette un lavoro multidisciplinare e interdisciplinare: può essere usato in diverse materie, osiamo dire quasi tutte, coinvolgendo nella progettazione didattica i consigli di classe e i gruppi docenti;
- molte volte fa riferimento a storie vere o verosimili, racconti personali e vicende storiche;
- è utilizzabile in scuole di ogni ordine e grado, in base alle forme stilistiche e narrative scelte. Alcuni albi illustrati, riferiti a eventi storici, sono adatti agli allievi della scuola primaria (classe IV e V).[4] Altri, invece, a lettori più grandi, per la complessità dei temi proposti o del linguaggio utilizzato.[5] Infine, ci sono albi adattabili alle diverse fasce di età: le osservazioni e le riflessioni possibili divengono via via sempre più profonde e complesse con il crescere dell’età.[6]
Così come qualsiasi libro, anche un albo illustrato, per essere efficace in classe, deve possedere alcune caratteristiche, soprattutto se lo si utilizza per affrontare un tema storico:
- ricerca storica accurata: prima di scegliere un albo è importante verificare se gli autori hanno utilizzato fonti affidabili, testimonianze, documenti per garantire che le informazioni siano corrette;
- contesto storico: alcuni albi forniscono un contesto storico essenziale per aiutare la comprensione della narrazione;
- personaggi credibili: devono essere coerenti con la storia e con la sua ambientazione (abiti, comportamenti …) e capaci di sviluppare empatia nel lettore;
- dialoghi realistici: i dialoghi devono essere coerenti con il linguaggio e lo stile di comunicazione del periodo della narrazione, evitando anacronismi linguistici che possono distrarre il lettore;
- trama coinvolgente: la trama deve coinvolgere e supportare il mantenimento dell’attenzione e dell’interesse;
- illustrazioni autentiche: gli albi più affascinanti utilizzano fotografie ed immagini grafiche per creare immagini realistiche, uniscono due linguaggi (testo e illustrazione) in maniera strettamente connessa, risultando più efficaci rispetto ai libri tradizionali o ai libri di testo. Ci sono autori che si occupano delle illustrazioni mentre altri scrivono i testi lavorando in gruppo, e ci sono gli “autori totali”, che si occupano di testo ed immagini;
- dettagli sensoriali: suoni, sapori e sensazioni tattili possono rendere più intensa la lettura;
- note e appendici: le note esplicative e le appendici forniscono informazioni aggiuntive per gli studenti che intendono approfondire la tematica dell’albo.
Metodologia
La proposta didattica qui di seguito illustrata si fonda sulla story-based methodology[7] e prevede la segmentazione del lavoro in tre fasi:
Fase 1: Prima della lettura
È il momento della scelta dell’albo, secondo il target a cui si riferisce (classe, materie, docenti coinvolti, tempo a disposizione per le attività), con attenzione alle caratteristiche tecniche dell’albo, e con la definizione chiara degli obiettivi da perseguire. Segue l’incontro con l’autore/autrice:[8] chi è, quali sono le motivazioni che lo/la hanno portato alla scrittura dell’albo, quali riconoscimenti ha eventualmente ottenuto per l’albo, quale è la sua motivazione rispetto alla decisione di scrivere per l’infanzia e l’adolescenza.[9] In caso non ci si trovi di fronte a un autore totale, cioè che realizza testo e immagini, si può organizzare un incontro con l’illustratore/illustratrice, analizzando quali sono la sua esperienza e formazione in campo artistico, la tecnica e le scelte stilistiche.
Prima di leggere la storia in classe si deve fare riferimento alla copertina, osservarla e rispondere a una serie di domande suggerite e possibili: quali immagini possono già annunciare il contenuto della storia? In che periodo potremmo essere? Ci sono indicazioni su storia e luogo di ambientazione che vengono date? Che cosa caratterizza i personaggi se sono in copertina?[10] La “lettura” della copertina permette ad allieve e allievi di “entrare nella storia” facendo delle ipotesi, che potranno poi essere confermate o smentite.
Poi si sfoglia l’albo: è richiesto di soffermarsi sui risguardi, di individuare i colori dominanti, rilevanti, simbolici, perché attraverso essi si riesce a determinare l’ambientazione in maniera precisa; e infine si esplicita quali sono i temi principali che emergono a una prima occhiata degli studenti. È la fase dell’attivazione e della condivisione delle conoscenze pregresse, in cui ognuno può portare il proprio bagaglio culturale e condividerlo in un processo di reciproco arricchimento.
Dopo questa panoramica, la prima attività didattica operativa si svolge senza ancora aver letto la storia. Una proposta efficace è l’intervista immaginaria al personaggio della copertina, oppure una ricerca sui simboli o sui colori scelti, per cominciare ad entrare nel racconto senza ancora esserci effettivamente. L’anticipazione favorisce il coinvolgimento nella lettura, veicola il sorgere di domande, la formulazione di ipotesi e l’attenzione al dettaglio. Consente di entrare nei panni dell’altro, provando ad immaginare i suoi pensieri, a prevedere le sue azioni, con potenziamento del pensiero critico e dell’empatia; è attivare i processi per la comprensione del testo che accompagneranno le fasi successive di lavoro.
Fase 2: Mentre si legge
La prima lettura deve svolgersi senza interruzioni, a bassa voce, individualmente, in modo che l’albo si connetta, in uno spazio di intimità e di riflessione personale, con il lettore/la lettrice sia per le parole sia per le immagini. Questa fase è funzionale per favorire il dialogo interiore di ogni studente con la storia, per immergerlo nella narrazione e creare un legame empatico con il protagonista o i protagonisti. Essa inoltre potenzia le funzioni esecutive, permette di soffermarsi su dettagli, sfumature, simboli, favorisce la rilettura e la comprensione del lessico e dei concetti, stimola l’immaginazione che si sente libera di dare una propria interpretazione della storia in modo creativo. Scrive Rita Longo, psicologa e psicoterapeuta:
Leggere fa bene. Migliora le competenze linguistiche, logiche e di comprensione del testo. Aumenta la conoscenza del mondo ma anche la conoscenza di sé e degli altri, mantiene attive le funzioni cognitive di memoria, attenzione e concentrazione, ragionamento e capacità critica. I libri insegnano a comprendere il mondo, ad approfondire, a riflettere, a pensare. […] Le storie permettono di accedere alla sfera dei sentimenti e delle emozioni dei protagonisti e in questo modo aumentano l’alfabetizzazione emotiva. Il vocabolario emotivo diventa più ampio e ciò migliora la definizione, l’espressione e la comprensione delle emozioni proprie e altrui. L’immedesimazione nei personaggi delle storie consente di sviluppare la capacità di sentire l’emotività dell’altro (cosa sta provando e come) ovvero l’empatia. Inoltre, la pagina sollecita la mente a immaginare, illustrare protagonisti, luoghi, vicende, storie attivando una creatività personale. […] i libri lasciano ai lettori la libertà di costruire le proprie immagini, con gradualità e con i propri tempi. Lasciarsi andare all’immaginazione, all’astrazione, ha il potere di sospendere l’esperienza del momento presente e trasportare il lettore in altri mondi, di distanziarsi dalla realtà del quotidiano, senza perdere il contatto con essa. Per questo motivo la lettura riduce le tensioni e lo stress.[11]
La seconda lettura deve essere ad alta voce, in forma collettiva, e riveste un valore pedagogico e sociale significativo, in quanto permette di condividere un’esperienza cogliendo dettagli trascurati alla prima lettura, dando al testo ed alle illustrazioni i ritmi e i colori proposti da voci diverse, ognuna con il proprio timbro e intonazione. Come ha affermato Daniel Pennac, «(La voce) delineando chiaramente i personaggi, sottolineando i temi, accentuando le sfumature, (fa) nel modo più chiaro possibile il suo lavoro di rivelatore fotografico»[12]
Inoltre può essere interrotta in vari momenti e può essere fonte di riflessione sui personaggi, sui dettagli dell’abbigliamento, dell’ambiente in cui si svolgono gli eventi narrati. È, quindi, un‘occasione per prestare attenzione anche a termini particolari che si trovano sfogliando le pagine (che non vengono usati per es. nella nostra lingua). Si analizzano le immagini per chiedersi cosa rappresentano e si compie una riflessione sulla Storia che ci aiuta a comprendere testo e contesto. Ci sono elementi della narrazione che possono raccontare eventi specifici, attraverso le illustrazioni si possono delineare elementi cupi.
La seconda attività operativa consiste nel rielaborare graficamente i personaggi e l’ambiente dell’albo letto, lasciando gli studenti liberi di rappresentarli seguendo la loro immaginazione e di scegliere con quali colori farlo. L’insegnante deve poi coordinare un successivo scambio delle rielaborazioni, chiedendo a ciascuno di motivare le scelte artistiche. Altri possibili interventi in classe riguardano la modifica del punto di vista, per considerare altre prospettive, aiutando così a potenziare la flessibilità cognitiva. Un’altra soluzione è la creazione di una nuova scena: arricchire l’albo con una tavola illustrata originale, che permette un’espansione della storia. Una terza opzione può essere la rielaborazione del testo: riscrivere la storia dal punto di vista di un altro protagonista sviluppa la capacità di entrare in rapporto empatico con l’altro da sé. O ancora si può anche proporre alla classe di cambiare il finale della storia: attraverso un’azione creativa si può pensare a altri finali, ancorandosi alla Storia si offre un ventaglio più ampio di possibilità (ciò che succede determina conseguenze, cambiando gli eventi cambiano le conseguenze). Infine si può suggerire agli studenti di scrivere la continuazione della storia: attraverso l’utilizzo di fonti storiche raccontare un’altra storia, legata a quella letta.
È inoltre possibile fare l’analisi delle figure dei protagonisti: la caratterizzazione – l’aspetto fisico rivela qualcosa sulla loro personalità o sul loro ruolo nella storia? La personalità- tratti caratteriali dei protagonisti: sono coraggiosi, timidi, curiosi, generosi…? Quale ruolo hanno nella storia: funzione narrativa – Sono eroi, antagonisti, co-protagonisti…? Quali temi principali emergono attraverso i protagonisti? (es. coraggio, amicizia, resilienza…)
Possiamo invitare studentesse e studenti a prendere in esame l’evoluzione dei fatti (c’è una trasformazione, un percorso di eventi?) e le relazioni tra i personaggi (quali sono le interazioni tra i protagonisti e gli altri personaggi? Quali dinamiche relazionali si possono osservare (amicizia, conflitto, aiuto…)?
Infine, è importante approfondire il contesto culturale e storico: ambientazione – Come sono inseriti i protagonisti nel contesto storico-culturale della narrazione? Quali aspetti del contesto influenzano comportamento e scelte? Quali valori muovono le azioni dei protagonisti? Sono coerenti con la narrazione? Vi sono elementi simbolici nelle illustrazioni legati ai protagonisti o alla vicenda, che servono a far comprendere meglio gli accadimenti o il personaggio/i personaggi? Qual è l’impatto emotivo? Si riesce a entrare in rapporto empatico con il protagonista? Quale messaggio trasmette?
Fase 3: Dopo la lettura
In questa fase va realizzato un affondo nella cornice storica e nel contesto geografico: specificare la periodizzazione situando correttamente il movimento della Resistenza, in questo caso, per esplicitare le motivazioni e l’evoluzione del conflitto e come nacquero le forme di ribellione e Resistenza. Risulta importante evidenziare le peculiarità territoriali della Resistenza in Italia: le montagne, le colline, le città, mostrando come il paesaggio abbia influenzato le dinamiche della lotta e condizionato gli eventi stessi e nello stesso tempo analizzare la componente sociale coinvolta. Gli uomini e le donne, partigiani e civili, i bambini; posare l’attenzione sulla cronologia dei fatti e sul cambiamento di un movimento spontaneo in uno strutturato, dove il ruolo della figura femminile ha rilievo, seppur sottovalutato se non celato. Infine analizzare l’impatto della lotta partigiana nella nascita della Repubblica e nella stesura della Carta costituzionale, discutendo insieme sul merito che la memoria della Resistenza ha per la costruzione di una società democratica.
Riteniamo a questo punto importante realizzare un ponte tra passato e presente: guidare gli studenti ad acquisire consapevolezza che la Resistenza non è stato un evento storico isolato, ma un’esperienza che dialoga tuttora con il presente, in quanto la memoria della Resistenza non è un semplice ricordo, ma uno strumento per comprendere e poter affrontare con responsabilità le sfide attuali. Come attualizzare i temi che scaturiscono dallo studio della Resistenza?
Si possono aprire varie tematiche di confronto:
- lotta alla discriminazione e alla oppressione, riflettendo insieme sulle attuali forme di discriminazione (razzismi, esclusione sociale) per promuovere valori di solidarietà e rispetto
- lotta per la libertà e per una società democratica: si possono approfondire storie che parlano di impegno civico e di battaglie per i diritti umani portate avanti attraverso il perseguimento dei propri ideali
- lotta a stereotipi e pregiudizi che hanno caratterizzato la II guerra mondiale e che oggi permeano la società, attraverso il riconoscimento ed il contrasto di pensieri rivolti alla costruzione del diverso e dell’esclusione
- un ambiente sociale dove ognuno può esprimere la propria opinione ascoltando quella altrui in un contesto di empatia e di rispetto reciproco per la risoluzione dei conflitti in maniera pacifica.
A questo punto si può realizzare la terza attività operativa (TAKE ACTION). La proposta è organizzare un dibattito etico.[13] legato al tema trattato nell’albo ed alla memoria storica, utilizzando le immagini dell’albo e le rielaborazioni artistiche degli studenti quali punto di partenza delle discussioni, per lo sviluppo del pensiero critico degli studenti, in modo che siano guidati alla riflessione su questioni etiche complesse, essendo in grado di analizzare le diverse prospettive. Questo è utile alla promozione del dialogo tra pari in un ambiente connotato dal rispetto e dall’ascolto; alla comprensione profonda dei valori di cittadinanza democratica e del ruolo della memoria storica per la costruzione di una società equa e per discutere, in un continuo rimando di passato e presente, dei temi affrontati, in modo da collegare eventi passati ed attuali per un apprendimento significativo.
Tre albi per parlare di Resistenza
Per affrontare questo tema a tutti i livelli scolastici, abbiamo individuato, tra i tanti disponibili, tre testi sembrano, dopo attenta analisi, particolarmente adatti al percorso immaginato:
- per la scuola primaria l’albo scelto è Di che colore è la libertà, scritto da Roberto Piumini e illustrato da Giovanni Manna per Mondadori (2021);
- per la scuola secondaria di primo grado la scelta è ricaduta su Alza la testa. La resistenza narrata ai bambini di Guia Risari, illustrato da Paolo d’Altan per Gribaudo (2022);
- per la scuola secondaria di secondo grado, è stato individuato il testo dell’autrice unica Sonia Maria Luce Possentini Nome di battaglia Nero, edito da Rrose Selavy (2021).
I tre libri permettono di offrire una panoramica di punti di vista, stili grafici e narrativi, case editrici, contribuendo, nella loro diversità, ad arricchire il bagaglio degli insegnanti. Le caratteristiche specifiche di ogni albo sono anticipate nell’introduzione alla scheda di lavoro proposta e allegata per tutti e tre i testi scelti. Nel caso di Nome di battaglia Nero siamo di fronte ad un’autrice totale, che ha un legame personale con la storia che ricostruisce e racconta. Nelle illustrazioni sono usati in modo esplicito documenti e la vicenda è reale. Il testo di Piumini- Manna, Di che colore è la libertà, è un albo realizzato con un realismo stilizzato. Le proporzioni dei personaggi, i colori e l’ambiente sono realistici, ma i visi dei personaggi sono stilizzati e semplificati. A livello di tecnica, l’autore ha lavorato con i disegni a matita e colore con acquerello, tratto distintivo di quasi tutti i suoi lavori[14]. Lo stile delle illustrazioni e della narrazione è particolarmente adatto ai più piccoli. Alza la testa. La resistenza narrata ai bambini di Guia Risari Paolo d’Altan è un albo di medio formato, in cui è esposta la parabola del fascismo in Italia attraverso la narrazione in terza persona della biografia di Luce, nata il 30 ottobre 1922 in una famiglia antifascista e staffetta. La narrazione si conclude con la sfilata del 25 aprile 1945. Alla fine della storia è riportata un’appendice storica che riprende le date degli avvenimenti più significativi. Rispetto ad altri albi sul tema della resistenza, questo testo insiste maggiormente su una narrazione descrittiva dei fatti storici, con un coinvolgimento emotivo lieve rispetto alla vicenda personale della protagonista.
Come sono organizzate le schede
Come accennato, le schede sono strumenti operativi immediatamente applicabili e utilizzabili in classe per far svolgere a studentesse e studenti, dopo una breve introduzione storica, un laboratorio in cui renderli protagonisti attivi, da intendersi come primo suggerimento di lavoro, rispetto al quale i/le docenti sono invitati/e a fare variazioni, integrazioni, modifiche. Nella prima parte si fornisce un’immagine della copertina e una sinossi, che può essere ripresa anche da quella proposta dalla casa editrice, e si forniscono i dati editoriali del testo. Le parti successive della scheda ricalcano il modello descritto delle tre fasi (prima, durante e dopo la lettura dell’albo), con una ricca proposta di esercitazioni.
Piste di lavoro
Invitiamo docenti di ogni ordine e grado ad utilizzare gli albi illustrati come strumento didattico per l’insegnamento della storia, perché attivano l’interesse e la partecipazione. Alleghiamo, quindi, alcune proposte, ritenendo che possano offrire spunti operativi in vista dell’imminente 80° Anniversario della Liberazione:
- SCHEDA_Di che colore è la libertà
- SCHEDA_Nome di battaglia Nero
- SCHEDA_Su la testa
- ULTERIORI DIRETTRICI DI LAVORO
Bibliografia
- L. Ambrosi, M. Angelini, A. Miccichè (a cura di), A scuola di cittadinanza. Educazione civica e didattica della storia, Editpress, Firenze 2024
- Associazione culturale Hamelin (a cura di), Ad occhi aperti. Leggere l’albo illustrato. nuova edizione, Donzelli, Roma 2023
- A. Capetti, A scuola con gli albi. Insegnare con la bellezza delle parole e delle immagini, Topipittori, Milano 2018
- A. Capetti, S. Minciotti, In classe con gli albi illustrati. Percorsi didattici ed attività per la scuola primaria, Sanoma, Torino 2024
- A. Chambers, Siamo quello che leggiamo. Crescere tra lettura e letteratura, Equilibri Editrice, Modena 2020
- A. Faeti, Guardare le figure. Gli illustratori italiani dei libri per l’infanzia, Donzelli, Roma 1972
- E. Garroni, Tra le emozioni con gli albi illustrati. Percorsi didattici per educare alle relazioni e alla conoscenza di sé, Sanoma, Torino 2024
- E. Garroni, Nella Storia con gli albi illustrati. Laboratori di didattica attiva per studiare il Novecento, Sanoma, Torino 2023
- V. Ilari, Non chiamateli libri! Sul filo degli albi illustrati, Gruppo Albatros Il filo, Roma 2022
- F. Lorenzoni, Educare controvento. Storie di maestre e maestri ribelli, Sellerio, Palermo 2023
- R. V. Merletti, B. Tognolini, Leggimi forte. Accompagnare i bambini nel grande universo della lettura, Salani, Milano 2015
- A. Merlin, L’albo illustrato: alla scoperta del mondo attraverso la lettura, Università degli studi Padova, 2021-22 https://thesis.unipd.it/retrieve/bebc16f6-34a6-427b-94df-2923e85284fa/Merlin_Angela.pdf
- M. Terrusi, Meraviglie mute. Silent book e letteratura per l’infanzia, Carocci, Roma 2017
- M. Terrusi, Albi illustrati. Leggere, guardare, nominare il mondo nei libri per l’infanzia, Carocci, Roma 2012
Note:
[1] Potete prendere visione della registrazione degli interventi sul canale YouTube di Istoreto https://www.youtube.com/playlist?list=PLdIB_a3-xogyc08HKmUNsS1jOh5ZihAen
[2] La rivista si è già occupata della relazione tra albi illustrati e didattica della storia nell’articolo di S. Lotti, Equilibri di storie. Albi illustrati per il calendario civile, in “Novecento.org”, n. 21, giugno 2024. DOI: 10.52056/9791254696965/16.
[3] A. Capetti, A scuola con gli albi. Insegnare con la bellezza delle parole e delle immagini, Topipittori 2018. Risguardo di copertina. Antonella Capetti è docente di scuola primaria, blogger, appassionata di lettura da sempre.
[4] È il caso, ad esempio, del libro Di che colore è la libertà, scritto da Roberto Piumini, illustrato da Giovanni Manna, Mondadori, 2021.
[5] Come ad esempio il libro Partigiane di Stefano Catone, Serena D’Angelo, Amalia Perfetti, edizioni People, 2023; oppure Nome di battaglia Nero di Sonia Maria Luce Possentini, Rrose Sélavy, 2021.
[6] È il caso di ’45, il silent book di Maurizio A. C. Quarello, edito da Orecchio Acerbo, 2020. A detta dello stesso autore, il libro è stato composto per un pubblico adulto, ma – aggiungiamo noi – si presta benissimo per affrontare il tema della Resistenza anche nella scuola primaria.
[7] La story-based methodology è una modalità di insegnamento che utilizza la narrazione e i racconti per aiutare gli studenti a comprendere e ricordare concetti, idee e informazioni. A differenza dei metodi di insegnamento tradizionali, l’apprendimento basato sulle storie utilizza storie e personaggi coinvolgenti per aiutare gli studenti a entrare in contatto con l’argomento e a conservare le informazioni nel tempo. Per un approfondimento si rimanda all’articolo online di Cristina Ferreira Pinto e Helena Soares, Using children’s literature in elt a story-based approach.
[8] Per contattare autori e illustratori è possibile fare riferimento alle case editrici, oppure cercare direttamente informazioni sulle pagine web e sui social media personali. La facilità di contatto dipende dalle disponibilità di tempo di ciascuno.
[9] Ad esempio, l’autore dell’albo Sassolino è Markus Marcinkevicius, testimone di II generazione della Shoah, che attualmente svolge la professione di medico ma scrive libri per bambini in quanto si dichiara convinto che la letteratura e la poesia possano cambiare la visione del mondo dei lettori.
[10] In effetti ci sono albi dove chiaramente c’è il riferimento al periodo storico, all’ambiente: sono indicazioni funzionali alla decodifica dell’albo e della storia che vuole raccontare.
[11] https://www.dors.it/2024/01/la-lettura-come-fonte-di-benessere-le-ricerche-recenti/#
[12] D. Pennac, Come un romanzo, Feltrinelli, Milano 1993, pag. 96
[13] Per un approfondimento si veda G. Giovannetti, Educazione civica, storia e debate: alcune considerazioni, in “Novecento.org”, n. 19, giugno 2023. DOI: 10.52056/9791254693872/10
[14] Le informazioni tecniche qui riportate sono state elaborate da Martina Cerrato, illustratrice e graphic designer https://www.martinacerrato.it/




















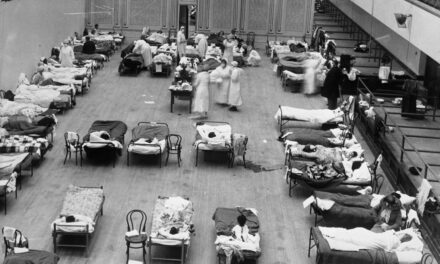
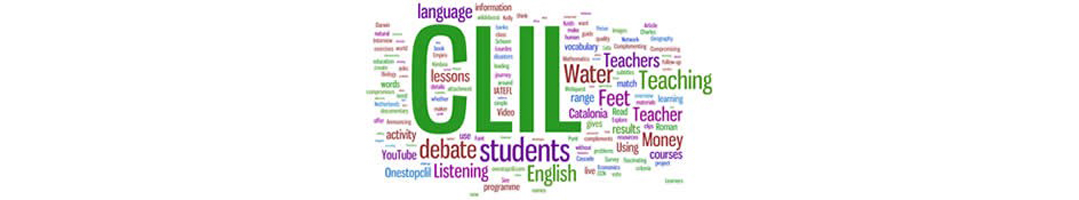


 Scarpe rotte eppur bisogna andar. Una storia della Resistenza in 30 oggetti, a cura di P. E. Boccalatte e M. Carrattieri
Scarpe rotte eppur bisogna andar. Una storia della Resistenza in 30 oggetti, a cura di P. E. Boccalatte e M. Carrattieri L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore
L’affaire Matteotti. Storia di un delitto, di Fabio Fiore Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino
Monte Sole Marzabotto. Il processo, la storia, i documenti, di Marco De Paolis e Paolo Pezzino Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio
Io vi accuso. Giacomo Matteotti e noi, di Concetto Vecchio Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa
Insegnare Storia nella Scuola Secondaria, a cura di F. Monducci e A. Portincasa Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice
Abbiamo strappato la pianta; bisogna strappare la radice Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli
Partigiani presso gli stabilimenti Ercole Marelli L’arresto degli arlecchini
L’arresto degli arlecchini